

Manoscritti del Mar Morto: Manoscritti su pergamena e papiro redatti in diverse lingue: ebraica, aramaica, greca, siriaca, araba (dal frammento in Levitico in antico alfabeto fenicio del V secolo a.C. ai frammenti arabi di Khirbet Mird del X secolo d.C.), trovati dal 1947 in poi all’interno di anfore nascoste in un serie di numerose grotte della zona del Mar Morto (Qumran, Murabaat, ‘En-gedi, Masada, Khirbet Mird). Il numero di frammenti è incalcolabile; essi possono dividersi in testi biblici ed extrabiblici. Fra i testi biblici (canonici, deuterocanonici ed apocrifi) sono particolarmente importanti: un testo completo di Isaia in ottime condizioni (II secolo a.C.); frammenti in ebraico di testi deuterocanonici ed apocrifi, conosciuti prima solo in versioni in altre lingue (Ecclesiastico, Testamento dei dodici Patriarchi, Libro dei giubilei); un apocrifo di Genesi in aramaico, completamente nuovo. L’importanza dei manoscritti biblici è dovuta al fatto che essi contengono testi anteriori di circa mille anni al più antico testo masoretico conosciuto (codice di Aleppo del X secolo d.C.). Fra i testi extrabiblici vi sono: · commenti a testi biblici (Abacuc, Salmi, Michea, Nahum) in cui versetti della Bibbia sono adattati ad avvenimenti storici dell’epoca degli scrittori; · testi redatti dalla cosiddetta setta essena di Qumran, comprendenti: Regola della comunità, Inni di ringraziamento, Manuale della guerra; · due rotoli di rame con una lista di tesori, molto probabilmente quelli nascosti nei sotterranei (Sancta Sanctorum) del Tempio di Gerusalemme. I primi testi ritrovati sono esposti oggi nel santuario del libro, nel museo Israele di Gerusalemme. Tra i frammenti rinvenuti a Murabba’at e Masada, oltre ai testi biblici, importanti sono le lettere di Simone bar-Kokeba, eroe della ribellione contro l’imperatore Adriano (132-135 d.C.), conclusasi con la strage suicida di Masada, nonché vari contratti.
Manoscritto Carmick: Conservato presso il Museo della Gran Loggia di Pennsylvania, è considerato il più antico documento massonico illustrato da un Quadro di Loggia (v.). È costituito da 24 pagine, e risale al XV secolo. Il suo nome deriva da quello di una nota famiglia della Pennsylvania, uno dei cui membri lo avrebbe trascritto. Il testo inizia con versi tratti dall’Ecclesiastico:"Avvicinatevi a me, voi che siete incolti e sostate nella casa dell’istruzione … l’Onnipotente Dio del cielo, cui la saggezza del Suo Figlio glorioso attraverso la Grazia e la bontà dello Spirito santo, che sono le tre persone ed uno solo, sia con noi nel nostro inizio, e ci dia qui la Grazia, nella speranza che noi possiamo venire al Suo Regno Eterno che non avrà mai fine. Amen. Buoni Fratelli e compagni, ora è nostro proposito dirvi in qual modo l’Arte, la Massoneria, ebbe inizio … ".
Mantra: Nella religione indiana, il termine definisce la formula magica consistente in un monosillabo od in una giaculatoria. È recitata dal discepolo durante la meditazione sul mandala (v.), di cui il M. è l’espressione sul piano del suono. Il fatto che il M. consista spesso in un suono od in una serie di suoni, privi di significato logico, sta ad indicare che, attraverso la sua recitazione meditativa, si deve arrivare ad intuire l’essenza del suono stesso, allorché privo di articolazioni è ancora in identità con la Parola creatrice o Verbo divino. Quindi sul piano articolato il M. è l’espressione di una verità sovrasensibile. Secondo la tradizione filosofica e religiosa orientale, sono M. le pratiche di perfezionamento adottate dallo Yoga (v.), consistenti in modulazioni armoniche o parole rituali usate per sollecitare il Kundalini (v.), la forza psichica avente sede in fondo alla colonna vertebrale. Vengono anche definiti M. gli inni del Veda (v.), in quanto considerati alla stregua di formule magiche sulle quali meditare.
Manu: Termine sanscrito dal significato di uomo, un appellativo attribuito dalla mitologia hindu a quattordici mitici progenitori del genere umano e sovrani della terra, ognuno dei quali regna per un periodo di 4.320.000 anni. Il primo fu Svayam-bhuva, nato da Brahma (v.-), il settimo Vaiva-svata (nato dal sole), al quale è connesso il mito del diluvio, da cui si salvò ad opera di un pesce, incarnazione di Visnù. Sotto il nome di Manavadharmasastra (Codice delle leggi di M.), ad indicarne la mitica antichità ed a sottolinearne l’autorità, è conosciuta la più nota raccolta di leggi del mondo hindu, che è stata redatta durante i secoli appena precedenti, o seguenti l’era volgare. Tale Codice, in dodici libri, tratta di diritto civile e penale, fissa le divisioni castali con i relativi doveri sociali e religiosi, dà norme per le donne, e contiene infine un catalogo di peccati e relative penitenze.
Manvantara: Unità di misura del tempo indiano di Brahma, avente la durata totale di 306.720.000 anni, equivalente a 71 Maha-yuga, ognuno dei quali ha la durata di 4.320.000 anni. Quattordici M. costituiscono un Kalpa (v.) di 4.294.080.000 anni del nostro calendario definito come "un giorno ed una notte si Brahma".
 Maometto: Nome del
fondatore dell'islamismo o musulmanesimo (La Mecca 571 ca.- Medina 632), dall'arabo Muhammad,
il lodato. Pur mancando dati incontrovertibili su questa figura di profeta armato e di
abilissimo uomo politico, secondo le notizie fornite dalla tradizione ed accettate dagli
studiosi, era figlio di 'Abd Allah e di Amina, ed apparteneva al clan dei Banu
Hasim della tribù di Qurais. Premortogli il madre e rimasto orfano anche della
madre a pochi anni d'età, M. venne accolto dallo zio Abu Talib, un agiato
commerciante che lo portò con sé in alcuni viaggi. Si sarebbe sposato intorno ai
venticinque anni con Khadiga, una donna ricca, vedova di ben due matrimoni e madre
di numerosi figli, che lo aveva assunto per aiutarla nella sua attività commerciale.
Secondo la tradizione M. era di bell'aspetto, di animo nobile e di intelligenza acuta ed
equilibrata. Aveva raggiunto l'agiatezza e, mentre continuava a fare il mercante, fu
all'improvviso assalito da un profondo disagio interiore, da un'intensa crisi spirituale,
sulle cui caratteristiche le interpretazioni degli esegeti si sono sbizzarrite
ricercandone le cause nella situazione politica ed economica del paese, nelle tensioni
ideali e religiose che percorrevano quei territori, nei viaggi compiuti, nella situazione
familiare e nelle particolarità della sua psicologia. Comunque a quarant'anni M. rispose
ad una misteriosa chianata mistica ed ascetica, ed incominciò ad illustrare le sue
visioni a quanti gli erano vicini. Il senso delle rivelazioni recepite, sempre più
precise e che furono subito credute da Khadiga, dal cugino Alì, dal liberto Zaid
ibn Haritha, dal ricco mercante Abu Bakr e da pochi altri, pur non risultando
eccessivamente insolito né troppo innovatore rispetto alle credenze allora diffuse alla
Mecca, tendeva a proclamare l'unicità di Dio, creatore dell'universo, onnipotente,
onnisciente, clemente e misericordioso, l'esigenza di rassegnarsi alla volontà divina e
di abbandonare il culto degli idoli, l'attesa del giudizio universale, del paradiso per i
buoni e dell'inferno per i reprobi. Inoltre la predicazione di M. raccomandava l'onestà,
la carità, la compassione per i deboli, la preghiera ed il pieno abbandono d'ogni
creatura nelle mani del Creatore, o islam. Si racconta poi che una notte, intorno
al 610, la voce imponesse al profeta: "Recita: nel nome del Signore che ha
creato", e che in quel preciso istante il Corano (v.) vedesse la sua
nascita. La nuova si configurò presto come anticonformistica, liberatrice e pericolosa
per gli strati dirigenti della Mecca, anche se M. non avesse alcunché dell'estremista e
vari autorevoli elementi gli si avvicinassero. Nel 619 l'improvvisa morte di Abu Talib e
di Khadiga (il profeta si sarebbe poi risposato con diverse mogli avendone numerosi figli)
originarono grande insicurezza intorno al neo profeta, per cui M. ed i suoi famigliari e
seguaci decisero di trasferirsi alla spicciolata in un ambiente più ospitale. Il 25
settembre 622 M., accompagnato dal solo Abu Bakr, emigrò a Medina, un'oasi a circa 350
km. a nord-ovest della Mecca. Qui gli abitanti erano da lungo tempo divisi in fazioni
accanitamente ostili tra loro e, avendo già conosciuta la personalità di M., l'accolsero
favorevolmente, accettandone e sollecitandone la funzione di arbitro delle loro contese.
M. per due anni si impegnò nella riorganizzazione della comunità medinese, entro la
quale occorreva anche stabilire la convivenza con un forte nucleo di ebrei. Resosi poi
conto delle difficoltà che perduravano nei suoi nel vivere a Medina, si decise a tentare
la riconquista della Mecca. Fu un'operazione condotta con grande prudenza ed abilità, con
momenti culminanti rappresentati dalla battaglia di Badr (624) in cui trecento maomettani
sconfissero mille meccani, il pellegrinaggio alla Mecca (629) che permise a M. di
riconciliarsi con gli abitanti, e l'occupazione trionfale della Mecca (gennaio 630). Negli
anni successivi l'ascesa di M. proseguì attraverso sottili trattative diplomatiche con le
tribù dell'interno, vere e proprie spedizioni militari, razzie e saccheggi. Interessante
è la spedizione a settentrione iniziata dieci mesi dopo la conquista della Mecca,
un'impresa dall'esito militarmente incerto, che contribuì comunque ad aumentare la fama
del signore della Medina. L'autorità di M., anche attraverso partigiani, agenti ed
alleati, si estese su gran parte della penisola arabica, dal mar Rosso al golfo Arabico e
fino allo Yemen, comprendendo vari regni feudali sotto controllo bizantino e persiano. Con
il prestigio politico si diffusero ovunque le idee e le norme rituali elaborate da M., in
modo che il grande stato musulmano si venne formando come un complesso tipico di
compattezza ideologica, fede profonda ed unità statuale. M. raggiunse il culmine del
successo con il cosiddetto pellegrinaggio d'addio alla Mecca, quando fu accolto da una
folla immensa, episodio che precedette di soli tre mesi la morte sopraggiunta a Medina per
malattia. Certo non privo dei comuni difetti umani (ma lo stesso M. affermò d'essere un
uomo come ogni altro oggetto però della miracolosa rivelazione del corano), egli non fu
soltanto assertore del monoteismo intransigente, ma provato dalla povertà e dalle
umiliazioni seppe trovare la forza per indicare al mondo una morale elevata, per sollevare
i miseri contro i superbi, per nobilitare la stessa guerra come un atto eroico compiuto
per la causa di Allah, e soprattutto per imprimere una svolta radicale al corso
della storia dell'umanità.
Maometto: Nome del
fondatore dell'islamismo o musulmanesimo (La Mecca 571 ca.- Medina 632), dall'arabo Muhammad,
il lodato. Pur mancando dati incontrovertibili su questa figura di profeta armato e di
abilissimo uomo politico, secondo le notizie fornite dalla tradizione ed accettate dagli
studiosi, era figlio di 'Abd Allah e di Amina, ed apparteneva al clan dei Banu
Hasim della tribù di Qurais. Premortogli il madre e rimasto orfano anche della
madre a pochi anni d'età, M. venne accolto dallo zio Abu Talib, un agiato
commerciante che lo portò con sé in alcuni viaggi. Si sarebbe sposato intorno ai
venticinque anni con Khadiga, una donna ricca, vedova di ben due matrimoni e madre
di numerosi figli, che lo aveva assunto per aiutarla nella sua attività commerciale.
Secondo la tradizione M. era di bell'aspetto, di animo nobile e di intelligenza acuta ed
equilibrata. Aveva raggiunto l'agiatezza e, mentre continuava a fare il mercante, fu
all'improvviso assalito da un profondo disagio interiore, da un'intensa crisi spirituale,
sulle cui caratteristiche le interpretazioni degli esegeti si sono sbizzarrite
ricercandone le cause nella situazione politica ed economica del paese, nelle tensioni
ideali e religiose che percorrevano quei territori, nei viaggi compiuti, nella situazione
familiare e nelle particolarità della sua psicologia. Comunque a quarant'anni M. rispose
ad una misteriosa chianata mistica ed ascetica, ed incominciò ad illustrare le sue
visioni a quanti gli erano vicini. Il senso delle rivelazioni recepite, sempre più
precise e che furono subito credute da Khadiga, dal cugino Alì, dal liberto Zaid
ibn Haritha, dal ricco mercante Abu Bakr e da pochi altri, pur non risultando
eccessivamente insolito né troppo innovatore rispetto alle credenze allora diffuse alla
Mecca, tendeva a proclamare l'unicità di Dio, creatore dell'universo, onnipotente,
onnisciente, clemente e misericordioso, l'esigenza di rassegnarsi alla volontà divina e
di abbandonare il culto degli idoli, l'attesa del giudizio universale, del paradiso per i
buoni e dell'inferno per i reprobi. Inoltre la predicazione di M. raccomandava l'onestà,
la carità, la compassione per i deboli, la preghiera ed il pieno abbandono d'ogni
creatura nelle mani del Creatore, o islam. Si racconta poi che una notte, intorno
al 610, la voce imponesse al profeta: "Recita: nel nome del Signore che ha
creato", e che in quel preciso istante il Corano (v.) vedesse la sua
nascita. La nuova si configurò presto come anticonformistica, liberatrice e pericolosa
per gli strati dirigenti della Mecca, anche se M. non avesse alcunché dell'estremista e
vari autorevoli elementi gli si avvicinassero. Nel 619 l'improvvisa morte di Abu Talib e
di Khadiga (il profeta si sarebbe poi risposato con diverse mogli avendone numerosi figli)
originarono grande insicurezza intorno al neo profeta, per cui M. ed i suoi famigliari e
seguaci decisero di trasferirsi alla spicciolata in un ambiente più ospitale. Il 25
settembre 622 M., accompagnato dal solo Abu Bakr, emigrò a Medina, un'oasi a circa 350
km. a nord-ovest della Mecca. Qui gli abitanti erano da lungo tempo divisi in fazioni
accanitamente ostili tra loro e, avendo già conosciuta la personalità di M., l'accolsero
favorevolmente, accettandone e sollecitandone la funzione di arbitro delle loro contese.
M. per due anni si impegnò nella riorganizzazione della comunità medinese, entro la
quale occorreva anche stabilire la convivenza con un forte nucleo di ebrei. Resosi poi
conto delle difficoltà che perduravano nei suoi nel vivere a Medina, si decise a tentare
la riconquista della Mecca. Fu un'operazione condotta con grande prudenza ed abilità, con
momenti culminanti rappresentati dalla battaglia di Badr (624) in cui trecento maomettani
sconfissero mille meccani, il pellegrinaggio alla Mecca (629) che permise a M. di
riconciliarsi con gli abitanti, e l'occupazione trionfale della Mecca (gennaio 630). Negli
anni successivi l'ascesa di M. proseguì attraverso sottili trattative diplomatiche con le
tribù dell'interno, vere e proprie spedizioni militari, razzie e saccheggi. Interessante
è la spedizione a settentrione iniziata dieci mesi dopo la conquista della Mecca,
un'impresa dall'esito militarmente incerto, che contribuì comunque ad aumentare la fama
del signore della Medina. L'autorità di M., anche attraverso partigiani, agenti ed
alleati, si estese su gran parte della penisola arabica, dal mar Rosso al golfo Arabico e
fino allo Yemen, comprendendo vari regni feudali sotto controllo bizantino e persiano. Con
il prestigio politico si diffusero ovunque le idee e le norme rituali elaborate da M., in
modo che il grande stato musulmano si venne formando come un complesso tipico di
compattezza ideologica, fede profonda ed unità statuale. M. raggiunse il culmine del
successo con il cosiddetto pellegrinaggio d'addio alla Mecca, quando fu accolto da una
folla immensa, episodio che precedette di soli tre mesi la morte sopraggiunta a Medina per
malattia. Certo non privo dei comuni difetti umani (ma lo stesso M. affermò d'essere un
uomo come ogni altro oggetto però della miracolosa rivelazione del corano), egli non fu
soltanto assertore del monoteismo intransigente, ma provato dalla povertà e dalle
umiliazioni seppe trovare la forza per indicare al mondo una morale elevata, per sollevare
i miseri contro i superbi, per nobilitare la stessa guerra come un atto eroico compiuto
per la causa di Allah, e soprattutto per imprimere una svolta radicale al corso
della storia dell'umanità.
Marabutto: Termine derivato dall’arabo murabit, persona acquartierata, che sta nel ribut. Definisce l’asceta santone cui vengono attribuiti poteri miracolosi. Attraverso una vita ascetica (zawiya), condotta con lo scrupoloso rispetto delle norme del Corano (v.), i M. cercano di raggiungere l’unione estatica (ittihad) con Allah. La virtù benefica (baraka) dei M. si estenderebbe anche ai loro oggetti ed ai discendenti. Diedero anche origine alla dinastia degli Almoravidi, che regnò sul Marocco e sulla Spagna meridionale dalla prima metà dell’XI secolo al 1146. Il marabuttismo si sviluppò poi nel Marocco a partire dal XIV secolo, diffondendosi in seguito nell’Africa settentrionale fino alla Marmarica. In Europa vennero detti M. anche i mausolei dove gli asceti erano sepolti. Chiamati qubba dagli arabi, consistevano di cubi bianchi con cupola emisferica ed intonacati all’esterno, e sono tuttora mete di frequenti pellegrinaggi.
Marae: Termine indicante il tipico luogo di culto dell’area polinesiana, costituito da una piattaforma quadrata o rettangolare chiusa da un muro a secco, oppure da un recinto di grosse pietre allineate disposte verticalmente. All’interno della M. sorgono di solito un tempio od una piramide a gradoni. Vi vengono inoltre collocate statue ed oggetti di culto, e talvolta vi sono sepolti personaggi illustri. Analoga alla M. è la malae delle Samoa e della Nuova Zelanda, che ha piuttosto funzione di centro politico e sociale, in quanto luogo di riunione della tribù.
Maroniti: Gruppo etnico-religioso cristiano, unito alla Chiesa romana, le cui origini risalgono ad una comunità costituitasi nel monastero di San Marone sul fiume Oronte, presso Apamea (Qal’at al-Mudiq, in Siria). Le relazioni dei M. col monotelismo (v.) sono attualmente poste in dubbio. Già nel lontano 685 i M. avevano eletto un loro patriarca, detto di Antiochia, Giovanni Marone (m. 707), Staccatisi da Bisanzio, vennero riconosciuti come comunità cristiana autonoma dal califfo Marwan II (744-750). Tuttavia, verso la fine del IX secolo, i M., per sottrarsi dalle persecuzioni musulmane e dei monofisiti eutachiani anticalcedoniani, si trasferirono nel Libano, dove vissero in luoghi di difficile accesso, agli ordini di capi civili (muqaddamin) con carattere ereditario. Appoggiarono le imprese dei Crociati dell’XI-XII secolo, si professarono fedeli alla Chiesa di Roma, diventando la roccaforte del cattolicesimo in Oriente. In seguito, e fino ad oggi, i M. determinarono una larga autonomia di fatto del Libano. La stessa Costituzione libanese prevede un presidente della Repubblica M. ed un presidente del consiglio musulmano. Attualmente i M. ammontano a circa 850.000, dei quali poco meno della metà residenti altrove, come in America, Australia, Francia, ecc. Un’importante comunità M. (ca. 160.000) risiede negli Stati Uniti. Il rito M. rappresenta un ramo del rito siriaco occidentale (eucarestia sotto una sola specie, celibato non obbligatorio per il clero inferiore): La loro lingua liturgica è il siriaco (aramaico), mentre la lingua usata è l’arabo. La Chiesa M. è l’unica completamente cattolica fra le Chiese cristiane orientali.
Marrano: Termine forse derivato dall’arabo mahran, cosa proibita, che rappresenta un’ingiuria con la quale era denominato l’Israelita che, nella Spagna del XIV-XVI secolo, per evitare le persecuzioni, ufficialmente si convertiva al cristianesimo, rimanendo nell’intimo legato alla sua religione primitiva. Così erano pure definiti i musulmani neo battezzati, ma il fenomeno ebbe maggiore rilevanza tra gli Ebrei. Con questi nuovi cristiani si ebbe così un fenomeno rilevante di cripto-giudaismo, in quanto i M. non credevano ai dogmi della Chiesa, mangiavano solo carne kasher (v.), si sposavano tra loro, frequentavano di nascosto la sinagoga, e trasmettevano ai figli la loro miscredenza. Praticamente si formò un nuovo culto misto di pratiche ebraiche e cristiane. I M., che furono numerosi ed assunsero posizioni sociali ragguardevoli, specie nella finanza e nel commercio (vari storici hanno ipotizzato che anche Cristoforo Colombo fosse stato un M.), andarono quasi sparendo intorno al ‘600, con la graduale concessione della libertà di culto. Tuttavia in Portogallo, nel 1917, furono individuate colonie di M. che praticavano la loro religione clandestina, ed altre furono poi scoperte anche in Spagna.
Marte: Figlio di Giove e di Giunone, era il dio romano della guerra, onorato in Grecia sotto il nome di Ares (v.).
 Martin Lutero: Dal
nome tedesco di Martin Luther, teologo e riformatore (Eisleben 10.11.1483 - 18.2.1546).
Figlio di un ex minatore che era riuscito a raggiungere una discreta agiatezza, conseguì
il grado di magister artium all'università di Erfurt il 7.1.1505. Entrato nel
convento degli Agostiniani eremitani (osservanti) di Erfurt il 17 luglio dello stesso
anno, vi fu consacrato sacerdote due anni dopo. Dopo un viaggio a Roma (1510-11) per
protestare contro l'unione tra osservanti e conventuali, nel 1512 conseguì la laurea in
teologia a Wittenberg, succedendo a Johann von Staupitz, vicario generale dell'ordine,
nella cattedra di Sacra Scrittura. L'intenso lavoro esegetico di quegli anni (Commento ai Salmi,
alle lettere ai Romani, ai Galati ed agli Ebrei, 1513-17) coincise
per L. con una profonda crisi spirituale, a cui non diede giovamento l'osservanza,
scrupolosa fino al tormento, delle rigide norme monastiche, e che trovò la sua
risoluzione nella theologia crucis. Elaborata negli anni 1515-18 ed influenzata
dalla rinascita della teologia agostiniana, quest'opera si fonda sull'affermazione che
l'uomo, costantemente peccatore, è guidato dall'egoismo in ogni sua azione, anche quelle
miranti alla salvezza eterna, e quindi non è in condizione di soddisfare Dio. Non gli
resta che riconoscere il proprio peccato, abbandonandosi alla giustizia divina (Romani
I, 17), intesa non in senso attivo, per cui Dio è giusto e punisce il peccatori, ma
in senso passivo, quella cioè per la quale Dio, nella sua misericordia, non solo non
imputa i peccati al predestinato, ma anzi gli applica i meriti di Cristo, sì da
giustificarlo (cioè renderlo giusto) mediante la fede. Nominato vicario distrettuale
dell'ordine nel 1515, sembra che L. non fosse consapevole del pericolo di scissione da
Roma insito nella sua teologia, così come nessuna intenzione di scisma pare fosse
contenuta nelle 95 tesi affisse, secondo l'uso allora generale delle università, a
Wittenbergil 31.10.1517, per proporre alla pubblica discussione la campagna di indulgenze
predicata dal domenicano J. Tetzel per la costruzione di san Pietro. Le tesi di L.
respingevano il valore delle indulgenze ottenute per denaro ed applicabili anche alle
anime del Purgatorio, riprendendo il concetto di penitenza come metanoia (v.) e,
pur cercando di scindere la responsabilità dei predicatori da quella del pontefice,
sottintendevano critiche alla Chiesa, che trovarono eco nei circoli erasmiani ed
umanistici tedeschi, dove si andava diffondendo la tendenza al distacco da Roma. Ma quanto
nelle 95 era solo implicito si chiarì nella cosiddetta disputa di Lipsia (1519),
seguita ad un tentativo fallito da parte del cardinale legato Caetano di indurre L. alla
ritrattazione, nella quale L. replicò al suo avversario, il domenicano J. Eck (che aveva
sottolineato certe affinità tra L. ed Hus), affermando l'esattezza di talune affermazioni
hussite, come la natura esclusivamente umana dell'istituzione del papato e la possibilità
di errare da parte di un concilio. Minacciato di scomunica con la bolla Exsurge domine (15.6.1520),
L., forte della diffusa ostilità popolare nei confronti del papato, dell'appoggio armato
dei potenti cavalieri tedeschi e della protezione dell'Elettore, rispose dando
pubblicamente alle fiamme sia la bolla che i testi del diritto canonico (10.12.1520), dopo
aver pubblicato dall'agosto all'ottobre precedenti quelli che vengono considerati i tre
grandi trattati programmatici della Riforma: An den christlichen Adel deutscher Nation (Alla
nobiltà cristiana della nazione tedesca), De captivitate babylonica Ecclesiae e De
libertate christiana. Punti fondamentali dei primi due sono la dottrina del sacerdozio
universale dei credenti, la negazione del monopolio pontificio nell'interpretazione delle
sacre scritture, l'interpretazione dipendente unicamente dalla fede e nella convocazione
del concilio, l'attacco contro la tirannide papale, che trae la sua sola ragione d'essere
dall'amministrazione dei sacramenti. Questi, ridotti a tre, Battesimo, Penitenza ed
eucarestia, non sono oggettivi segni efficaci di grazia, ma traggono la loro validità
unicamente dalla fede di chi li riceve. Infine L. nega la dottrina della Messa come
sacrificio. Condannato definitivamente il 3.1.1521 (Bolla Decet Romanum Pontificem),
dopo aver rifiutato di sconfessare le sue opere dinanzi alla dieta di Worms
(17/18,4.1521), il 24 maggio L. venne sottratto al bando imperiale (emanato quattro giorni
dopo) mediante un simulato rapimento organizzato dal Principe elettore, e messo in salvo
nella Wartburg di Eisenach. Vi rimase per circa dieci mesi, dando inizio a quella
traduzione della Bibbia che, terminata poi nel 1534, è il primo monumento del tedesco
moderno. Se ne allontanò, contro il volere dell'elettore, nel marzo 1522, per difendere
la sua dottrina delle interpretazioni estremistiche dei suoi discepoli, e per sedare i
tumulti nati dall'introduzione di improvvisate riforme liturgiche, emanando norme di culto
e predicando la moderazione. Nel 1525 la distinzione fra uomo interiore e uomo esteriore,
fra potere spirituale e potere temporale, diede origine all'intransigente condanna
luterana della guerra dei contadini che, alla protesta di ordine economico sociale,
univa elementi religiosi assimilati dalla sua dottrina. Allontanatosi così dalle istanze
popolari di rinnovamento sociale, e postosi dalla parte dei grandi principi territoriali,
lo stesso anno, in seguito alla polemica con Erasmo da Rotterdam (De servo arbitrio),
L. si alienò anche le simpatie degli umanisti. Anno di decisioni e di rotture, il 1525 fu
anche l'anno del suo matrimonio con l'ex suora Katharina von Bora, che gli diede sei
figli. Da questo momento L., da profeta della Riforma intesa come rivoluzione teologica,
si trasformò in organizzatore della Chiesa nazionale tedesca posta, in contrasto con
l'idea iniziale del sacerdozio universale, sotto la tutela dei principi territoriali,
mentre si andava evidenziando il suo contrasto con i riformatori svizzeri (Zwingli ed
Ecolampadio). Contrasto confermatosi inconciliabile nei colloqui di Marburgo (ottobre
1529), rifiutando L. l'interpretazione simbolica dell'Eucarestia di Zwingli. L'anno
seguente ebbe luogo la Dieta d'Augusta, dove L., escluso per effetto del bando del 1521,
fu rappresentato da Melantone, firmatario della Confessio augustana che, insieme
agli articoli di Smeralda redatti dallo stesso L. (1537), costituisce il documento della
professione di fede luterana. L'organizzazione della sua Chiesa, la predicazione e
l'insegnamento occuparono gli ultimi anni della vita di L., di cui i Tischreden (Discorsi
conviviali), raccolti da amici e discepoli, costituiscono una viva testimonianza. I suoi
scritti, suddivisi in 69 volumi dall'edizione di Weimar del 1883 in poi, uniscono alla
genialità del teologo e dell'esegeta la freschezza e la forza espressiva della poesia e
del linguaggio popolare, ed hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella
formazione del tedesco moderno.
Martin Lutero: Dal
nome tedesco di Martin Luther, teologo e riformatore (Eisleben 10.11.1483 - 18.2.1546).
Figlio di un ex minatore che era riuscito a raggiungere una discreta agiatezza, conseguì
il grado di magister artium all'università di Erfurt il 7.1.1505. Entrato nel
convento degli Agostiniani eremitani (osservanti) di Erfurt il 17 luglio dello stesso
anno, vi fu consacrato sacerdote due anni dopo. Dopo un viaggio a Roma (1510-11) per
protestare contro l'unione tra osservanti e conventuali, nel 1512 conseguì la laurea in
teologia a Wittenberg, succedendo a Johann von Staupitz, vicario generale dell'ordine,
nella cattedra di Sacra Scrittura. L'intenso lavoro esegetico di quegli anni (Commento ai Salmi,
alle lettere ai Romani, ai Galati ed agli Ebrei, 1513-17) coincise
per L. con una profonda crisi spirituale, a cui non diede giovamento l'osservanza,
scrupolosa fino al tormento, delle rigide norme monastiche, e che trovò la sua
risoluzione nella theologia crucis. Elaborata negli anni 1515-18 ed influenzata
dalla rinascita della teologia agostiniana, quest'opera si fonda sull'affermazione che
l'uomo, costantemente peccatore, è guidato dall'egoismo in ogni sua azione, anche quelle
miranti alla salvezza eterna, e quindi non è in condizione di soddisfare Dio. Non gli
resta che riconoscere il proprio peccato, abbandonandosi alla giustizia divina (Romani
I, 17), intesa non in senso attivo, per cui Dio è giusto e punisce il peccatori, ma
in senso passivo, quella cioè per la quale Dio, nella sua misericordia, non solo non
imputa i peccati al predestinato, ma anzi gli applica i meriti di Cristo, sì da
giustificarlo (cioè renderlo giusto) mediante la fede. Nominato vicario distrettuale
dell'ordine nel 1515, sembra che L. non fosse consapevole del pericolo di scissione da
Roma insito nella sua teologia, così come nessuna intenzione di scisma pare fosse
contenuta nelle 95 tesi affisse, secondo l'uso allora generale delle università, a
Wittenbergil 31.10.1517, per proporre alla pubblica discussione la campagna di indulgenze
predicata dal domenicano J. Tetzel per la costruzione di san Pietro. Le tesi di L.
respingevano il valore delle indulgenze ottenute per denaro ed applicabili anche alle
anime del Purgatorio, riprendendo il concetto di penitenza come metanoia (v.) e,
pur cercando di scindere la responsabilità dei predicatori da quella del pontefice,
sottintendevano critiche alla Chiesa, che trovarono eco nei circoli erasmiani ed
umanistici tedeschi, dove si andava diffondendo la tendenza al distacco da Roma. Ma quanto
nelle 95 era solo implicito si chiarì nella cosiddetta disputa di Lipsia (1519),
seguita ad un tentativo fallito da parte del cardinale legato Caetano di indurre L. alla
ritrattazione, nella quale L. replicò al suo avversario, il domenicano J. Eck (che aveva
sottolineato certe affinità tra L. ed Hus), affermando l'esattezza di talune affermazioni
hussite, come la natura esclusivamente umana dell'istituzione del papato e la possibilità
di errare da parte di un concilio. Minacciato di scomunica con la bolla Exsurge domine (15.6.1520),
L., forte della diffusa ostilità popolare nei confronti del papato, dell'appoggio armato
dei potenti cavalieri tedeschi e della protezione dell'Elettore, rispose dando
pubblicamente alle fiamme sia la bolla che i testi del diritto canonico (10.12.1520), dopo
aver pubblicato dall'agosto all'ottobre precedenti quelli che vengono considerati i tre
grandi trattati programmatici della Riforma: An den christlichen Adel deutscher Nation (Alla
nobiltà cristiana della nazione tedesca), De captivitate babylonica Ecclesiae e De
libertate christiana. Punti fondamentali dei primi due sono la dottrina del sacerdozio
universale dei credenti, la negazione del monopolio pontificio nell'interpretazione delle
sacre scritture, l'interpretazione dipendente unicamente dalla fede e nella convocazione
del concilio, l'attacco contro la tirannide papale, che trae la sua sola ragione d'essere
dall'amministrazione dei sacramenti. Questi, ridotti a tre, Battesimo, Penitenza ed
eucarestia, non sono oggettivi segni efficaci di grazia, ma traggono la loro validità
unicamente dalla fede di chi li riceve. Infine L. nega la dottrina della Messa come
sacrificio. Condannato definitivamente il 3.1.1521 (Bolla Decet Romanum Pontificem),
dopo aver rifiutato di sconfessare le sue opere dinanzi alla dieta di Worms
(17/18,4.1521), il 24 maggio L. venne sottratto al bando imperiale (emanato quattro giorni
dopo) mediante un simulato rapimento organizzato dal Principe elettore, e messo in salvo
nella Wartburg di Eisenach. Vi rimase per circa dieci mesi, dando inizio a quella
traduzione della Bibbia che, terminata poi nel 1534, è il primo monumento del tedesco
moderno. Se ne allontanò, contro il volere dell'elettore, nel marzo 1522, per difendere
la sua dottrina delle interpretazioni estremistiche dei suoi discepoli, e per sedare i
tumulti nati dall'introduzione di improvvisate riforme liturgiche, emanando norme di culto
e predicando la moderazione. Nel 1525 la distinzione fra uomo interiore e uomo esteriore,
fra potere spirituale e potere temporale, diede origine all'intransigente condanna
luterana della guerra dei contadini che, alla protesta di ordine economico sociale,
univa elementi religiosi assimilati dalla sua dottrina. Allontanatosi così dalle istanze
popolari di rinnovamento sociale, e postosi dalla parte dei grandi principi territoriali,
lo stesso anno, in seguito alla polemica con Erasmo da Rotterdam (De servo arbitrio),
L. si alienò anche le simpatie degli umanisti. Anno di decisioni e di rotture, il 1525 fu
anche l'anno del suo matrimonio con l'ex suora Katharina von Bora, che gli diede sei
figli. Da questo momento L., da profeta della Riforma intesa come rivoluzione teologica,
si trasformò in organizzatore della Chiesa nazionale tedesca posta, in contrasto con
l'idea iniziale del sacerdozio universale, sotto la tutela dei principi territoriali,
mentre si andava evidenziando il suo contrasto con i riformatori svizzeri (Zwingli ed
Ecolampadio). Contrasto confermatosi inconciliabile nei colloqui di Marburgo (ottobre
1529), rifiutando L. l'interpretazione simbolica dell'Eucarestia di Zwingli. L'anno
seguente ebbe luogo la Dieta d'Augusta, dove L., escluso per effetto del bando del 1521,
fu rappresentato da Melantone, firmatario della Confessio augustana che, insieme
agli articoli di Smeralda redatti dallo stesso L. (1537), costituisce il documento della
professione di fede luterana. L'organizzazione della sua Chiesa, la predicazione e
l'insegnamento occuparono gli ultimi anni della vita di L., di cui i Tischreden (Discorsi
conviviali), raccolti da amici e discepoli, costituiscono una viva testimonianza. I suoi
scritti, suddivisi in 69 volumi dall'edizione di Weimar del 1883 in poi, uniscono alla
genialità del teologo e dell'esegeta la freschezza e la forza espressiva della poesia e
del linguaggio popolare, ed hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella
formazione del tedesco moderno.
Martinezismo: Il patrizio Dom Martinez de Pasqually (1710-1779), iniziato ventenne alla Massoneria a Londra da Swedenborg, era di mediocre cultura intellettuale, come evidenziato dalle sue penose (da leggere) lettere. Eccellente figura di cattolico, abbandonava la Massoneria insieme al conte di Saint Martin (v.), per fondare in Francia il cosiddetto M., come dottrina mistica. Nei Misteri del M. l’Adamo biblico si identifica con l’Adamo Kadmon della tradizione cabalistica, a cui allude San Paolo nella sua prima lettera ai Corinti (15, 45-50), mentre fa distinzione fra l’Adamo dei Cieli e l’Adamo di Creta di questo nostro mondo. Il peccato di Adamo sarebbe consistito in un’operazione alchemica mal riuscita, dal che ha tratto origine l’attuale umanità, legata la mondo dei sensi, in conseguenza della superbia del proprio Archetipo. Martinez sosteneva che le sue conoscenze erano d’origine orientale, suffragando tale ipotesi col fatto d’aver intrapreso nella sua giovinezza un viaggio in Cina, peraltro confermato da vari seri indizi. Tuttavia, meglio di altri egli riuscì a congiungere la sua dottrina alla cabala araba. Il Taumaturgo pretendeva di stabilire relazioni con gli spiriti celesti, per mezzo di un cerimoniale cabalistico. Inoltre l’iniziazione Rosacrociana, alla quale si richiamava la sua dottrina, pretendeva fosse conferita da Angeli, oppure da Spiriti minori. Nella sua struttura gerarchica il M. prospettava, nei suoi Gradi più illuminati, una specie di aristocrazia segreta, definita dei Sacerdoti Eletti, dalla quale derivò l’Ordine dei Massoni Eletti Cohen dell’Universo, praticamente un panteismo (v.) mistico che sedusse molti massoni scozzesi. Per diffondere queste informazioni metafisiche Martinez viaggiò per tutta la Francia, dove le sue due oasi furono costituite a Bordeaux ed a Parigi. Lo stesso Saint Martin, dopo la morte del fondatore del rito, si avvicinò a questo insieme di cognizioni e di precetti, ammantati di scienza occulta, con indirizzi essenzialmente magici e teosofici, cui presentavano un’impostazione di base mistico-religiosa interiorizzata, propria poi del suo Rito Martinista (v.)
Martinismo: V. Ordine Martinista.
Marxismo: Corrente di pensiero avente il proprio fondamento teorico nelle opere di Karl Marx (1818-1883) e di Friedrich Engels (1820-1895), e che ha avuto un ampio e progressivo sviluppo negli ultimi decenni del secolo scorso e per tutto il secolo corrente. Essa si basa essenzialmente sopra un’interpretazione materialistica della storia, in funzione della quale due sono gli elementi decisivi tra loro interconnessi: i rapporti sociali di produzione, che ne costituiscono il lato oggettivo, ovvero i rapporti oggettivi entro cui gli uomini si trovano nell’ambito di un mondo in cui, ad un certo livello storico, la produzione è organizzata, e da cui a propria volta scaturisce la divisione sociale in classi contrapposte; e le forme di organizzazione e di conduzione della lotta di classe, il lato soggettivo, che corrispondono, in ultima analisi, alla storia del movimento operaio. Tale interpretazione materialistica, che individua una contraddizione oggettiva al livello dei modi di produzione e riproduzione della vita materiale ed un soggetto agente nella storia stessa, il proletariato, le cui forme di coscienza e di organizzazione pratica, si misurano nello stesso tempo con gli effetti politici immediati e rispetto ad un complessivo progetto rivoluzionario rivolto all’instaurazione del comunismo, non possono non applicarsi a se stessa: in altre parole, la storia del M. non può essere letta come semplice evolversi di posizioni teoriche che si superano, si criticano e si perfezionano secondo una propria logica interna, bensì va considerata sempre in stretto rapporto con il dato materiale cui si riferisce, dato oggettivo (il livello di organizzazione e di lotta). Conseguentemente, nel suo progressivo caratterizzarsi come fenomeno internazionale, il M. è scandito nelle tappe fondamentali dell’organizzazione operaia: il periodo della I Internazionale che nasce nel 1864 sotto l’influenza dello stesso Marx, vede il costituirsi delle prime effettive organizzazioni operaie, il primo esemplare sbocco rivoluzionario nella Comune parigina del 1871, ed il grande dibattito tra M. ed anarchismo; il periodo della II Internazionale, a partire dal 1889, durante il quale si sviluppa il partito socialdemocratico tedesco e si organizza il partito bolscevico russo, mentre si articola l’altro grande dibattito sul revisionismo (la dissoluzione del concetto di rivoluzione nella teoria di Bernstein): tale periodo si chiude nel 1914, all’inizio della prima guerra mondiale, con il fallimento delle posizioni fino allora sviluppate, in particolare quelle riformistiche di Kautsky, ormai inadeguate ad interpretare e guidare i movimenti rivoluzionari che in Russia, con Lenin, sfocia nella clamorosa vittoria del 1917, che permette il costituirsi del primo Stato nazionale a regime socialista, cioè sulla base della proprietà collettiva dei mezzi di produzione. La rivoluzione di ottobre ed il successivo sviluppo della situazione sovietica dopo la morte di Lenin e con l’avvento di Stalin, caratterizzano il periodo della III Internazionale, la cui strategia sta a fondamento anche dell’attività del partito comunista italiano (guidato da Gramsci e poi da Togliatti), e di quello francese con Thorez, cioè delle due maggiori organizzazioni operaie dell’Europa occidentale. Dopo la seconda guerra mondiale il quadro politico europeo risulta notevolmente mutato: da un lato vi è un blocco di paesi a regime socialista imperniato sull’Unione Sovietica, in cui vengono conservate le posizioni del M. dogmatico sovietico; dall’altro lato s’impone invece la ricerca di una soluzione sociale per vie nazionali, legate alla specificità delle situazioni. La morte di Stalin e le destalinizzazione ufficialmente proclamata nel XX Congresso del PCUS (1956) affrettano quest’ultimo processo, anche a livello di elaborazione teorica, mentre comportano una dialettica interna ai paesi del blocco socialista, come il nuovo corso cecoslovacco represso nel 1968. Contemporaneamente matura la situazione cinese, che rappresenta il grande fatto nuovo destinato ad incidere profondamente nella storia del M. La rivoluzione cinese, proclamata dopo una lunga lotta nel 1949, la rottura tra Cina ed URSS, il periodo successivo della rivoluzione culturale antiburocratica, le idee che ne conseguono, e principalmente quella della lotta di classe continuata anche dopo la presa del potere, vengono a rappresentare un punto di riferimento per lo stesso M. occidentale, ed un deciso attacco all’ortodossia sovietica internazionalista. I movimenti operai e studenteschi del 1968 esprimono la persistente crisi delle organizzazioni ufficiali proletarie, e l’esigenza di una risposta teoricamente ed organizzativamente diversa nel confronto con il capitalismo avanzato ed alla trasformazione che il mondo del lavoro vi sta subendo. Complessivamente si sta affacciando alla ribalta sociale una nuova forma di M., risultante sia dal fenomeno cinese sia come riflessione nelle lotte studentesche ed operaie, che sembrano portare ad un vigoroso conflitto fra strutture e sovrastrutture, uno dei cardini dell’interpretazione marxista, per un’analisi diversa del rapporto stesso, che evidenzi il carattere decisivo dei livelli considerati sovrastrutturali, ovvero il livello politico, quello della società civile e quello della vita quotidiana.
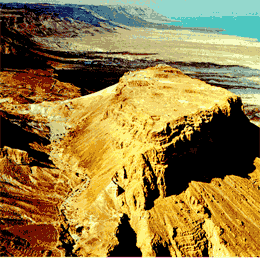 Masada: Nome derivato
dall’ebraico Mesalah e dal greco Masada. Località
dello Stato d’Israele, sulla sponda occidentale del Mar Morto, ubicata su un vasto
pianoro a circa 300 metri di altezza. Vi si trovava un’antica fortezza ebraica, fatta
costruire da Gionata Asmoreo; qui, dopo la conquista partica di Gerusalemme, si rifugiò
Erode che la trasformò, dotandola di strutture che la resero confortevole e molto più
adatta alla propria difesa. Il questo luogo resistettero (77-73 d.C.) gli ultimi gruppi di
Zeloti (v:), promotori della rivolta giudaica, sino alla presa da parte dei romani guidati
da Flavio Silva. Le legioni di Roma in quell’occasione subirono un tragico smacco,
poiché occuparono una città di morti: infatti tutti gli assediati, uomini, donne, vecchi
e bambini, si erano già suicidati, preferendo la morte all’onta della resa. Gli
scavi hanno messo in luce le costruzioni edificate al tempo di Erode (37 a.C.): opere di
difesa, cisterne, caserme e due palazzi con ambienti molto sontuosi.
Masada: Nome derivato
dall’ebraico Mesalah e dal greco Masada. Località
dello Stato d’Israele, sulla sponda occidentale del Mar Morto, ubicata su un vasto
pianoro a circa 300 metri di altezza. Vi si trovava un’antica fortezza ebraica, fatta
costruire da Gionata Asmoreo; qui, dopo la conquista partica di Gerusalemme, si rifugiò
Erode che la trasformò, dotandola di strutture che la resero confortevole e molto più
adatta alla propria difesa. Il questo luogo resistettero (77-73 d.C.) gli ultimi gruppi di
Zeloti (v:), promotori della rivolta giudaica, sino alla presa da parte dei romani guidati
da Flavio Silva. Le legioni di Roma in quell’occasione subirono un tragico smacco,
poiché occuparono una città di morti: infatti tutti gli assediati, uomini, donne, vecchi
e bambini, si erano già suicidati, preferendo la morte all’onta della resa. Gli
scavi hanno messo in luce le costruzioni edificate al tempo di Erode (37 a.C.): opere di
difesa, cisterne, caserme e due palazzi con ambienti molto sontuosi.
Massone: Detto anche Libero Muratore, è la denominazione attribuito ad ogni membro attivo della Massoneria Universale. L'Istituzione dei Liberi Muratori ha un unico obbiettivo, identificato nell'elevazione e nel progresso dell'uomo e, conseguentemente, dell'umanità intera. Per conseguirlo, non sceglie il metodo dell'insegnamento, peraltro inapplicabile e quindi escluso nel campo esoterico, ma la ricerca personale, propiziata dall'impegno collettivo nel Tempio, arricchita dall'esperienza dei singoli, stimolata dall'emulazione e rafforzata dall'esempio. Ciò perché la Massoneria non ritiene di avere Verità da trasmettere, pur ribadendo la validità di valori morali validi in ogni tempo e luogo, espressi nell'esaltazione suprema della libertà materiale e spirituale, diritto-dovere d'ogni essere umano e di qualsiasi consorzio civile. Il M. non fa parte di un gregge e non accetta pastori. Egli non mira ad apparire, ma ad essere, ed è portato a conoscere, valutare, scoprire comprendere e meditare tutto su tutto, sfruttando unicamente il proprio raziocinio. Requisito fondamentale d'ogni M. è la condizione di "uomo libero e di buoni costumi". Uomo libero significa non schiavo di ristrettezze mentali, di pregiudizi e credenze, ma di mente aperta e tollerante, disposto quindi a ricercare attivamente ogni possibile fonte di conoscenza e di verità. Uomo dotato di un atteggiamento mentale imparziale, pronto a modificare idee precedenti ed a sperimentare, desideroso di passare dalle tenebre alla Luce. Di buoni costumi significa uomo dotato di qualità fisiche, animiche e spirituali che non lo pone solo in armonia col mondo di relazione in cui vive ed opera, ma lo conduce a sviluppare quell'intelligenza intuitiva che porta a compiere il salto qualitativo da uomo determinato dall'ambizione e dall'egoismo a Uomo teso ad integrare la propria natura nel ritmo della Legge universale di Evoluzione ed Amore. Si può dire in sintesi che il M. sia alunno di una scuola del pensiero democratico, in cui si formano uomini di spiritualità superiore. Rappresenta l'ideale della comunanza umana, che va cancellando dalla società ogni privilegio ed ostilità di razza, di casta e di nazione, onde congiungerli tutti, in armonica varietà, sotto una comune legge di libertà, di giustizia e d'amore. La Massoneria è accusata di creare sacerdoti della dea Ragione, operatori adogmatici privi delle regole canoniche ideate essenzialmente a sostegno dei cosiddetti portatori della Verità e del loro potere temporale, ed è quindi combattuta da quanti hanno creato il mito della saggezza imposto dal dogma. Le circa trecento scomuniche comminate dalla Chiesa di Roma contro la figura del M., non hanno certo avuto l'effetto auspicato, considerato il fatto che moltissimi sono stati i prelati, anche principi della Chiesa, che hanno comunque voluto e conseguito l'iniziazione muratoria. L'unica conseguenza è stata che, specie in alcuni paesi (come soprattutto l'Italia), la scomunica (v.) ha costretto la Massoneria alla difensiva, trasformandola in un'associazione forzatamente riservata, a tutela della privacy dei suoi adepti, spesso soggetti a ritorsioni o vere persecuzioni nell'ambito professionale in cui operano profanamente. Contro tali atti assolutamente ingiustificati, il Grande Oriente d’Italia ha da qualche anno istituzionalizzato un apposito fondo di solidarietà, mediante il quale interviene per tutelare legalmente ogni M. oggetto di discriminatorie censure attuate contro di lui, come sola conseguenza della sua appartenenza all'Istituzione, dai mezzi d'informazione, da enti pubblici o dalla stessa magistratura. (v. La Luce massonica, di A. Sebastiani, Ediz. Hermes. 1992, Vol. 1°).
Massoneria e Buddhismo: In estremo oriente la forma prevalente di Buddhismo è quella del "Grande Veicolo", che a differenza di quella del "Piccolo Veicolo" riconosce il Buddha originario come somma divinità, dalla quale provengono e verso la quale ritornano tutte le sfere d’esistenza. Tuttavia in talune diramazioni del Grande Veicolo tale credenza non è affatto solida, e secondo C. Haffner la questione dell’iniziabilità dei buddhisti resta aperta. L’avvenuta iniziazione di vari buddhisti nelle aree cino-nipponica ed indocinese attesta inequivocabilmente la compatibiltà di fatto tra Libera Muratoria e Grande Veicolo.
Massoneria e Chiesa: Fu nel lontano 1738 che papa Clemente XII condannò per primo la Massoneria attraverso la Bolla In Eminenti (v.), comminando la scomunica (v.) ai Massoni e denunciando la pratica dell’Ordine come contraria alla quiete degli Stati temporali ed alla salute delle anime. In pratica si proibiva a tutti i fedeli, sotto pena di scomunica, di aderire alle società massoniche e di ricevere i massoni dando loro asilo. Era una vera dichiarazione di guerra della Chiesa contro la Massoneria, cui si contrapponeva un Ordine che mai si era opposto alla religione cattolica. Suscita perplessità il fatto che molti prelati, tra i quali anche vescovi e cardinali, abbiano varcato la soglia del tempio massonico, nonostante la formale inequivocabile proibizione dei vertici della Chiesa. Più tardi certi scrittori cristiani si sforzeranno di ribadire che la condanna interessasse soprattutto l’Italia. Altri invece sosterranno che il papa avesse inteso reagire al sequestro effettuato dai protestanti anglicani della Massoneria inglese. Alcuni renderanno responsabili di tale condanna papale i creatori degli Alti Gradi, particolarmente quelli Scozzesi (v.) che, improntando alla religione pubblica determinati atti rituali, spogliati dei loro contenuti mistici per dare loro significanze morali, con quei Gradi di vendetta avrebbero scatenato le sanzioni dei pontefici di Roma. Conglobando il simbolo della Rosa+Croce di ispirazione luterana nonché i rituali del Grado Kadosh evocante l’Ordine abolito dei Templari, lo scozzesismo, secondo i Massoni mistici, aveva provocato quella reazione. Ritornando alle condizioni del tempo, risulta inevitabile ammettere che la Massoneria stava diventando una potenza con cui la Chiesa, ed suo potere temporale, non poteva evitare di confrontarsi. Quella prima bolla, diventata famosissima, assumeva ed assume tuttora tanta importanza da essere ripetutamente citata in molte encicliche e bolle di condanna successive (oggi ammontano ad oltre 200). Era un documento tanto perentorio e determinato da non poter essere stato edito da un papa molto vecchio com’era Clemente XII, ma si comprese presto chi ne fosse stato l’autore, allorché l’amministratore dello Stato Pontificio, il cardinale segretario di Stato Giuseppe Firrao, emise un editto nel quale ai Massoni veniva comminata la scomunica, confiscati i beni e condannati a morte. Vi si notificava pure che le case utilizzate quale luogo di riunione massoniche dovevano essere tutte abbattute. Alle minacce seguirono subito i fatti, testimoniati da un lungo elenco di martiri, maltrattati e perseguitati con estrema crudeltà dalla Santa Inquisizione (v.). Dal punto di vista puramente storico, si può ritenere che la Chiesa non abbia avversato la Massoneria in quanto anticattolica, o anticristiana, od antireligiosa, oppure anti spiritualistica, ma piuttosto che l’ostilità della Chiesa abbia avuto l’effetto di determinare, soprattutto nei paesi a forte influenza clericale, il nuovo carattere della Libera Muratoria, costretta a difendersi ed a proteggersi, trasformandola in un’associazione forzatamente segreta. Ma essa non divenne mai settaria, ed i suoi rituali sarebbero sempre rimasti conformi allo spirito di Tolleranza, secondo le sue antiche Tradizioni. Oggi più che mai i veri Massoni apprezzano l’adempimento dei doveri morali ben più di tutte le credenze bigotte, mentre le massime dell’Istituzione muratoria sono diventate veri principi del mondo colto, trovando conferma nelle leggi di ogni stato civile e democratico. Quella scomunica scagliata sulla base delle motivazioni dichiarate e ribadite anche in tempi recenti, non può avere alcun effetto infamante, rivelando al contrario al mondo intero l’oscurità profonda dell’intolleranza che l’ha originata, e quanto Roma sia rimasta arretrata nel progresso morale e sociale dell’Umanità.
Massoneria e Confucianesimo: La filosofia di Confucio (v.) è fondata sul concetto di ordine Celeste (t’ien tao) e, essendo fortemente legata a pratiche di tipo alchemico (anche se molto particolare), non ha mai posto problemi all’iniziazione muratoria dei suoi seguaci. Il Confucianesimo ammette infatti una realtà Suprema sovrastante l’uomo, e ne venera la via tracciata dagli antichi Libri Sacri.
Massoneria e Fascismo: Fin dall’epoca dei suoi entusiasmi social-rivoluzionari, Benito Mussolini si era battuto perché fosse proclamata l’incompatibilità tra l’iscrizione al Partito Socialista Italiano e l’appartenenza alla Massoneria. Prima venne proposta al Congresso di Bologna del 1904, e poi a quello di Reggio Emilia del 1912, dove fu approvata. A spingere Mussolini a questa decisione erano stati i rappresentanti dell’ala cattolico-nazionalista del partito, che consideravano intermazionalisti tutti i massoni. Sopraggiungeva la prima guerra mondiale, e la politica dell’interventismo fu patrimonio ed espressione di ambo le obbedienze di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù, nate dalla scissione del 1908, nel solco dell’ancor viva e diffusa filosofia azionista e mazziniana. Entrambe furono indotte ad espressioni di simpatia iniziali nei confronti dei Fasci di Combattimento. Molti uomini aderenti a quest’ultimo movimento erano attivi massoni, come Italo Balbo, Giuseppe Bottai, Giacomo Acerbo e persino Roberto Farinacci, ma fu un idillio di breve durata. Il G.O.I. lasciò ai propri iscritti di sentimenti fascisti la "piena libertà di rompere i ponti con la Massoneria", sostenendo che questi restavano comunque coerenti con l’amor patrio loro inculcato in Loggia (delibera del 18 febbraio 1923). Invano Piazza del Gesù offriva a Mussolini il brevetto di 33° Grado del suo R.S.A.A. La persecuzione contro l’istituzione massonica in tutte le sue espressioni, scatenò dalla fine del 1923 l’azione delle squadre d’azione fasciste, che devastarono tutte le sedi massoniche, bruciandone archivi e preziose biblioteche. Nel maggio 1925 veniva decretato lo scioglimento di tutte le società segrete, aprendo la caccia indiscriminata al massone, culminata con la mortale bastonatura dello scrittore spiritualista e uomo politico Giovanni Amendola. Prendendo a pretesto il progetto d’attentato dell’on. Zaniboni contro Mussolini, sia il Gran Maestro del G.O.I. Domizio Torrigiani che il generale Capello venivano accusati d’aver finanziato il complotto. Ma nel 1927 poterono entrambi dimostrare la propria ampia estraneità a quei fatti. Venivano entrambi comunque puniti: il Capello con la condanna a trent’anni di reclusione (doveva scontarne solo dieci, data l’età di 78 anni), e Torrigiani costretto per cinque anni al domicilio coatto a Lipari: veniva liberato pochi giorni prima del termine della pena, in quanto divenuto cieco e gravemente ammalato, per cui gli fu consentito di morire in pace nella sua casa di Pistoia (31 agosto 1932). Non furono soltanto Capello e Torrigiani i massoni perseguitati dal governo fascista. La legge contro le società segrete aveva dimenticato tra i suoi obiettivi tre istituzioni di scarso peso numerico, ma che potevano offrire una cornice organizzativa ed una base simbolica di variegato valore: l’Ordine del tempio, l’Ordine Martinista ed il Rito di Memphis-Misraim. Fu naturale che i fratelli esoteristi si avvalessero di esse per mantenere in vita lo spirito massonico. Ci provarono soprattutto sia il Reghini che l’Allegri, massimi responsabili di tali istituzioni, che furono prodighi di ospitalità e protezione verso i confratelli delle obbedienze disciolte. Questo sarebbe costato all’Allegri sia la carcerazione che il confino (1928-29), ma egli non demordeva affatto dall’attività esoterica (v. "Tutti gli uomini del Martinismo" di Gastone Ventura, pagg. 60-71, Ediz. Atanor, 1978). Varie Logge operarono in esilio, restando all’obbedienza del disciolto G.O.I., sia in Francia e Svizzera che negli Stati Uniti. La fine del fascismo e della seconda guerra mondiale (1945) vedeva la rinascita della massoneria italiana, purtroppo però espressa da una ventina di diverse obbedienze, per lo più accavallate in modo convulso, con un contorno di recriminazioni e di ambizioni nettamente retoriche. Oggi tale numero si è più che dimezzato, ed il panorama massonico nazionale si è sotto molti aspetti chiarito (v. "La Massoneria", di Christian Jacq, Appendice di Alberto Cesare Ambesi, Ediz. Mursia, 1978)
Massoneria e Jainismo: Per il Jainismo si pone un problema di qualificazione analogo a quello presentato dal Buddhismo del Piccolo Veicolo. Si tratta di una religione che non ammette una divinità creatrice, ma contempla una innumerevole molteplicità di anime che, a contatto con la materia matrice, formano l’universo. Il Jainismo offre il proprio culto a quegli asceti-eroi che hanno ripulito la propria anima da ogni contaminazione materialistica, permettendole di salire alla sommità dell’universo, al vertice del polo dell’Essere. Diversamente dall’ateismo buddhista, quello jaina ammette una sostanza spirituale eterna. Al riguardo vale la pena d’osservare che nel corso dell’ultimo secolo, come annotato dal Bouquet nel 1941, sono state avanzate interpretazioni panteistiche del Jainismo: "Vijana Dharma Suri, morto pochi anni or sono, considerato dai jaina un grande santo, in un sermone tenuto davanti al marajà di Benares asserì che è un errore accusare i jaina di ateismo, perché essi credono nel Paratman, lo Spirito Supremo". In ultima istanza, nel Jainismo il Grande Architetto dell’Universo si identifica con l’Anima (jiva), la sostanza più elevata nella Realtà che plasma la materia (pudgala) e, recuperata l’inerente onniscenza nella dimora dei liberati, sorta di collettività animica costituente una versione jaina del Dio Altissimo. Quindi non può sollevare stupore che tanto in India che in paesi di emigrazione indiana (come il Kenia ed il Sud Africa), elementi di estrazione jaina abbiano avuto accesso ai Templi massonici, in obbedienze regolari ed irregolari, raggiungendo nell’Ordine posizioni anche autorevoli. Per quanto riguarda la cosiddetta Massoneria spuria, occorre ricordare l’interessante capitolo della formazione di un gruppo jaina "liberale", che nell’India della fine ‘800 cominciò a proporre un Jainismo essenziale ed ecumenico, non dogmatico e non casuistico (com’erano invece le principali scuole tradizionali), proiettandosi anche in occidente con il sostegno offerto alla minuscola ed effimera Mahavira Brotherhood di Londra. Il Bharat Jaina Mahamandal, denominazione della formazione jaina liberale, ebbe stretti rapporti con la Società Teosofica di Annie Besant, leader della Co-Masonry (Massoneria mista) angloindiana, e madrina di vari jaina candidati all’iniziazione massonica.
Massoneria e religioni orientali: La penetrazione della Massoneria e la formazione di un’Istituzione autoctona nell’Estremo Oriente ha comportato un processo lungo e complesso, perché: · 1) la Massoneria penetrò in quell’area al seguito di eserciti coloniali, non sempre bene accetti, oppure per opera di commercianti o di tecnici, guardati comunque con sospetto dalle popolazioni locali; essa si lasciò pertanto docilmente omologare alle istituzioni nazionali dei paesi dai quali provenivano i suoi membri, provocando frequenti reazioni di rigetto od almeno di disinteresse, com’è stato il caso del Pakistan e del Giappone; · 2) I Liberi Muratori occidentali, specialmente i britannici, hanno solo gradualmente e con grande cautela accolto, nel secolo scorso, candidati orientali aderenti a religioni in cui la credenza in un Essere Supremo non fosse esplicita come nelle tradizioni monoteistiche dell’Occidente. Rapporti validi sono stati comunque avviati con vari gruppi religiosi orientali, come con l’Induismo (v.), il Buddhismo (v.), il Jainimo (v.), il Sikhismo (v.), il Confucianesimo (v.), il Taoismo (v.) e lo Shintoismo (v.).
Massoneria e Shintoismo: Il primo giapponese iniziato alla Libera Muratoria fu quasi certamente Amane Nishi (1829-1897), che ricevette la Luce a Leida (Paesi Bassi) nel 1864, durante uno dei pochi viaggi che l’Imperatore del Sol levante, notoriamente isolazionista all’epoca, consentiva ai propri sudditi. A Leida Nishi studiò diritto ed economia: rientrato in patria, contribuì al riformismo illuminato dell’imperatore Meiji, che aprì lo Shintoismo ad alcuni aspetti della cultura occidentale, coniando il moderno linguaggio filosofico giapponese. Il primo incontro tra Massoneria e Shintoismo avvenne dunque sotto il segno dell’apertura ideologica del secondo, che tuttavia restò poco permeabile agli influssi teorici e linguistici occidentali, e fece quadrato intorno alla mitologia imperiale. Solo nell’ultimo dopoguerra si verificò un modesto sviluppo della Massoneria giapponese, incrementando un certo contrasto tra Shintoismo e massoneria, specie quella americana. Le Logge, ruotanti intorno all’orbita statunitense, avrebbero infatti dovuto contribuire a sradicare l’ideologia imperiale (pilastro dello Shintoismo, che vede nell’imperatore un discendente della dea solare Amaterasu) dalla cultura giapponese, plasmando quest’ultima sul modello dei valori occidentali. Secondo lo studioso C. Haffner, "il Fratello Mac Arthur vedeva la Massoneria come uno dei mezzi disponibili per raggiungere questi fini". In una sua lettera del 29 luglio 1949 alle classi dirigenti del R.S.A.A. di Tokyo egli, capo delle forze d’occupazione, indicava nel risveglio massonico giapponese un valido supporto alla democratizzazione del paese. Malgrado la successiva iniziazione alla Libera Muratoria di vari esponenti del governo giapponese, e l’interessamento manifestato verso di essa dallo stesso Imperatore Hirohito, il rapporto tra l’Ordine e la cultura ufficiale giapponese è rimasto decisamente labile. Di particolare interesse massonico appare comunque il rituale tenrikyo, detto Mikagura-Uta, nelle cui pagine finali si rintraccia una vera e propria apoteosi della "costruzione": "Prima di dare inizio alla meravigliosa costruzione, interrogate i disegni di Dio, poi date gli ordini. A poco a poco, da tutto il mondo, si riuniscono i costruttori: spandete su di loro il profumo di Dio. Se conoscete dei validi maestri d’opera, fateli al più presto convenire qui, al luogo Originario. Ecco, ora sono tutti riuniti i costruttori, per la costruzione del mondo gioioso".
Massoneria e Sikhismo: La presenza nei templi massonici di esponenti della comunità sikh (nelle varie diramazioni, escluse quelle integraliste) non ha mai posto problemi di qualificazione, poiché la credenza nell’Essere Supremo è stata uno dei capisaldi della fede di Nanak e dei suoi discepoli, dal ‘500 ad oggi. Uno dei fattori che ha contribuito a far affluire i sikh nelle Logge è stata sicuramente la circostanza che, dopo le battaglie anti-inglesi in cui la comunità fu impegnata negli anni 1845-1849, i quadri dell’esercito angloindiano venissero reclutati in gran numero proprio tra loro, in quanto le loro virtù guerriere avevano avuto modo di palesarsi nel corso dei precedenti conflitti. A contatto con gli ambienti massonici castrensi, gli ambienti sikh di più provato lealismo al Commonwealth ebbero agio di avvicinarsi all’Istituzione che, meglio d’ogni altra, rappresentava la spinta universalistica che lambiva l’ideologia coloniale, tanto celebrata da R. Kipling (v.). Un altro motivo che spinse numerosi sikh ad accostarsi alla Massoneria fu l’operosità diffusa nella comunità, il suo stile di vita laborioso (integrante l’elemento mistico e contemplativo essenziale alla religione sikh) e transitivo, tanto che fin dall’inizio i sikh si raccolsero intorno ai loro guru, provenendo sia dall’induismo che dall’islam, e superando pregiudizi di casta e nazionalistici. Figura paradigmatica tra i Massoni di religione sikh fu certamente il maharaja Dhuleep Singh (1837-1893), membro della Loggia Eastern Star di Calcutta.
Massoneria e Spiritualità: La Comunione italiana adotta rituali in accordo con gli Antichi Doveri, usi e costumi dell’Ordine, osserva il monoteismo, apre il Libro della Legge Sacra sull’Ara del Tempio e vi sovrappone la squadra ed il compasso, segue l’esoterismo nell’insegnamento ed il simbolismo nell’arte operativa (Art. 3 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia). Questo significa che la Libera Muratoria contempla una religiosità universalista. Essa tende ad avvicinare i suoi adepti all’essenza delle cose attraverso la ricerca e la focalizzazione dei collegamenti tra i molteplici aspetti del pensiero, e tra le diverse nature dell’essere umano. Pratica inoltre lo studio comparato delle dottrine filosofiche e religiose mediante la drammatizzazione rituale, escludendo qualsiasi scoria di superstizione. Le reiterate aggressioni subite in 250 anni da parte della Chiesa hanno reso inevitabile l’adozione di misure di difesa, sia disciplinari che dottrinali e dialettiche. Queste ultime sono talvolta sfociate in aperte ed esasperate polemiche, che di norma la Massoneria considera oggi inutili se non controproducenti, preferendovi l’adozione della ricerca del dialogo con il plurisecolare oppositore. Gli incontri tra massoni e teologi della chiesa si sono moltiplicati ovunque, specie nell’ultimo dopoguerra. Un esempio classico è costituito dal volume "Kirche und Freimaurer im Dialog", Chiesa e massoni in dialogo, pubblicato nel 1975 e scritto congiuntamente da un famoso Massone (Rolf Appel) e da un eminente teologo delegato dalla Chiesa (Herbert Vorgrimler), dopo oltre sei anni di intensi contatti tra loro. Vi vengono esposti ed evidenziati i moltissimi e significativi punti di contatto che accomunano le due istituzioni, arrivando a concludere che sono ormai maturate le condizioni per un definitivo avvicinamento. Secondo il Moramarco, si può ipotizzare che la realtà di una massoneria spesso profanizzata, abbia indotto i massoni più sensibili a rivolgersi con maggior forza alle radici della loro identità. Nel contempo, seguendo le linee guida che si è imposto da oltre un secolo, la legge della tolleranza si è intersecata con la legge psicologica junghiana della "enantidromia", ossia della convertibilità di un’istanza nel suo opposto. Il che spiega come in una Comunione talora cedevole al mito positivista siano poi fermentate idee barocche e leggendarie sul cosiddetto mistero massonico. Le diverse riviste massoniche ufficialmente edite nel tempo dal Grande Oriente d’Italia (Rivista Massonica, Hiram, Massoneria oggi), hanno pubblicato saggi metafisici (G. Rocchi), lavori poliedrici di Emilio Servadio, vari saggi sull’Induismo, sull’Ebraismo, sulla misteriosofia dei pellirossa (Carlo Gentile), sull’epopea babilonese di Gilgamesh, sulla morte e sul Pitagorismo. Una vera fiumana di autorevoli interventi, che dimostra un poderoso e crescente fermento d’interesse per la spiritualità. Un chiaro richiamo rivolto alla Comunione a rafforzare nel Tempio i legami ai più elevati valori dell’esistenza, i soli che possano contrastare i deleteri influssi materialistici che predominano nel mondo profano. Ne dovrà scaturire il massone nuovo, degno dei compiti che lo attendono nel 2000, soprattutto finalmente nell’effettiva condizione di pilotare l’Umanità verso le ineffabili mete dell’Era dell’Acquario (v.).
Massoneria e Stagioni: Il collegamento è esposto alla voce Stagioni e Massoneria (v.).