Thueri: Divinità egiziana, il cui nome geroglifico Ta-Uret significa La
Grande. Ha un corpo ibrido, con testa e tronco dell'ippopotamo femmina, zampe di leone
e coda di coccodrillo. Può anche avere testa di donna, ed essere coperta da un lungo velo
vaporoso. Il suo simbolo è il segno SA, nodo che esprime l'idea della protezione. Le sono
attribuiti anche l'Ankh ed il collare Menat. Chiamata anche l'Harem, la
dea T. incarna il concetto della fecondità acquatica. Protegge la donna durante la
gravidanza, il parto e l'allattamento, allontanando al contempo le forze del male dai
neonati. Nume tutelare del sonno (insieme al nano Bes), la dea T. scaccia i demoni maligni della notte. Per mettersi sotto l'influsso della sua magia, si debbono indossare amuleti verdi od azzurri. È presente al momento della nascita, e non manca mai nell'istante della morte. È decisamente simile alla divoratrice Sekhmet che sta ai
piedi della bilancia del giudizio, mangiatrice di anime, pronta a far ripiombare nella
materia quanti non sono ancora degni di far parte del paradiso di Osiride. "Ta-Uret,
tu sei la Madre che genera tutti gli dei".
Ti: Termine cinese frequente
nella tradizione misteriosofica orientale, avente il significato di terra , od anche di
Signore Supremo che governa. Corrisponde a Prakrti (v.) della tradizione induista.
Tiara: Nell’antica
Grecia era un alto copricapo di tessuto o di pelle, generalmente di forma conica e con
punte ripiegata (berretto frigio). Nelle raffigurazioni dei monumenti greci e romani
appare portata da personaggi storici o mitici di origine orientale (Persiani) o barbara in
genere (Traci e Sciiti). Segno di distinzione presso vari popoli dell’Oriente ed
attributo divino di Mitra (v.), nell’arte cristiana caratterizzò poi i Re Magi. La
T. venne anche designata con il nome del nastro di stoffa che la teneva fissata attorno
alla fronte (mitra, mitra). Nella liturgia cristiana ne
sono appunto derivate la mitra (v.) e la T. papale, usata dal pontefice
dall’VIII secolo come segno di autorità. Da Bonifacio VIII in poi questa viene anche
detta triregno (v.).
Tibie incrociate: Generalmente associate al teschio (v.), sono rappresentate in modo da formare una
croce obliqua o di Sant’Andrea (v.), simbolo della Perfezione e della Morte, sia
fisica che iniziatica. Alchemicamente sono connesse alla fase del processo in nero, o nigredo
(v.). Fanno parte della simbologia rappresentata nel Quadro di Loggia (v.) in Grado di
Maestro Massone.
Tichismo: Termine
derivato dal greco taiche, caso, indicante una teoria che
considera il caso come forza primaria agente nel Cosmo.
T’ien Ti: Espressione
del linguaggio misteriosofico cinese indicante la combinazione Cielo e Terra, considerati
generatori della vita nei suoi principi attivi maschili (v. Yang) e passivi femminili (v.
Yin).
T’ien: Termine
cinese che, nel linguaggio misteriosofico, indica il Cielo, sia in senso materiale e
fisico che come principio, origine primordiale dell’Universo.
Timkat: Termine che
definisce la massima festa religiosa degli etiopi falasha, una particolare branca
dell’ebraismo che adotta un testo sacro ebraico, denominato Kebra Nagast. Tale
festa, celebrata ogni anno il giorno 17 gennaio, vede come protagonista una sorta di
pietra considerata sacra, denominata Tabot (v.), oppure Tapet, o Theba.
Questa pietra, seconda la tradizione, rappresenta l’Arca dell’Alleanza
(v.). Ogni chiesa etiopica, da Axum al lago Tana, ne custodisce gelosamente una, nel Sancta
Sanctorum (v.). Essa viene maneggiata esclusivamente da sacerdoti particolari, ed è
sempre occultata agli occhi dei fedeli. In occasione dei festeggiamenti del T., essa viene
portata solennemente in processione, ma sempre nascosta da veli e paramenti sacri,
accompagnata da canti e danze dei sacerdoti e della popolazione.
Tipitaka: Termine
della lingua pali, che significa "Tre Canestri", indicante il
canone, ovvero la raccolta dei testi sacri del buddhismo Hinayana (v.). Codificato
nel terzo concilio di Pataliputra (245 a.C.) e risalente a non oltre il I secolo a.C.
nella forma giunta a noi. Il suo stile è scolastico, appesantito dalla ripetizione di
concetti e da enumerazioni. È formato da tre parti: il Vinaya-pitaka (Canestro
della disciplina), il Sutta-pitaka (Canestro degli insegnamenti) e l’Abbidhamma-pitaka
(Canestro della scolastica). Quest’ultimo costituisce la parte più recente del
canone, e comprende sette testi, tra i quali il più importante è il Kathavatthu,
in cui sono discusse e respinte le eresie. Il T., che è stato oggetto di vari commenti da
parte di Buddhaghosa (V secolo d.C.), uno dei massimi esponenti del buddhismo Hinayana,
costituisce il Vangelo buddhista di Ceylon, Birmania, Siam, Cambogia, Laos ed Indocina.
Tipo, Editto: Denominazione
dell’editto promulgato nel 648 in sostituzione della Ectesi (v.) dall’imperatore
d’Oriente Costante II. Con esso si proponeva di evitare i frequenti tumulti causati
dalla questione della doppia natura e della duplice volontà di Cristo, attraverso
l’abolizione delle libertà di parola e la comminazione della pena di morte.
L’editto T. venne condannato insieme con l’Ectesi da papa Martino I (649), che
lo ritenne un’invasione del campo religioso da parte dell’imperatore. Per
reazione Costanzo II ordinò l’arresto del pontefice, che morì in esilio a Cherson,
in Crimea.
Tirannia: Forma di
governo politico in cui i diritti dei cittadini sono usurpati dall’arbitrio di un
solo individuo. La T., nota agli antichi Greci, fu definita per la prima volta da un punto
di vista etico e politico da Platone ed Aristotele, come forma di degenerazione del regime
democratico. Nella T. si assommano i difetti del regime democratico e di quello
oligarchico: l’eccessiva libertà che porta i cittadini a lottare contro i
maggiorenti, e la brama di denaro che corrompe la cosa pubblica. Il concetto tende a
venire staccato dal piano dell’etica, e definito giuridicamente dai Romani. Cicerone
afferma che la T., attribuendo la summa potestas ad un solo individuo, annulla il vinculum
iuris che stringe i cittadini in una comunità giuridica, e mina alle basi la stessa
convivenza sociale. Questa base della concezione classica rimane valida fin oltre il
medioevo. Si arricchisce della distinzione tra la Tyrannis tituli, ossia il governo
usurpato e privo quindi di legittimazione giuridica, e la T. regiminis, ovvero il
governo oppressivo di chi è peraltro legittimo sovrano. Tale distinzione è ripresa da
Coluccio Salutati e Mario Salamonio, che collegano il potere del principe
all’espressione della volontà popolare, la lex imperii. Il problema se sia
legittima l’uccisione del tiranno (tirannicidio) qualora questi esca dai
limiti della lex imperii impostagli dai cittadini, occupa gran parte della
trattazione rinascimentale e della Riforma (v.).
Tnetopsichite: Termine
di derivazione greca, che significa "morte dell’anima", ed indica la
teoria secondo cui l’anima muore con il corpo, per poi risorgere quando quello
risuscita. Secondo il Suzuki (Psicoanalisi e buddhismo Zen, Ediz. Astrolabio,
1968), "La grande morte è l’ego che muore a sé stesso nella sua radicale
negatività. Non riguardabile in alcun senso come un contingente distruggersi o spirare,
nichilisticamente, in uno squallido vuoto o nel nulla, quest’improvvisa spaccatura,
quest’improvviso ribaltamento, sono piuttosto la rottura e l’eliminazione della
contraddizione, dell’abisso, dell’aporia. L’annullamento e la negazione
della negatività ultima sono in sé stesse positive. La dissoluzione negativa è nello
stesso tempo una risoluzione positiva. L’Ego negato, in quanto Ego, nella sua
contraddizione centrale della coscienza dell’ego, persegue attraverso siffatta
negazione, positivamente ed affermativamente, la sua risoluzione e la sua realizzazione.
Nel morire a sé stesso in quanto Ego, nasce e si ridesta al suo Sé in quanto Sé"
(v. anche Reincarnazione, Morte mistica).
Tobia: Nome di due
protagonisti del libro biblico omonimo (Libro di T.) deuterocanonico, padre e
figlio, detto anche Tobiolo (VIII secolo a.C.). T. il Vecchio, della tribù di Naftali
(come Hiram, v.), deportato a Ninive con la moglie ed il figlio (II Re 15, 29),
rimase fedele a Dio, distinguendosi per la propria pietà e bontà. Diventato cieco e già
desideroso di morire, mandò il figlio T. a ritirare un deposito nella città di Rages.
Durante il viaggio il figlio, con l’aiuto dell’arcangelo Raffaele, riuscì a
liberare Sara, figlia di Raguel, dal demonio Asmodeo, e la sposò. Ritornato a casa,
restituì la vista al padre con il fegato di un pesce catturato nel Tigri. Il Libro di
T., romanzo storico con carattere didattico, per le evidenti influenze persiane, è stato
attribuito al IV secolo a.C. e ad un autore esilico. Scritto in ebraico od aramaico, ci è
però pervenuto in edizione greca. Frammenti in ebraico ed aramaico del Libro di T.
sono stati rinvenuti tra i manoscritti del Mar Morto (v.).
Toccamento: Segno
non palese dato con una particolare forma di stretta di mano, con il quale il Libero
Muratore si fa riconoscere da un altro Fratello ogni qual volta gli viene richiesto di
farlo. I T. sono diversi a seconda del grado massonico ricevuto. Generalmente il T. viene
seguito dalla parola sacra. Secondo gli studiosi, nei tempi antichi i T. rituali avrebbero
rivestito un’importanza non soltanto psicologica ma anche fisiologica, in quanto
avrebbero consentito l’attivazione e l’orientamento delle forze di natura
psichica; si deve quindi presumere che chi a suo tempo ha introdotto l’impiego del
T., doveva anche essere profondo conoscitore delle forze psichiche, nonché dei punti
fisici attraverso cui tali forze penetrano più agevolmente nell’organismo umano (v.
Agopuntura).
Tolleranza: Capacità
di sopportare ciò che è o potrebbe rivelarsi sgradevole o dannoso. Disposizione d'animo
per la quale si ammette, senza palesare alcuna contrarietà, che un altro professi
un'idea, un'opinione, una religione diversa od addirittura contraria alla nostra. Y (Massoneria) La T. nei confronti degli altri uomini è una
predisposizione interiore dell'uomo. In quanto tale presenta sempre un carattere di
soggettività e di contingenza, dovendo rispecchiare la volontà dei singoli individui. La
T. rispecchia anche la qualificazione interiore dell'uomo. Un uomo veramente libero è
colui che riconosce agli altri la stessa libertà che invoca per se stesso. La T. comporta
un profondo rispetto per il desiderio di manifestazione degli altri esseri viventi. Essere
tolleranti non comporta comunque una limitazione alla possibilità di manifestare e di
proporre i propri punti di vista, ai quali corrispondono sempre valori interiori. La T.
implica invece il superamento degli antagonismi nelle manifestazioni dei punti di vista
degli uomini. I termini di giudizio assoluti, come verità e falsità, non dovrebbero mai costituire motivo di impedimento per la comprensione delle ragioni profonde che sono alla base delle manifestazioni. È la prima ed essenziale virtù
caratteristica di ogni buon Massone (v. Trinomio).
Tomismo: Indirizzo
filosofico che riprende e sviluppa le dottrine di Tommaso d’Aquino. Dopo la morte di
Tommaso la sua dottrina, osteggiata dalle correnti dominanti dell’agostinismo
francescano, viene difesa e studiata solo all’interno dell’Ordine domenicano,
fino a diventarne la teoria ufficiale. I due più noti commentatori dell’opera di
Tommaso furono Tommaso de Vio, detto il Gaetano, e Francesco Silvestri, detto il
Ferrarese, autori rispettivamente di un commento alla Summa theologica ed alla Summa
contra Gentiles (1523-1524). Dopo la metà del XVI secolo il T. cessa di essere la
dottrina esclusiva dei Domenicani e viene ripreso, in forma creativa, dalla Compagnia di
Gesù. I maggiori rappresentanti del T. diventano il Molina, il Suarez ed il Bellarmino.
Il contrasto tra il T. rigido dei Domenicani e quello moderato dei Gesuiti si accentua nel
corso del XVII e del XVIII secolo, ma può essere considerato una stanca continuazione
della Scolastica. Una ripresa del T. si ha nell’Ottocento, per impulso di papa Leone
XIII, che lo ripropone come filosofia cattolica in contrasto polemico con le ideologie
dominanti del liberalismo, dell’idealismo e soprattutto del marxismo.
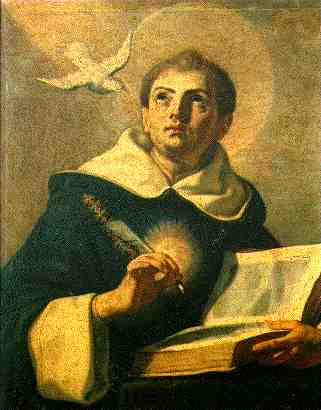 Tommaso d'Aquino: (1225-1274) Nacque
intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, presso l'abbazia di Monte Cassino, da famiglia
antica e nobile. Il padre Landolfo, era conte di famiglia longobarda, e la madre Teodora,
contessa di famiglia normanna di Napoli. Nel 1236 venne presentato, come oblato,
all'abbazia benedettina di Montecassino, dove iniziò gli studi. Nel 1239 si allontanò
dall'abbazia dopo che il luogo sacro era stato trasformato in fortezza militare da
Federico II, durante la lotta contro il papa Gregorio IX. Nel 1240 la famiglia lo mandò
presso l'Università di Napoli per il completamento degli studi letterari e per
l’inizio di quelli filosofici; per gli studi di grammatica e logica ebbe come maestro
Martino di Dacia, per quelli delle scienze naturali e della metafisica, Pietro d'Irlanda.
Tra il 1242-43 abbracciò la vita religiosa ed entrò come novizio nell'ordine di San
Domenico, contro la volontà della sua famiglia. Nel 1244 fallì il suo tentativo di
raggiungere Parigi insieme con Giovanni Teutonico, maestro generale dell'Ordine, proprio a
causa delle minacce della famiglia che non condivideva la sua vocazione. Catturato dai
fratelli presso Acquapendente in Toscana, venne rinchiuso nel castello di San Giovanni in
Roccasecca, dove rimase prigioniero un anno. Nel 1245 fuggì per recarsi a Parigi, dove
seguì i corsi di teologia di Alberto Magno, con il quale si recò poi a Colonia. Nel
1248, di ritorno da Colonia, fu ordinato sacerdote. Nel 1252 si recò nuovamente a Parigi,
dove iniziò la carriera accademica e scrisse un saggio in difesa degli ordini mendicanti,
contro i quali avevano lanciato i loro strali i professori della Sorbona, primo fra tutti
Guglielmo di Sant' Amore, canonico di Beauvais. Tra il 1252-1254 fu baccelliere biblico
dello Stato generale domenicano, nel convento di San Giacomo a Parigi. Tra il 1254-1256 fu
sentenziario. Nel 1256 ebbe inizio il suo insegnamento ordinario presso lo studio generale
di Parigi, che terrà fino al 1259, anno in cui figura come membro della commissione per
l'ordinamento degli studi dell'ordine domenicano. Alla corte papale si incontra con
Guglielmo di Moerbeke, valente grecista, il quale gli prepara un testo latino di
Aristotele più aderente al greco, in modo che egli possa approfondire il pensiero
autentico di quel filosofo. Nel 1259 rientrò in Italia dove permase fino al 1268. Fu
nominato teologo della Curia papale, e fu invitato da papa Urbano IV (1261-1264) a
comporre un "elogio" per solennizzare la festa del SS. Sacramento istituita dal Papa. Nel 1269 ritornò a Parigi in qualità di maestro di teologia, e si dedicò all'insegnamento ed alla predicazione. Tra il 1272-1274 rientrò in Italia. Su pressante istanza di Carlo d'Angiò, il Capitolo Generale dell'ordine lo inviò a Napoli, in qualità di direttore della facoltà di teologia presso l'università di quella città. T. fu anche a Salerno, dove tenne una serie di lezioni straordinarie ed un corso di conferenze, nella celebre scuola medica che aveva sollecitato l'onore e il decoro del Santo. Nel 1273 papa Gregorio X lo invitò a partecipare ad un Concilio generale convocato a Lione, con lo scopo di appianare le controversie tra la Chiesa romana e i greci scismatici. All’inizio del 1274, durante un viaggio verso Lione, si ammalò gravemente e venne portato all'abbazia cisterciense di Fossanova di Priverno, nella diocesi di Terracina, dove morì il 7 marzo dello stesso anno. Dante avanzò l'ipotesi che fosse fatto morire per veleno dallo stesso Carlo d'Angiò: "Carlo venne in Italia e, per
ammenda, vittima fè di Curradino; e poi rispinse al ciel Tommaso, per ammenda...
(Purg. 67-69)" - (ovvero Carlo I d'Angiò venne in Italia e, per fare ammenda, fece
di Corradino di Svevia una vittima; quindi, sempre per fare ammenda, rimandò in cielo T.
con il veleno ...). Nel 1277 il vescovo di Parigi condannò 21 Proposizioni tratte
dalle opere di T., per il loro accentuato razionalismo e naturalismo. Nel 1323 San T. fu
canonizzato da papa Giovanni XXII. Durante il concistoro il Pontefice sostenne che non era
stato necessario ricercare i miracoli che T. aveva potuto operare in vita, ma che
occorreva tenere ben presente il modo con cui aveva risolto mirabilmente tante spinose
questioni della Chiesa. Nel 1567 papa Pio V dichiarò T. dottore della Chiesa. Nel 1888
Leone XIII dichiarò San T. patrono delle scuole cattoliche. Le sue opere maggiori sono:
(1253-55) - Commento ai 4 libri delle Sentenze; (1258-62) - Summa contra
Gentiles scritta su richiesta di Raimondo di Penafort per esigenze missionarie;
(1266-68) - Summa theologica: si suddivide in quattro parti: la prima tratta di Dio
in sé e come principio di tutte le cose, e di Dio come causa prima delle creature; la
seconda tratta del movimento della creatura ragionevole verso Dio e dell'influsso di Dio
sul movimento da regolare per mezzo della legge e da sorreggere con la Grazia; la terza,
tratta di Gesù Cristo, della Sua Persona, della vita e delle opere, dei Sacramenti, fino
a quello della Penitenza. L'opera è rimasta incompiuta; (1256-1268) - Quaestiones
disputatae: commenti alla Sacra Scrittura; (1259-69) - Isaia, Geremia, Giobbe e
Canticum Canticorum; (1256-59) San Matteo (i suoi commenti a Marco, Luca e
Giovanni sono andati perduti); (1270-72) Salmi; (1272-73) Epistolae Paulinae;
(1265-67) Catena aurea in Marco, Luca, e Giovanni, ed infine i Commenti ad
Aristotele.
Tommaso d'Aquino: (1225-1274) Nacque
intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, presso l'abbazia di Monte Cassino, da famiglia
antica e nobile. Il padre Landolfo, era conte di famiglia longobarda, e la madre Teodora,
contessa di famiglia normanna di Napoli. Nel 1236 venne presentato, come oblato,
all'abbazia benedettina di Montecassino, dove iniziò gli studi. Nel 1239 si allontanò
dall'abbazia dopo che il luogo sacro era stato trasformato in fortezza militare da
Federico II, durante la lotta contro il papa Gregorio IX. Nel 1240 la famiglia lo mandò
presso l'Università di Napoli per il completamento degli studi letterari e per
l’inizio di quelli filosofici; per gli studi di grammatica e logica ebbe come maestro
Martino di Dacia, per quelli delle scienze naturali e della metafisica, Pietro d'Irlanda.
Tra il 1242-43 abbracciò la vita religiosa ed entrò come novizio nell'ordine di San
Domenico, contro la volontà della sua famiglia. Nel 1244 fallì il suo tentativo di
raggiungere Parigi insieme con Giovanni Teutonico, maestro generale dell'Ordine, proprio a
causa delle minacce della famiglia che non condivideva la sua vocazione. Catturato dai
fratelli presso Acquapendente in Toscana, venne rinchiuso nel castello di San Giovanni in
Roccasecca, dove rimase prigioniero un anno. Nel 1245 fuggì per recarsi a Parigi, dove
seguì i corsi di teologia di Alberto Magno, con il quale si recò poi a Colonia. Nel
1248, di ritorno da Colonia, fu ordinato sacerdote. Nel 1252 si recò nuovamente a Parigi,
dove iniziò la carriera accademica e scrisse un saggio in difesa degli ordini mendicanti,
contro i quali avevano lanciato i loro strali i professori della Sorbona, primo fra tutti
Guglielmo di Sant' Amore, canonico di Beauvais. Tra il 1252-1254 fu baccelliere biblico
dello Stato generale domenicano, nel convento di San Giacomo a Parigi. Tra il 1254-1256 fu
sentenziario. Nel 1256 ebbe inizio il suo insegnamento ordinario presso lo studio generale
di Parigi, che terrà fino al 1259, anno in cui figura come membro della commissione per
l'ordinamento degli studi dell'ordine domenicano. Alla corte papale si incontra con
Guglielmo di Moerbeke, valente grecista, il quale gli prepara un testo latino di
Aristotele più aderente al greco, in modo che egli possa approfondire il pensiero
autentico di quel filosofo. Nel 1259 rientrò in Italia dove permase fino al 1268. Fu
nominato teologo della Curia papale, e fu invitato da papa Urbano IV (1261-1264) a
comporre un "elogio" per solennizzare la festa del SS. Sacramento istituita dal Papa. Nel 1269 ritornò a Parigi in qualità di maestro di teologia, e si dedicò all'insegnamento ed alla predicazione. Tra il 1272-1274 rientrò in Italia. Su pressante istanza di Carlo d'Angiò, il Capitolo Generale dell'ordine lo inviò a Napoli, in qualità di direttore della facoltà di teologia presso l'università di quella città. T. fu anche a Salerno, dove tenne una serie di lezioni straordinarie ed un corso di conferenze, nella celebre scuola medica che aveva sollecitato l'onore e il decoro del Santo. Nel 1273 papa Gregorio X lo invitò a partecipare ad un Concilio generale convocato a Lione, con lo scopo di appianare le controversie tra la Chiesa romana e i greci scismatici. All’inizio del 1274, durante un viaggio verso Lione, si ammalò gravemente e venne portato all'abbazia cisterciense di Fossanova di Priverno, nella diocesi di Terracina, dove morì il 7 marzo dello stesso anno. Dante avanzò l'ipotesi che fosse fatto morire per veleno dallo stesso Carlo d'Angiò: "Carlo venne in Italia e, per
ammenda, vittima fè di Curradino; e poi rispinse al ciel Tommaso, per ammenda...
(Purg. 67-69)" - (ovvero Carlo I d'Angiò venne in Italia e, per fare ammenda, fece
di Corradino di Svevia una vittima; quindi, sempre per fare ammenda, rimandò in cielo T.
con il veleno ...). Nel 1277 il vescovo di Parigi condannò 21 Proposizioni tratte
dalle opere di T., per il loro accentuato razionalismo e naturalismo. Nel 1323 San T. fu
canonizzato da papa Giovanni XXII. Durante il concistoro il Pontefice sostenne che non era
stato necessario ricercare i miracoli che T. aveva potuto operare in vita, ma che
occorreva tenere ben presente il modo con cui aveva risolto mirabilmente tante spinose
questioni della Chiesa. Nel 1567 papa Pio V dichiarò T. dottore della Chiesa. Nel 1888
Leone XIII dichiarò San T. patrono delle scuole cattoliche. Le sue opere maggiori sono:
(1253-55) - Commento ai 4 libri delle Sentenze; (1258-62) - Summa contra
Gentiles scritta su richiesta di Raimondo di Penafort per esigenze missionarie;
(1266-68) - Summa theologica: si suddivide in quattro parti: la prima tratta di Dio
in sé e come principio di tutte le cose, e di Dio come causa prima delle creature; la
seconda tratta del movimento della creatura ragionevole verso Dio e dell'influsso di Dio
sul movimento da regolare per mezzo della legge e da sorreggere con la Grazia; la terza,
tratta di Gesù Cristo, della Sua Persona, della vita e delle opere, dei Sacramenti, fino
a quello della Penitenza. L'opera è rimasta incompiuta; (1256-1268) - Quaestiones
disputatae: commenti alla Sacra Scrittura; (1259-69) - Isaia, Geremia, Giobbe e
Canticum Canticorum; (1256-59) San Matteo (i suoi commenti a Marco, Luca e
Giovanni sono andati perduti); (1270-72) Salmi; (1272-73) Epistolae Paulinae;
(1265-67) Catena aurea in Marco, Luca, e Giovanni, ed infine i Commenti ad
Aristotele.
Tommaso
Moro: Nome
derivato da Thomas More, statista ed
umanista inglese, santo della Chiesa Cattolica (1478-1535). Amico e
corrispondente di Erasmo da Rotterdam (v.), fu uno degli esponenti della
Controriforma (v.). Scrisse l'Utopia
(1516), un trattato dialogico in cui si satireggiano le condizioni sociali e
politiche inglesi, confrontandoli con uno stato ideale, organizzato su basi
comunitarie e retto dai princìpi della ragione e della tolleranza. La sua fu
una brillante carriera politica, avendo ricoperto le cariche di ambasciatore e
speaker ufficiale, e di presidente della Camera dei Comuni. Il re Edoardo VIII
(v.) lo nominò cancelliere del regno (1529), primo laico a ricoprire tale
carica. Per alcuni anni fu tra i maggiori artefici della politica reale, ma non
volle pronunciarsi a favore del sovrano sulla questione dell'annullamento del
matrimonio con Caterina d'Aragona, l'evento che divise il re dal papa. Per
questo rassegnò le proprie dimissioni nel 1532. Inquisito per false e vaghe
accuse di tradimento, si rifiutò di approvare l'Atto di Supremazia del 1534,
che definiva formalmente lo scisma della nuova Chiesa anglicana da quella di
Roma. Fu quindi rinchiuso nella Torre di Londra con il cardinale J. Fisher, dove
dopo un anno fu condannato a morte e decapitato. Nel 1886 venne beatificato da
papa Leone XIII, e nel 1935 papa Pio XI lo canonizzò.
Torah: Termine ebraico
avente il significato di legge. Lo si trova nei testi biblici vetero-testamentari, ed è
espressione della costante volontà divina nei riguardi dell'uomo, e quindi norma
insostituibile di ogni rapporto dell'uomo con Dio. Dopo l'esilio babilonese, con T. si
designava semplicemente la legge mosaica (v. Tavole della Legge). Nei testi biblici
neotestamentari, con lo stesso termine si designa il Pentateuco (v.) e, per esteso,
tutti gli altri libri dell'Antico Testamento. Più in particolare di norma e per
consuetudine si riferisce al solo Decalogo.
Tornata: Termine
massonico indicante una seduta di Lavoro rituale. Può essere ordinaria, ovvero compresa
come data ed ordine del giorno nel Programma annuale dei Lavori, oppure Straordinaria. I
due casi sono regolamentati dal Regolamento dell'Ordine, rispettivamente agli Artt. 51 e
52.
Toro: L'animale che per
lunghi millenni è stato considerato sacro. L'origine del suo culto risale al 4500 a.C.,
nell'Asia minore. Lo si trova venerato nelle religioni sumera, assira, babilonese,
persiana, greca ed egizia (v. Apis).Per i cretesi era l'identificazione di Zeus che, per
sedurre la ninfa Europa, assunse le sembianze di un T. bianco. Celti e Galli gli
dedicavano sacrifici, mentre gli scandinavi lo adoravano nel loro tempio di Uppsala. Nel
culto di Mitra, di origine persiana, era considerato la fonte della vita, ed al suo
sacrificio si doveva l'origine della creazione, in quanto si pensava che dal suo sangue
fossero germogliate le piante e nate tutte le creature viventi. Indra, il potente e sagace
re degli dei vedici, è paragonato ad un T. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, a, alef, significa T., ed è il simbolo della Luna durante la
prima settimana del suo ciclo. Il T. fu considerato sacro anche dai seguaci di Maometto,
perché lo credevano creato dalla polvere sollevata dagli zoccoli del cavallo
dell'arcangelo Gabriele. Il suo glifo è B, è il secondo segno dello Zodiaco ed appartiene all'elemento Terra. Il sole vi si trova fra il 21 aprile ed il 20 maggio, durante il secondo mese di primavera. È simbolo della tolleranza, del lavoro, dell'obbedienza, della forza e della materia prima. È un segno associato alla simbologia della materia primordiale, molto particolare, magnetico e medianico, decisamente possessivo. Vi si riscontrano caratteristiche di laboriosità e di pazienza. Sensitivo, è perseverante e calmo. Nel contempo è testardo ed egoista, poco coraggioso e materialista, in quanto tende a soddisfare il desiderio del possesso; ama la natura e la bellezza, la musica e la vita. Leale ed ambizioso, non ama lanciarsi in speculazioni ardite perché è realista e non difetta di buon senso. Semplice e pratico, un po’ presuntuoso ed a volte ostinato, è un insicuro, più fragile di quanto appaia essere. La sua innata insicurezza, unita al suo desiderio di possesso, spesso si tramuta in irragionevole gelosia. Perciò tende a cercare un partner paziente, sereno, ma soprattutto fedele. Sa infondere e donare calore. Ottimo lavoratore, è più amante della montagna e della campagna che del mare e della città. Nei meno evoluti può evidenziarsi non il tipico spirito combattivo, ma una carica di violenza. Nei più evoluti invece si trova dolcezza e sensibilità, raziocinio e capacità tecniche, creatività ed amore per l’arte. Piuttosto egocentrici, tendono a far ruotare il mondo intorno a loro. Amano molto la buona tavola. I nati sotto questo segno sono sostanzialmente diffidenti e lenti ad apprendere e ad accettare qualsiasi idea, ma quando l’hanno fatta propria non se ne discostano più, difendendola con accanimento. Se deluso da qualcuno è incapace di perdono, e tronca di netto ogni rapporto. Fondamentalmente molto paziente, è capace di collere terribili, che sono però di breve durata. Circoscrive le sue esperienze nell’ambito familiare, e segue i valori tradizionali. L’affettività è tenera e dolce, la possessività è notevole; non si irrita facilmente, e rumina le proprie inquietudini, pur presentando spesso caratteristiche di adattabilità. In amore è di temperamento passionale ed emotivo. Da bambino non è molto curioso né capriccioso. Psichicamente fragile, ubbidisce senza troppe proteste e discussioni, subendo anche le angherie eventuali dei fratelli: le sue esperienze infantili determineranno comunque i suoi futuri atteggiamenti. Molto affettuoso, un po’ permaloso ma paziente, è poco interessato al mondo circostante perché gli piace vivere accanto ai genitori, da cui si sente protetto. Da adulto il rapporto con la famiglia sarà sempre molto importante. La gioia di vivere è intensa, il temperamento generoso e vitale, con doti di pazienza e costanza; potrà saziarsi sia di passione che di estremo interesse per la professione prescelta, a cui si dedica con forza e perseveranza.
Totem: Derivazione di una
voce nord-americana degli indigeni Ojibway. Il termine usato da una tribù degli Algonkini
è la corruzione della parola tototeman, che significa parente, nel senso di
stretta consanguineità. Indica il legame di parentela che un certo gruppo etnico sente di
possedere con un animale, ma anche con una pianta od altro, che funge da capostipite di
tutti gli esseri appartenenti al gruppo, ma anche degli esseri della specie del T.
medesimo. In alcune tribù australiane e nella maggior parte delle tribù indiane
dell’America settentrionale, ogni individuo intrattiene personalmente con una
determinata cosa un rapporto paragonabile a quello che ogni clan intrattiene con il
proprio T. (v. Totemismo).
Totemismo: Derivazione
di totem, indica un complesso di credenze, usi, regole sociali, obblighi e divieti,
fondati sull’esistenza di un particolare rapporto di parentela, e quindi di reciproca
protezione, tra un gruppo od un individuo ed una specie di animali, piante, fenomeni
naturali, ecc. Vincoli di parentela si stabiliscono tra discendenti umani e non umani del totem,
chiamato fratello, padre o nonno; è rigorosamente vietato ucciderlo, danneggiarlo o
mangiarlo. La più diffusa forma di T. è quella di clan, estensione della famiglia
coniugale e raggruppamento di parentela unilaterale, costituito da varie famiglie, i cui
membri sono legati da un unico capostipite dal quale discendono in linea paterna o
materna. Se due gruppi hanno lo stesso totem, si ritengono tra loro strettamente
imparentati ed evitano matrimoni tra loro per non contrarre rapporti tra consanguinei (v.
esogamia). Di qui la connessione tra il totem ed il tabù (v.), confermata dalla
cessazione periodica del divieto di toccare il totem, come nella festa australiana Intichinma
(pasto sacrificale del totem). Molte tribù collocano, davanti alle capanne delle singole
famiglie, grossi pali con scolpite le immagini degli antenati del clan. Questi pali
costituiscono una specie di albero genealogico, le cui figure vanno lette dal basso verso
l’alto, ovvero dai parenti più prossimi fino al capostipite. Il T. di clan, che per
i contatti con civiltà superiori si è spesso affievolito trasformando i totem in un
simbolo puramente decorativo, ebbe particolare diffusione nell’America
settentrionale, in Africa, in Oceania ed in Asia. Dopo l’introduzione del termine T.
ad opera di J. Long (1791) ed i primi studi informativi, dal 1870 si ebbe una serie di
lavori sistematici sul fenomeno: F. McLennan descrisse per primo il sistema totemico
avanzando l’ipotesi, ripresa e sviluppata da W.R. Smith, dell’universalità del
fenomeno nelle società primitive; H. Spencer mise in relazione il T. col culto degli
antenati, affermando che l’aspetto del totem deriverebbe dai nomignoli attribuiti
agli antenati; J.G. Frazer, limitando la diffusione del T. come sistema sociale complesso,
sostenne la cosiddetta teoria concezionale, e legò il fenomeno del T. alla magia, ponendo
il T. come religione originaria di tutta l’umanità. In seguito si ebbe una seconda
fase di studi, grazie alla scuola storico-culturale che, sulla base di nuove ricerche
etnologiche, cercò di formulare una teoria compiuta del T. Una terza fase, avviatasi nel
1940, è caratterizzata dal tentativo di definire le diverse forme di T., le loro origini
ed i loro rapporti con la religiosità. Più recentemente l’antropologo A.R.
Radcliffe-Brown ha dimostrato (1951) come nei racconti di animali il mondo della vita
animale è rappresentato in termini di relazioni sociali simili a quelle della società
umana; attraverso l’uso di questi simboli animali, presentati in connessioni
socialmente rilevanti, il pensiero è allo stesso tempo diretto sia verso le relazioni tra
animali che verso le relazioni tra gruppi umani. C. Lévi-Strauss ha cercato di allargare
tale concetto (1962): siamo di fronte ad un sistema di pensiero che si riferisce a tutte
le categorie di fenomeni sociali, come valori ed eventi.
Tracciare: In gergo
massonico è sinonimo di scolpire, e significa scrivere. Comunemente
riferito ad una Tavola (v.), ovvero ad un Lavoro eseguito da un adepto a beneficio proprio
e dell'Officina.
Traditi Humilitati: Denominazione dell’enciclica emessa il 24 maggio 1829, con la quale il papa
Pio VIII riconfermò la validità della scomunica (v.) comminata alla Massoneria.
Tradizione: Termine
che indica la trasmissione vivente dell’eredità tecnica o culturale di un popolo, di
generazione in generazione. In filosofia il valore della T., riferita al dominio
filosofico od a quello teologico, è affermato fin dai tempi più antichi. Da Aristotele a
Plotino ed oltre, la T., spoglia di ogni elemento mitologico, costituisce il fondamento
della verità filosofica, al punto che dottrine moderne vengono spesso legittimate con il
crisma della T. mediante documenti apocrifi. Nell’ambito della teologia cattolica,
l’idea di T. è legata a quella della rivelazione, che suppone l’esistenza di
un’autorità dotata di magistero e di infallibilità in questo campo. L’età
moderna ha reagito, sia in campo scientifico che filosofico, a questa mentalità
tradizionalistica, e tale opposizione si è manifestata nella forma più estrema
nell’Illuminismo, dove la T. non è affatto garanzia di verità, ma fonte di errore e
di superstizione. Non la T., ma la ragione individuale, deve giudicare della verità
storica. Una migliore comprensione del significato della T. si ha con il romanticismo, che
torna a rivalutare la T. nell’ambito dell’esperienza spirituale di un popolo. La
T. non va concepita come qualcosa di statico o di meccanico, ma come un continuo
rinnovamento ed una costante rifondazione della esperienza storica. La T. viene inserita
nelle strutture fondamentali della contemporaneità storica, in quanto suppone una
dialettica vivente tra presente e passato, anziché una rigida giustapposizione.
Nell’ambito strettamente religioso, la T. consiste nella trasmissione del contenuto
della rivelazione anche al di fuori delle fonti religiose scritte. Concetto di particolare
rilevanza nella religione cattolica, dove costituisce la fonte della rivelazione divina
insieme alla Sacra Scrittura, in quanto trasmissione orale di verità attraverso il
magistero infallibile della Chiesa assistita dallo Spirito Santo. Nel cristianesimo
primitivo l’importanza della T. fu affermata in base all’insegnamento orale del
Cristo, ed al compito della predicazione assegnata agli apostoli (Matteo 28, 18-20;
Marco 16, 15-16) cui è promesso l’invio dello Spirito perché li assista.
L’insegnamento degli apostoli fu perciò riguardato come un necessario completamento
delle notizie scritte sulla vita e sulla predicazione di Gesù (Giovanni 21, 25);
nelle lettere di Paolo si sottolinea l’importanza della comunicazione orale per una
esauriente conoscenza della verità e della pratica cristiana. I Padri della Chiesa in
lotta contro le eresie, si richiamarono alla T. come norma di fede e criterio di
interpretazione delle Sacre Scritture, laddove il testo si presenta reticente o non
sufficientemente chiarito. Ireneo (Adversus haereses) si appellò alla T. di tutte
le chiese di origine apostolica, ma soprattutto a quella romana. Tertulliano (De
praescriptione haereticorum) esaltò il valore della T. apostolica contro le tesi
eretiche. Anche Agostino si pronunciò più volte a favore della T., tanto che dal V
secolo la sua autorità come fonte di interpretazione è accettata in oriente ed in
occidente. Lo scisma tra le due chiese (1054) non mutò la situazione, anche se la chiesa
d’Oriente riconobbe come organo di trasmissione della T. solo i vescovi. Soltanto nel
tardo Medioevo si ebbero confutazioni del valore della T. da parte di Wycliff, e più
tardi da parte dei riformatori protestanti: la negazione dell’autorità della chiesa
portò ad una svalutazione delle testimonianze della T., mentre venne riaffermata
l’unicità della Sacra Scrittura come fonte delle verità rivelate. Questa tesi,
fatta propria da tutto il movimento protestante, venne respinta dal concilio di Trento,
che mise sullo stesso piano l’autorità documentaria della T. e quella della Bibbia.
Più tardi tale posizione venne ribadita dal concilio Vaticano I. Oggi la teologia
protestante, pur dando priorità di valore alle fonti bibliche, ha attenuato la sua
posizione, riconoscendo la ricchezza di testimonianze tramandata dalla T. (Culmann e
seguaci del metodo delle forme). Gli studiosi cattolici a loro volta hanno esteso il
concetto di T., superando gli atti ufficiali, gli scritti ed il magistero della Chiesa,
alla vita concreta delle comunità cristiane nella loro esperienza storica. Da qui
discendono alcune distinzioni: la T. può essere divino-apostolica (quando deriva
direttamente da Cristo e dagli apostoli), ecclesiastica (cioè di età post-apostolica),
dogmatica (quando propone verità da credere), morale (quando sancisce norme da
osservare), costitutiva (quando fa conoscere verità non espressamente contenute nella
Bibbia), interpretativa (quando aiuta ad interpretare correttamente verità implicitamente
o succintamente presentate nella Bibbia). Y (Massoneria) La
definizione del significato del termine T. impone un particolare esame. Normalmente esso
viene inteso come un qualcosa che ci viene tramandato, generalmente non per iscritto,
dalle generazioni precedenti. La T. contiene verità di solito non documentabili, relative
a moltissimi argomenti. Una simile interpretazione è però troppo generica e si presta a
numerose e giustificabili critiche, in quanto tende a spostare l'attenzione sul tempo
passato ed a privilegiare un aspetto storico, di solito non documentabile. Molto più
importante, soprattutto sul piano esoterico, appare essere l'interpretazione esistenziale.
In ogni tempo l'uomo è sempre nel medesimo rapporto con la vita. Perciò quello che si
tramanda non è tanto il contenuto delle esperienze vissute da altri esseri umani, quanto
il loro modo di porsi di fronte alla vita stessa. La T. tramanda la testimonianza di
esperienze esistenziali, che non possono essere oggetto di descrizioni. Attraverso la
testimonianza si propone all'attenzione del tempo presente qualcosa già vissuto da altri,
ma ancora percepibile in modo analogo dall'attuale essere umano.
Traducianismo: Opinione
teologica secondo la quale l’anima viene trasmessa dai genitori mediante la
generazione. Le si oppone il creazionismo, che introduce nell’atto il diretto
intervento divino. Tertulliano (De anima 27) sostenne un T. a sfondo
materialistico. Agostino (De genesis ad litteram 10, 11-26) fu incerto tra T. e creazionismo,
mentre Tommaso (e con lui la scolastica) condannò il T. in ragione della pura
spiritualità dell’anima. Lutero vide nel T. una teoria di appoggio alla sua
concezione del peccato originale, mentre Calvino le fu contrario. Leibniz (v.) tentò di
conciliare T. e spiritualità dell’anima superando il dualismo cartesiano. Tracce di
T. si ritrovano nel XIX secolo in autori come H. Klée, J. Froschammer, N.S. Laforet ed A.
Rosmini. Il creazionismo, in opposizione al T., è stato confermato, da parte
cattolica, dallo stesso pontefice Pio XII, nell’enciclica Humani generis
(1950).
Transustanziazione: Dottrina propria della teologia cattolica riguardante il problema della reale
presenza di Cristo nell’Eucarestia, sotto la specie apparente del pane e del vino. La
T. si differenzia da ogni altro tipo di trasformazione o mutazione sostanziale: in essa
non ha infatti luogo una permanenza (nel divenire) dell’elemento sostanziale, bensì
delle determinazioni accidentali. Si ha una singolare mutazione, che interessa tutta la
sostanza del terminus a quo, rispetto al terminus ad quem, con la permanenza
delle species (apparenze) o determinazioni accidentali del primo.
All’eccessiva scolasticizzazione (risalente alla teologia tomista) del dogma, Lutero
reagì negando la presenza reale, ed affermando una pura presenza simbolica del cristo nel
pane, od una sorta di companazione od impanazione del Cristo con la specie
eucaristica.
Trascendentale: Principio
che conviene universalmente ai contenuti dell'esperienza, e che perciò li trascende. Se
questi contenuti si ordinano, aristotelicamente, in generi sommi o categorie, T. si
contrappone a categoriale. Se invece, kantianamente, tali contenuti sono
considerati come la materia del conoscere o come dati dell'esperienza, T. si contrappone
ad empirico. Kant è il primo a definire in questo senso moderno la nozione di T.,
criticando la concezione classica che presentava una duplice limitazione: 1) di ridurre il
T. ad un semplice concetto logico-formale; 2) di considerare tale concetto logico-formale
una proprietà delle cose stesse. Viceversa, per Kant T. sono le condizioni stesse di
possibilità della cosa conosciuta, condizioni che si riferiscono all'ordine fenomenico, e
non riguardano la cosa in sé. Per Kant è T. la conoscenza delle condizioni a priori della
conoscenza umana e dei suoi oggetti: "definisco T. ogni conoscenza che si
occupa non degli oggetti, ma del nostro modo di conoscere gli oggetti, in quanto questo è
possibile a priori". Come tale, T. si oppone a trascendente (v.);
infatti esso non è ciò che sta al di là d'ogni nostra esperienza, bensì ciò che la
precede, rendendola a priori possibile. L'opposizione di trascendenza ed immanenza viene
accentuata dall'idealismo, a partire da Fichte. La dottrina della scienza è T., in quanto
fa vedere che tutti gli elementi della conoscenza rientrano nell'Io o nella
coscienza. Questo è il motivo per cui la filosofia contemporanea tende ad identificare T.
con coscienziale. T. è tutto ciò che appartiene al soggetto od alla coscienza, e
che condiziona l'oggettività. Un tentativo ambiguo di superare l'immanenza idealistica
della nozione di T. è rappresentato dalla fenomenologia husserliana. Mediante la teoria
dell'intenzionalità, Husserl tenta di evitare l'idealismo, pur ponendosi entro un ambito
T. di analisi. L'atteggiamento dell'analisi fenomenologica o T. è quello che si ottiene
sospendendo la validità empirica del mondo, modificando l'atteggiamento naturale, ed
interrogando l'oggettività da questo diverso punto di vista. Il T. nella versione
heideggeriana della fenomenologia assume un significato del tutto opposto all'idealismo,
in quanto lo considera in senso oggettivo: T. è ogni manifestazione dell'essere nel suo
essere trascendente.
Trascendentalismo: Termine con cui viene indicato l'indirizzo filosofico inaugurato dal criticismo
kantiano, e proseguito dall'idealismo romantico, che sottolinea l'autonomo potere
conoscitivo dello spirito umano rispetto all'esperienza. Da tale matrice si stacca invece
il T. spiritualistico, un indirizzo estetico-religioso iniziato da R.W. Emerson,
sviluppatosi negli Stati Uniti ove ha esercitato una certa influenza, che, richiamandosi
ad Hegel ed a Schelling, si basa sulla concezione secondo la quale l'unica realtà sarebbe
quella trascendentale, forma aprioristica di ogni altra realtà.
Trascendente: Ciò che sta al di là di un certo limite, ciò che lo supera. È l'opposto di immanente. In
senso gnoseologico T. è l'oggetto del conoscere, in quanto esiste indipendentemente
dall'atto del conoscere, ossia trascende tale atto. Più genericamente T. è l'essere
rispetto al pensiero. Per Platone il mondo delle idee è T. rispetto al mondo delle cose sensibili. Secondo Aristotele invece il concetto di Dio è T. rispetto all'universo, allo spazio ed al tempo, Infine per Kant T. è ciò che sta al di là di ogni possibile esperienza, ed esiste solo come idea razionale. In senso metafisico, il termine viene ad indicare una certa superiorità di valore. È T. un essere che sta al di sopra, esistendo indipendentemente dall'esistenza di un altro essere. Vi è una gerarchia di valori tra gli esseri tale per cui l'essere T. per eccellenza, quello che è in sé e per sé sussistente, fonda l'ordine razionale degli enti. Questo essere coincide con Dio.
Trascendenza: Termine
che indica l'opposto di Immanenza (v.). In prima istanza definisce il rapporto tra oggetto
conosciuto e soggetto conoscente, escludendo un'identificazione tra i due termini. Mentre
l'atto del conoscere è come tale immanente al soggetto od alla coscienza, l'oggetto che attraverso tale atto viene attinto è trascendente, ovvero esiste in modo indipendente. È il presupposto di ogni gnoseologia idealistica. Nella filosofia moderna il merito d'aver distinto con forza l'atto (noesi) e l'oggetto (noema) del conoscere, contro ogni tipo di immanenza idealistica o coscienzalistica, va attribuito a Husserl, ed al suo concetto di intenzionalità. In seconda istanza T. sta ad indicare il
rapporto tra l'essere divino ed il mondo. La T. divina implica che Dio stia al di là
d'ogni possibile esperienza umana. Tale affermazione è comune sia alle filosofie che
escludono la possibilità d'una conoscenza razionale di Dio, opponendo pertanto come
assolute sia la T. che l'Immanenza, sia a quelle metafisiche che, al contrario, ammettono
tale possibilità, gettando così un ponte tra l'Immanenza e la T. Queste interpretazioni
(tra cui quella di Tommaso d'Aquino) pongono la T. a fondamento di un ordine intelligibile
di enti che in sé sono finiti e rimandano come tali ad un essere infinito e perfetto,
quindi intrascendibile.
Trasformazioni: (Massoneria)
Il fenomeno delle T. interiori, che producono cambiamenti irreversibili nella nostra interiorità, è stato talvolta sperimentato nel corso della vita. Spesso viene trascurato, non perché irrilevante, ma forse perché viene considerato troppo legato ad eventi particolari, e quindi trovasi collocato al di fuori del controllo della volontà. Quando le T. si presentano, di norma non certo frequentemente, portano ad una più chiara coscienza di valori prima quasi ignorati, nei quali poi ci si riconosce con grande certezza. Le T. avvengono semplicemente, e non appaiono dipendere direttamente dalle nostre intenzioni. Anche se uno fosse perfettamente persuaso delle verità contenute nei nostri ragionamenti, non per questo essi sono in grado da soli di produrre in noi T.. È evidente la differenza abissale esistente fra la forza di persuasione di un ragionamento e quella che deriva invece da una T. irreversibile. Malgrado quanto può apparire, le T. non avvengono per circostanze casuali, ma che seguono logiche ben precise, che possono essere comprese attraverso un rigoroso lavoro di ricerca interiore.
Trasparenza:
Termine
dell'ottica impiegato per definirne la densità.
Y
(Massoneria) A partire dalla metà degli anni '80, la Massoneria
italiana è stata perseguitata dalle richieste pressanti da parte della
magistratura inquirente sulle possibili connessioni con la cosiddetta criminalità
organizzata. Perquisizioni e sequestri delle autorità giudiziarie a sedi
massoniche centrali e periferiche (G.O.I. e Collegi) hanno comportato il
sequestro delle liste dei membri, effettuato allo scopo dichiarato di
individuare Logge «coperte»,
com'era stata la ”P2” (v.). Fu allora che il G.O.I. avviò nella propria
organizzazione la politica della T., allo scopo dichiarato di ridurre e col
tempo eliminare i sospetti e le pressioni in atto da parte dell'opinione
pubblica e dei mezzi d'informazione. Ignorando l'esoterismo che aveva
ispirato i codificatori delle antiche Tradizioni dell'Ordine muratorio,
attraverso modifiche apportate ai testi delle Costituzioni, del Regolamento e
degli stessi Rituali, si adottarono molteplici misure per rendere
l'Istituzione più accettabile al mondo profano. Unica Obbedienza al mondo, il
G.O.I. dapprima mutò l'universalmente vigente anno massonico, facendolo
coincidere con quello civile (v. Massoneria e Stagioni), poi soppresse il
plurisecolare giuramento, sostituito dalla promessa solenne (come se ci fosse
qualche differenza!), a beneficio esclusivo dei dipendenti pubblici e dei
militari, accusati dai politici di essere servi di due padroni, la Patria e la
Massoneria. Poi fu la volta dei certificati penali, imposti dapprima a tutti i
Fratelli Massoni (con le autocertificazioni) ma soprattutto ai profani
postulanti. L'ultima è un'imposizione mantenuta tuttora in vigore. Tra la
fine del 1992 e l'inizio del 1993 le «modifiche» raggiunsero il culmine dell'intensità, tanto da
sconvolgere usi e costumi delle Logge, conseguendo fatalmente il paradossale
obbiettivo di fare della Libera Muratoria del G.O.I. una società
prevalentemente essoterica, a dispetto delle reiterate dichiarazioni della sua
qualifica di società esoterica. Nello stesso Tempio vennero scambiate le
collocazioni del Sole e della Luna, di Ercole e di Venere; scomparvero le
sciarpe magistrali, le innocue spade ed i cappucci rituali (poi ripristinati).
Il tutto diede poi adito ad ulteriori sconvolgimenti dei Rituali, originati da
fatiscenti membri della Commissione Rituali, che deliberarono modifiche, invano
e più volte presentate per l'approvazione alle Grandi Logge annuali, che
evidenziavano l'accantonamento pressoché totale delle più elementari regole
alchemiche. Recentemente si parla sempre più di una imminente e drastica
modifica del sistema elettorale previsto dalla Costituzione per l'elezione
quinquennale del Gran Maestro e della Gran Giunta. A sostegno di tale presunta
necessità viene sbandierata la «furbizia»
di varie Logge del G.O.I., in cui il M.V. in carica regolarizza le pendenze
amministrative soltanto alla vigilia della Gran Loggia, alterando le firme dei
Fratelli Maestri assenti alla votazione di Loggia od evitando di notificare il
Piedilista annuale. Il tutto ignorando l'opportunità di rendere veramente
operativi ed efficienti tutti gli Ispettori di Loggia, nonché l'eventuale
necessità (come nei casi di «furbizia»
succitati) di attivare le vigenti norme della Giustizia Massonica. Come
conseguenza parrebbe emergere un G.O.I. sempre meno esoterico, e purtroppo
sempre più politico se non partitico, quindi essoterico, ovvero un sistema
incompatibile con tutti i principi sui quali la Massoneria Universale
formalmente si regge negli ormai quasi tre secoli della sua più che degna ed
onorevole storia. Come dichiarato da moltissimi buoni Massoni, pare proprio che
ci si stia amputando dell'organo che dimostra la nostra mascolinità, ovvero
che ci si stia avviando a privare i Massoni del G.O.I. dell'indumento che vela
la parte inferiore, notoriamente oscena, del corpo fisico umano. Purtroppo
molti ormai temono che questo possa significare l'inizio della fine della
Massoneria del G.O.I., un'arma, un sistema sociale, un giocattolo che si
ritiene ancora utilissimo per il singolo e per la collettività, quindi non da
scartarsi né da buttare nella spazzatura. In quest'ultima, semmai, proveremo
a buttarci certi arroganti personaggi che si nascondono dietro il grembiule
massonico e sfruttano i mezzi a loro disposizione per (si spera inconsciamente)
inquinare e spingere la Massoneria del G.O.I verso la sua definitiva rovina.
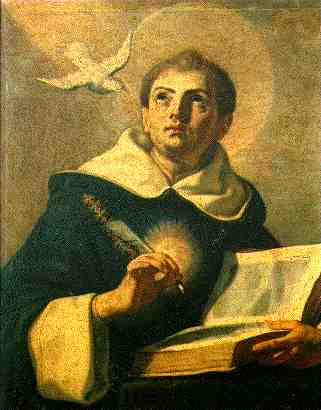 Tommaso d'Aquino: (1225-1274) Nacque
intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, presso l'abbazia di Monte Cassino, da famiglia
antica e nobile. Il padre Landolfo, era conte di famiglia longobarda, e la madre Teodora,
contessa di famiglia normanna di Napoli. Nel 1236 venne presentato, come oblato,
all'abbazia benedettina di Montecassino, dove iniziò gli studi. Nel 1239 si allontanò
dall'abbazia dopo che il luogo sacro era stato trasformato in fortezza militare da
Federico II, durante la lotta contro il papa Gregorio IX. Nel 1240 la famiglia lo mandò
presso l'Università di Napoli per il completamento degli studi letterari e per
l’inizio di quelli filosofici; per gli studi di grammatica e logica ebbe come maestro
Martino di Dacia, per quelli delle scienze naturali e della metafisica, Pietro d'Irlanda.
Tra il 1242-43 abbracciò la vita religiosa ed entrò come novizio nell'ordine di San
Domenico, contro la volontà della sua famiglia. Nel 1244 fallì il suo tentativo di
raggiungere Parigi insieme con Giovanni Teutonico, maestro generale dell'Ordine, proprio a
causa delle minacce della famiglia che non condivideva la sua vocazione. Catturato dai
fratelli presso Acquapendente in Toscana, venne rinchiuso nel castello di San Giovanni in
Roccasecca, dove rimase prigioniero un anno. Nel 1245 fuggì per recarsi a Parigi, dove
seguì i corsi di teologia di Alberto Magno, con il quale si recò poi a Colonia. Nel
1248, di ritorno da Colonia, fu ordinato sacerdote. Nel 1252 si recò nuovamente a Parigi,
dove iniziò la carriera accademica e scrisse un saggio in difesa degli ordini mendicanti,
contro i quali avevano lanciato i loro strali i professori della Sorbona, primo fra tutti
Guglielmo di Sant' Amore, canonico di Beauvais. Tra il 1252-1254 fu baccelliere biblico
dello Stato generale domenicano, nel convento di San Giacomo a Parigi. Tra il 1254-1256 fu
sentenziario. Nel 1256 ebbe inizio il suo insegnamento ordinario presso lo studio generale
di Parigi, che terrà fino al 1259, anno in cui figura come membro della commissione per
l'ordinamento degli studi dell'ordine domenicano. Alla corte papale si incontra con
Guglielmo di Moerbeke, valente grecista, il quale gli prepara un testo latino di
Aristotele più aderente al greco, in modo che egli possa approfondire il pensiero
autentico di quel filosofo. Nel 1259 rientrò in Italia dove permase fino al 1268. Fu
nominato teologo della Curia papale, e fu invitato da papa Urbano IV (1261-1264) a
comporre un "elogio" per solennizzare la festa del SS. Sacramento istituita dal Papa. Nel 1269 ritornò a Parigi in qualità di maestro di teologia, e si dedicò all'insegnamento ed alla predicazione. Tra il 1272-1274 rientrò in Italia. Su pressante istanza di Carlo d'Angiò, il Capitolo Generale dell'ordine lo inviò a Napoli, in qualità di direttore della facoltà di teologia presso l'università di quella città. T. fu anche a Salerno, dove tenne una serie di lezioni straordinarie ed un corso di conferenze, nella celebre scuola medica che aveva sollecitato l'onore e il decoro del Santo. Nel 1273 papa Gregorio X lo invitò a partecipare ad un Concilio generale convocato a Lione, con lo scopo di appianare le controversie tra la Chiesa romana e i greci scismatici. All’inizio del 1274, durante un viaggio verso Lione, si ammalò gravemente e venne portato all'abbazia cisterciense di Fossanova di Priverno, nella diocesi di Terracina, dove morì il 7 marzo dello stesso anno. Dante avanzò l'ipotesi che fosse fatto morire per veleno dallo stesso Carlo d'Angiò: "Carlo venne in Italia e, per
ammenda, vittima fè di Curradino; e poi rispinse al ciel Tommaso, per ammenda...
(Purg. 67-69)" - (ovvero Carlo I d'Angiò venne in Italia e, per fare ammenda, fece
di Corradino di Svevia una vittima; quindi, sempre per fare ammenda, rimandò in cielo T.
con il veleno ...). Nel 1277 il vescovo di Parigi condannò 21 Proposizioni tratte
dalle opere di T., per il loro accentuato razionalismo e naturalismo. Nel 1323 San T. fu
canonizzato da papa Giovanni XXII. Durante il concistoro il Pontefice sostenne che non era
stato necessario ricercare i miracoli che T. aveva potuto operare in vita, ma che
occorreva tenere ben presente il modo con cui aveva risolto mirabilmente tante spinose
questioni della Chiesa. Nel 1567 papa Pio V dichiarò T. dottore della Chiesa. Nel 1888
Leone XIII dichiarò San T. patrono delle scuole cattoliche. Le sue opere maggiori sono:
(1253-55) - Commento ai 4 libri delle Sentenze; (1258-62) - Summa contra
Gentiles scritta su richiesta di Raimondo di Penafort per esigenze missionarie;
(1266-68) - Summa theologica: si suddivide in quattro parti: la prima tratta di Dio
in sé e come principio di tutte le cose, e di Dio come causa prima delle creature; la
seconda tratta del movimento della creatura ragionevole verso Dio e dell'influsso di Dio
sul movimento da regolare per mezzo della legge e da sorreggere con la Grazia; la terza,
tratta di Gesù Cristo, della Sua Persona, della vita e delle opere, dei Sacramenti, fino
a quello della Penitenza. L'opera è rimasta incompiuta; (1256-1268) - Quaestiones
disputatae: commenti alla Sacra Scrittura; (1259-69) - Isaia, Geremia, Giobbe e
Canticum Canticorum; (1256-59) San Matteo (i suoi commenti a Marco, Luca e
Giovanni sono andati perduti); (1270-72) Salmi; (1272-73) Epistolae Paulinae;
(1265-67) Catena aurea in Marco, Luca, e Giovanni, ed infine i Commenti ad
Aristotele.
Tommaso d'Aquino: (1225-1274) Nacque
intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, presso l'abbazia di Monte Cassino, da famiglia
antica e nobile. Il padre Landolfo, era conte di famiglia longobarda, e la madre Teodora,
contessa di famiglia normanna di Napoli. Nel 1236 venne presentato, come oblato,
all'abbazia benedettina di Montecassino, dove iniziò gli studi. Nel 1239 si allontanò
dall'abbazia dopo che il luogo sacro era stato trasformato in fortezza militare da
Federico II, durante la lotta contro il papa Gregorio IX. Nel 1240 la famiglia lo mandò
presso l'Università di Napoli per il completamento degli studi letterari e per
l’inizio di quelli filosofici; per gli studi di grammatica e logica ebbe come maestro
Martino di Dacia, per quelli delle scienze naturali e della metafisica, Pietro d'Irlanda.
Tra il 1242-43 abbracciò la vita religiosa ed entrò come novizio nell'ordine di San
Domenico, contro la volontà della sua famiglia. Nel 1244 fallì il suo tentativo di
raggiungere Parigi insieme con Giovanni Teutonico, maestro generale dell'Ordine, proprio a
causa delle minacce della famiglia che non condivideva la sua vocazione. Catturato dai
fratelli presso Acquapendente in Toscana, venne rinchiuso nel castello di San Giovanni in
Roccasecca, dove rimase prigioniero un anno. Nel 1245 fuggì per recarsi a Parigi, dove
seguì i corsi di teologia di Alberto Magno, con il quale si recò poi a Colonia. Nel
1248, di ritorno da Colonia, fu ordinato sacerdote. Nel 1252 si recò nuovamente a Parigi,
dove iniziò la carriera accademica e scrisse un saggio in difesa degli ordini mendicanti,
contro i quali avevano lanciato i loro strali i professori della Sorbona, primo fra tutti
Guglielmo di Sant' Amore, canonico di Beauvais. Tra il 1252-1254 fu baccelliere biblico
dello Stato generale domenicano, nel convento di San Giacomo a Parigi. Tra il 1254-1256 fu
sentenziario. Nel 1256 ebbe inizio il suo insegnamento ordinario presso lo studio generale
di Parigi, che terrà fino al 1259, anno in cui figura come membro della commissione per
l'ordinamento degli studi dell'ordine domenicano. Alla corte papale si incontra con
Guglielmo di Moerbeke, valente grecista, il quale gli prepara un testo latino di
Aristotele più aderente al greco, in modo che egli possa approfondire il pensiero
autentico di quel filosofo. Nel 1259 rientrò in Italia dove permase fino al 1268. Fu
nominato teologo della Curia papale, e fu invitato da papa Urbano IV (1261-1264) a
comporre un "elogio" per solennizzare la festa del SS. Sacramento istituita dal Papa. Nel 1269 ritornò a Parigi in qualità di maestro di teologia, e si dedicò all'insegnamento ed alla predicazione. Tra il 1272-1274 rientrò in Italia. Su pressante istanza di Carlo d'Angiò, il Capitolo Generale dell'ordine lo inviò a Napoli, in qualità di direttore della facoltà di teologia presso l'università di quella città. T. fu anche a Salerno, dove tenne una serie di lezioni straordinarie ed un corso di conferenze, nella celebre scuola medica che aveva sollecitato l'onore e il decoro del Santo. Nel 1273 papa Gregorio X lo invitò a partecipare ad un Concilio generale convocato a Lione, con lo scopo di appianare le controversie tra la Chiesa romana e i greci scismatici. All’inizio del 1274, durante un viaggio verso Lione, si ammalò gravemente e venne portato all'abbazia cisterciense di Fossanova di Priverno, nella diocesi di Terracina, dove morì il 7 marzo dello stesso anno. Dante avanzò l'ipotesi che fosse fatto morire per veleno dallo stesso Carlo d'Angiò: "Carlo venne in Italia e, per
ammenda, vittima fè di Curradino; e poi rispinse al ciel Tommaso, per ammenda...
(Purg. 67-69)" - (ovvero Carlo I d'Angiò venne in Italia e, per fare ammenda, fece
di Corradino di Svevia una vittima; quindi, sempre per fare ammenda, rimandò in cielo T.
con il veleno ...). Nel 1277 il vescovo di Parigi condannò 21 Proposizioni tratte
dalle opere di T., per il loro accentuato razionalismo e naturalismo. Nel 1323 San T. fu
canonizzato da papa Giovanni XXII. Durante il concistoro il Pontefice sostenne che non era
stato necessario ricercare i miracoli che T. aveva potuto operare in vita, ma che
occorreva tenere ben presente il modo con cui aveva risolto mirabilmente tante spinose
questioni della Chiesa. Nel 1567 papa Pio V dichiarò T. dottore della Chiesa. Nel 1888
Leone XIII dichiarò San T. patrono delle scuole cattoliche. Le sue opere maggiori sono:
(1253-55) - Commento ai 4 libri delle Sentenze; (1258-62) - Summa contra
Gentiles scritta su richiesta di Raimondo di Penafort per esigenze missionarie;
(1266-68) - Summa theologica: si suddivide in quattro parti: la prima tratta di Dio
in sé e come principio di tutte le cose, e di Dio come causa prima delle creature; la
seconda tratta del movimento della creatura ragionevole verso Dio e dell'influsso di Dio
sul movimento da regolare per mezzo della legge e da sorreggere con la Grazia; la terza,
tratta di Gesù Cristo, della Sua Persona, della vita e delle opere, dei Sacramenti, fino
a quello della Penitenza. L'opera è rimasta incompiuta; (1256-1268) - Quaestiones
disputatae: commenti alla Sacra Scrittura; (1259-69) - Isaia, Geremia, Giobbe e
Canticum Canticorum; (1256-59) San Matteo (i suoi commenti a Marco, Luca e
Giovanni sono andati perduti); (1270-72) Salmi; (1272-73) Epistolae Paulinae;
(1265-67) Catena aurea in Marco, Luca, e Giovanni, ed infine i Commenti ad
Aristotele.