Saqqara: Antica località egiziana, sede di una vastissima necropoli, tuttora oggetto di
scavi e di ricerche sistematiche. Il settore settentrionale ha rivelato tombe a mastaba,
ed oggetti con i nomi di sovrani egiziani della I dinastia (2850 a.C.): le mastabe erano
strutture a pianta rettangolare, con camera funeraria centrale circondata da ambienti
adibiti a magazzino. A S. si trova anche il grandioso complesso funerario del re Doser,
fondatore della III dinastia (2650-2700 a.C.), compreso in una cinta muraria, entro la
quale si trova la piramide a gradoni, e numerosi annessi in una complicata
planimetria. Notevoli per interesse anche le piramidi di Userkaf e di Unis, della V
dinastia (2480-2350 a.C.); nelle camere sepolcrali di quest’ultima, ed in quelle di
alcuni re e regine della VI dinastia (2350-2200 a.C.), furono incisi i celebri Testi
delle Piramidi. Importanti per la struttura e per la bellezza decorativa, sono anche
le mastabe di alcuni grandi dignitari di corte. Alla Bassa Epoca appartiene invece il Serapeum,
con le sepolture dei buoi Api (v.). Di grande interesse il complesso funerario di
Sepseskaf, della IV dinastia, di Dedkare-Isesi della V dinastia, e di Ibi del Primo
periodo Intermedio.
Saraceni: Denominazione
generica degli Arabi nomadi (golfo di ‘Aqaba, a Sud della penisola del Sinai) e dei
musulmani in genere, con particolare riferimento a quelli stanziati nel Mediterraneo
centro-orientale, nonché in Spagna e lungo le coste europee, durante il Medioevo
cristiano (IX-X secolo).
Satana: Nome derivato
dall’ebraico Satan, nemico, e dal greco ecclesiastico Satan.
Nella Bibbia è l’avversario, l’oppositore per eccellenza (Zaccaria 3,
1-2, Giobbe 1, 6; I Cronache 21, 1). Nel Nuovo Testamento viene identificato
con il diavolo (I Pietro 5, 8) o con gli antichi simboli del male, come il
dragone ed il serpente cacciato dal Paradiso, l’essere preternaturale che si frappone
tra Dio e gli uomini, per tentarli ed indurli al peccato (Luca 10, 18; Matteo
4, 1-11; 1 Corinzi 7, 5; 2 Corinzi 2, 11). Nelle leggende tedesche e nelle
varie opere ispirate alla vicenda di Faust, è Mefistofele, il diavolo che concede
a Faust giovinezza e sapere, pretendendone in cambio l’anima. Nella tradizione
apocalittica gli viene attribuito il nome di Lucifero, principe di tutti gli angeli
prima della sua ribellione a Dio, che lo mutò in capo dei demoni. L’Apocalisse
(19-20) presenta il grandioso conflitto tra Dio e S., che sarà infine precipitato nel
lago di fuoco. Anche il Corano parla di S. come dell’angelo decaduto oppure di uno
spirito del male.
Satanismo: Termine
attribuito al culto tributato a Satana, al demonio. È stato un atteggiamento letterario
della cultura occidentale, con le diverse linee che vanno da Milton e Blake a De Sade al
decadentismo francese. Nella tradizione anticlericale divenne espressione della ribellione
ai vincoli religiosi e morali, per affermare la totale libertà e la forza creatrice
dell’essere umano, rappresentata dalla figura di Satana. Tali idee, insieme ad una
radicale negazione delle strutture sociali e dei valori più diffusi, si trasferirono ad
alcune esperienze associazionistiche, come il movimento dei Luciferiani, che intendevano
costituire la "vera Chiesa di Satana". Recentemente sono sorti vari
gruppi satanici, che si richiamano alla "Chiesa di Satana", fondata in
California da Anton S. La Vey (1906). La dottrina di tale chiesa è razionalistica ed
edonistica, con un rituale fortemente anticristiano (la messa nera, comprendente la
profanazione dell’ostia consacrata). Un’altra organizzazione satanica, forse la
più importante, è stata fondata negli Stati Uniti nel 1975 da Michael A. Aquino,
ufficiale del controspionaggio dell’esercito americano, con il nome di "Tempio
di Set", che si considera il punto d’arrivo della tradizione magico-satanica
contemporanea. Accanto a queste forme di S., che adorano un Satana personificato, vi sono
altre forme come quella occultistica, in cui Satana è inteso come simbolo della rivolta
contro ogni tipo di regola (anarchia), o quello psichedelico, con visioni di Satana
sotto l’effetto dell’esaltazione musicale e della droga.
Saturno: Nella tradizione alchemica il nome del pianeta e del dio degli inferi assume
diversi significati simbolici, quali: piombo, cambiamento provocato da una forza agente,
tratto verticale della Croce (v.), trasformazione o disgregazione, età adulta e morte.
Secondo il Mariani (Introduzione alla pratica alchemica, Ediz. Bastogi, 1983),
"S., la spoliazione, è il più lontano tra i pianeti dell’antichità
classica, quello che in un cerchio compiuto e perfetto rinchiude tutti gli altri. È
l’ultima sfera del mondo a portata di mano: al di là di S. i cieli sono
occupati dalle grandi centrali energetiche che con l’umano hanno solo indecifrabili
riferimenti ed oscuri rapporti che, di volta in volta, caso per caso, debbono essere
stabiliti e fissati con un lavoro che, per il ricercatore, non può che risultare
titanico. È cioè al di là delle capacità umane. L’intero sistema solare è
racchiuso in una sfera di piombo di S., e la nera matrice del divoratore dei propri
figli è quella che da significato alla manifestazione sublunare. Così l’uomo che
non abbia la forza o l’occasione per sperimentare la vertigine delle vette, che non
abbia gli attrezzi per rompere la sfera di piombo e proiettarsi fuori, nell’abisso di
Luce, deve fare i conti con questo particolare gioco delle energie planetarie e mettere
ordine, attraverso lo studio e l’applicazione pratica dell’Astrologia (v.),
nei suoi rapporti con esse. Semmai solo dopo, se gliene resta il tempo, potrà tentare
di spiccare il salto. S., la Grande Madre, il Mare di Bronzo, la nascita del mondo
fisico, che nella morte l’esplicita sua scadenza ed il suo riflesso, è la
trasmutazione ultima".
Savonarola Giacomo: Religioso e
uomo politico italiano (Ferrara 21.9.1452 - Firenze 23.5.1498). Nato da una famiglia
originaria di Padova, resa famosa dal nonno Michele, un famoso medico, S. intraprese
dapprima gli studi di medicina, abbandonati nel 1475 per entrare a far parte dell'ordine
domenicano nel convento di San Domenico a Bologna. Ritornato a Ferrara per qualche anno,
per completarvi gli studi di teologia, nel 1492 fu trasferito nel convento di San Marco in
Firenze. Vi rimase per cinque anni, iniziando la sua attività di predicatore ed
affrontando subito i temi centrali della sua ideologia: condanna dei costumi dissoluti dei
laici e dei chierici ed annuncio dell'imminente rigenerazione della Chiesa, preceduta da
una serie di sventure e di castighi. Il suo tono acceso e profetico colpì fin dai primi
anno la sensibilità dei fedeli fiorentini. Nel 1487 lasciò Firenze perché trasferito,
prima a Ferrara e poi a Brescia, da dove venne richiamato a Firenze per volontà dello
stesso Lorenzo de' Medici. Questi aveva infatti ceduto alle pressioni esercitate da un
gruppo di intellettuali estimatori del frate, capeggiati da Pico della Mirandola.
Dall'autunno del 1490 i Fiorentini tornarono ad ascoltare le profezie 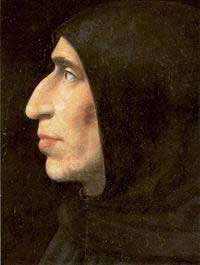 apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della
prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa
corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò
dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco
dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne
uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al
dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,
che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si
rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo
all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale
fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta
opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,
grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più
accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle
donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare
contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,
che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De
veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a
predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il
papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato
arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo
tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed
immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il
S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed
altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23
maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati
nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse
a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo
non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..
apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della
prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa
corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò
dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco
dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne
uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al
dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,
che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si
rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo
all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale
fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta
opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,
grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più
accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle
donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare
contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,
che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De
veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a
predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il
papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato
arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo
tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed
immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il
S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed
altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23
maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati
nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse
a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo
non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..
Scala di Giacobbe: Termine identificante un simbolo mantenuto in uso in tutta la sua vitalità nella
sola tradizione massonica britannica. "Giacobbe partì da Bersabea e si diresse
verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era
tramontato; prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece
un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco
gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa" (Genesi 28, 10-15).
Poi Iddio stesso, che apparve in cima alla scala, gli parlò, confermandogli il Berith, il
patto stabilito con Abramo. Il luogo in cui avvenne la manifestazione celeste era
denominato Lutz, ma Giacobbe lo chiamò Beth-‘El, la casa di Dio. Secondo
un’interpretazione qabbalistica, il sogno descrive il pellegrinaggio dell’anima
dopo la morte; Lutz sarebbe il sepolcro, e Beth-‘El il regno di Dio, che concluderà
le ascese e le discese dello spirito, al termine dei cicli di morte-rinascita. Y (Massoneria): Oggi soltanto la Massoneria inglese ed i suoi
derivati considera la S. di Giacobbe simbolo delle virtù umane, specialmente della Fede
(v.), definita prova delle cose mai viste, la Speranza, ancora dell’anima, e la
Carità, ovvero l’Amore, unica prova della sincerità della Fede. Alcuni autori
massoni forniscono interpretazioni simboliche della S. L’Oliver, nella visione
giacobiana, nel 1837 sosteneva che "le nuvole scure dell’ira divina sono
dissolte, i cieli sono aperti, e godiamo di un raggio della sua gloria nella copertura
celestiale della Loggia … Su questa scala gli angeli salivano e scendevano di
continuo, per ricevere comunicazioni dall’Altissimo, e per disseminare le loro grandi
comunicazioni sulla faccia della terra … Abbiamo qui una straordinaria coincidenza di
tradizione rispetto alla Scala Massonica, esistente in ogni regione del mondo … Tra
noi questa pratica si fonda sulla forte base della Fede, che è il primo gradino della
Scala poggiante sulla parola di Dio. Essa produce una Speranza ben fondata di condividere
le promesse registrate in quel Libro Sacro; e questo è il secondo gradino della Scala
Massonica. Il terzo ed il più perfetto gradino è la carità, mediante la quale è
raggiungibile la cima della S., metaforicamente parlando il regno della beatitudine, la
dimora del diletto puro e permanente" (v. Symbolism in Craft Freemasonry, di
C. Dyer). Più recentemente il Guenon ha scritto: "L’Asse dell’Universo
è come una S., sulla quale si effettua un perpetuo movimento ascendente e
discendente".Il Moramarco, che queste note ha mirabilmente raccolto, nella sua Nuova
Enciclopedia Massonica, Vol. I, pag. 141, scrive che "Far sì che si compia
tale movimento è infatti la destinazione essenziale della S., da un altro lato la
sua particolare forma impone alcune osservazioni: i suoi due montanti verticali
corrispondono alla dualità dell’Albero della Scienza o, nella Cabala ebraica,
alle due colonne di destra e di sinistra dell’Albero Sefirotico (v.); né
l’uno né l’altro è propriamente assiale, e la colonna di mezzo, che è
l’asse vero e proprio, non è raffigurata in modo sensibile; d’altronde
l’intera S., nel suo complesso, è in certo modo unificata dai pioli che
congiungono i due montanti e che, essendo posti orizzontalmente tra questi, hanno
necessariamente i loro punti centrali proprio sull’asse. Si vede così come la S.
offra un simbolismo completo: essa è come un ponte verticale che si eleva attraverso
tutti i mondi, permettendo di percorrerne l’intera gerarchia passando di piolo in
piolo; nello stesso tempo i pioli sono i mondi stessi, cioè i diversi livelli o gradi
dell’Esistenza Universale. Tale significato è evidente nel simbolismo biblico della S.
di Giacobbe, lungo la quale gli angeli salgono e scendono. Ed è noto che Giacobbe, nel
luogo in cui aveva avuto la visione, posò una pietra che "eresse come un
pilastro", la quale è anche una raffigurazione dell’Asse del Mondo,
sostituendosi alla S. stessa. Gli angeli rappresentano gli stati superiore
dell’essere, e ad essi corrispondono più particolarmente i pioli, il che si spiega
col fatto che la S. va considerata con la base poggiata a terra, ovvero per noi è
necessariamente il nostro mondo, il supporto a partire dal quale si deve affrontare
l’ascensione". Infine Giuseppe Mazzini (Dal Concilio a Dio, 1870)
scrive che "Noi vediamo negli angeli l’anima dei giusti che vissero nella Fede e
morirono nella Speranza. Nell’angelo custode ed ispiratore, l’anima della
creatura che più santamente e costantemente ci amò, riamata, sulla terra, ed ebbe per
ricompensa la missione o la potenza di vegliare su di noi giovandoci: la S. fra terra e
cielo, intraveduta in sogno da Giacobbe, rappresenta per noi la doppia serie ascendente e
discendente delle nostre trasformazioni sulla via dell’iniziazione all’Ideale
divino, e delle influenze benefiche esercitate su noi dagli esseri cari che su quella via
ci precedono"
Scalpello: Utensile
impiegato dall'artista per dare forma e regolarità alla pietra informe da sgrossare, il
cui uso è consentito da quello congiunto del Maglietto (v.). Rappresenta la ragione,
intesa come potenza esecutrice della volontà, ed è ovviamente l'emblema della scultura,
oltre che simbolo del pensiero fermo, perseverante, ponderato, della risoluzione decisa ed
inderogabile. Lo S. copre un ruolo importante nell'opera che ogni Libero Muratore deve
compiere su se stesso. La mente dell'uomo è come un diamante al suo stato grezzo,
primitivo: allorché per l'intervento dello S. la superficie esterna viene rimossa,
appaiono subito le bellezze latenti nelle sfaccettature di quella pietra. Rappresenta
anche l'immagine della parola guidata dalla volontà, dalla virtù e dalla ragione, con la
quale si distrugge sempre ogni errore.
Scetticismo: Filosofia
che nega l’esistenza di un criterio certo di verità. Fondatore della scuola scettica
fu Pirrone (365-275 a.C.), da cui il nome di pirronismo talvolta usato come
sinonimo di S. Assimilato ed in seguito anche predicato da Sant’Agostino (v.), lo S.
antico predica la sospensione del giudizio contro l’atteggiamento dogmatico degli
stoici (v.). Non esiste alcun criterio di verità dal momento che ad ogni ragione è
sempre possibile contrapporne una contraria di uguale valore. Il carattere radicale di
questa forma di S. viene attenuato dalla filosofia moderna, in cui il dubbio scettico
assume spesso la funzione puramente metodica di garantire la conoscenza degli errori dei
sensi (v. Cartesio). Una vera e propria ripresa dello S. antico si ha solo con Montaigne
(1533-1592) e Charron (1541-1603), in clima controriformistico. La nostra conoscenza della
verità è sempre parziale, e quest’ultima può essere garantita solo dalla
Rivelazione divina. Il pirronismo si presta meglio del dogmatismo ad esprimere questo
carattere limitativo e provvisorio della conoscenza umana. Il maggior rappresentante dello
S. moderno è comunque Hume (1711-1776) che, pur respingendo lo S. totale degli antichi,
afferma che i nostri giudizi non assumono valore assoluto, ma si fondano su
un’abitudine psicologica. Lo S. humiano viene contrapposto polemicamente al
razionalismo kantiano da Schulze nell’Aenesidemus (1792), mentre
l’idealismo postkantiano lo combatte decisamente. Nel pensiero contemporaneo lo S.
tende ad essere superato dai diversi indirizzi fenomenisti, pragmatisti e relativisti,
sopravvivendo soprattutto come reazione polemica a certi indirizzi idealistici.
Scheletro: Simbolicamente,
in tutte le tradizioni ed in gran parte delle credenze, è la personificazione della Morte
(v.). l’Alchimia lo considera simbolo del Nero (v.) e della Putrefazione (v.). La
Libera Muratoria impiega l’immagine dello S. all’interno del Gabinetto di
Riflessione (v.), dov’è però simbolo della liberazione da quanto può distogliere
l’essere umano dal percorrere la via della rettitudine, a cominciare dai Metalli (v.)
e dalle Passioni tipiche del mondo profano.
Sciamanismo:
Antica pratica mistica più che movimento filosofico-spirituale, impiegata da
alcuni illuminati del XVIII secolo collocabili tra le frange magico misteriche, createsi
con l’esasperazione delle tendenze spirituali. Per questi la perfetta conoscenza era
data dall’unione dell’uomo con il divino, attraverso mezzi, quali esseri,
animali o cose, che ne favorivano il processo. Lo S. è un complesso di credenze e
pratiche magico-religiose incentrate sulla figura e sull’attività dello sciamano.
Solitamente viene considerato una delle forme tipiche dell’animismo (v.), ossia la
manifestazione religiosa primitiva la cui credenza attribuisce ad ogni essere, anche
materiale, un’anima intesa come principio attivo. Il nome deriva dal termine "sciaman",
comune alle lingue siberiane, indicante il veggente, lo stregone e l’asceta. Molti
considerano erroneamente lo S. sinonimo di stregoneria e satanismo. Al riguardo Guenon,
nel suo Regno delle Quantità e i Segni dei Tempi (Ediz. Adelphi, 1982) diceva : "La
distinzione che taluni hanno voluto stabilire tra S. e feticismo, considerati come
due varietà dell’animismo, non può essere né così netta né così
importante com’essi ritengono: che siano esseri umani (nel primo caso) od oggetti
qualsiasi (nel secondo caso) a fungere principalmente da supporti o da condensatori
per certe influenze sottili, si tratta soltanto di una semplice differenza di modalità tecniche,
la quale, in fondo, non ha nulla di assolutamente essenziale". In sostanza lo S.
è una specie di animismo, in cui la parte preponderante è costituita dall’elemento
magia (v.). Comunque non tutti i maghi sono sciamani, mentre tutti gli sciamani sono
maghi, esperti in tecniche dell’estasi del tutto particolari. Alla base delle
credenze sciamaniche c’è la convinzione che in ogni elemento naturale dimori uno
spirito sacro di origine divina. Per entrare in contatto con queste forze misteriose, che
tra l’altro infondono facoltà di guarigione e di interpretazione del futuro, gli
sciamani si sottopongono a difficili prove fisiche. Questo carattere religioso, che di
norma è estraneo a sistemi teologici ben definiti, riconosce l’esistenza di un
Essere Supremo, quasi sempre androgino e quindi autogenerantesi, col quale lo sciamano
entra in contatto. In breve, lo sciamano viene posseduto essenzialmente da uno spirito in
uno stato ipnotico o di trance profonda. I suoi sogni sono viaggi estatici nella
realtà. Il suo spirito, percorrendo mondi paralleli, incontra altre entità, altri mondi
dei trapassati ed altri sciamani. Dai mondi esplorati trae l’energia che mette al
servizio di riti magici per il bene dell’umanità. Nel momento dell’estasi,
provocata in vari modi e sempre accompagnata dal battere d’uno speciale tamburo,
attributo dello sciamano, egli s’identifica magicamente con il suo Dio unico. Nello
sciamano si rileva l’esistenza di una cosmologia molto sviluppata (i cosiddetti tre
mondi, v. Astrale), e si riscontrano riti di elevato livello esoterico che ricordano
quelli primordiali o vedici. Tra gli sciamani del 1700 potrebbe essere annoverato il
famoso taumaturgo Cagliostro, in quanto anch’egli nelle sue pratiche magico-rituali
si avvaleva di una fanciulla medium, dal nome simbolico di Colomba, come mezzo coadiuvante
nell’evocazione dei dodici profeti o dei sette angeli. Oggi lo sciamano esiste in
tutti i paesi del mondo. Nella società moderna egli si esprime anche in gruppo,
utilizzando vari riti propiziatori, come quello della pioggia. Normalmente un gruppo
associato che celebra un rito magico è composto da 13 sciamani. Simbolo di queste
congreghe ascetiche è il pentacolo, una stella a cinque punte inscritta in un
cerchio, a cui si attribuisce valore magico. (La Luce Massonica di A. Sebastiani,
Vol 6°, Ediz. Hermes, 1995).
Sciarpa: Indumento
massonico caduto molto in disuso dopo gli anni ’80, di cui sono dotati i Maestri
Massoni. Secondo gli studiosi richiama il cordone dei Brahmani (v.). La S., cade
dalla spalla destra al fianco sinistro, e viene ritualmente indossata solo in talune Logge
del Grande Oriente d’Italia. In genere però viene oggi usata preferibilmente durante
alcune cerimonie festive o nelle Tornate bianche (v.). Indumento proveniente dalla
Tradizione Scozzese, la S. è di colore azzurro (come la Volta Stellata, v.) con bordi
rossi (la Trascendenza).
 Scientology: Termine
che definisce la tecnologia sviluppata e diffusa nel 1950 dall’americano L. Ron
Hubbard, consistente nella liberazione della mente da condizionamenti derivati da traumi
subiti fin da prima della nascita in condizione di incoscienza, che possono portare
l’essere umano a comportamenti irrazionali od a patologie psico-fisiche anche molto
gravi (v. Dianetics).
Scientology: Termine
che definisce la tecnologia sviluppata e diffusa nel 1950 dall’americano L. Ron
Hubbard, consistente nella liberazione della mente da condizionamenti derivati da traumi
subiti fin da prima della nascita in condizione di incoscienza, che possono portare
l’essere umano a comportamenti irrazionali od a patologie psico-fisiche anche molto
gravi (v. Dianetics).
Sciiti: Denominati anche
Si’iti, dall’arabo si’a, divisione, partito. Seguaci della
fazione di ‘Alì, cugino e genero di Maometto, del quale aveva sposato la figlia
Fatima. Dopo l’uccisione di ‘Alì (661), i suoi sostenitori diedero vita ad un
partito fondato sul principio del legittimismo tanto politico quanto religioso, che
rivendicava ai discendenti dell’assassinato la massima autorità sull’Islam. In
pratica gli S. respingevano il principio del consensus della comunità in
riferimento alla designazione dell’imam, sostenendo la dottrina che in ogni
tempo Dio affidi a un imam infallibile "per natura" la guida dei
suoi servi, tanto come capo religioso quanto come capo temporale. Di qui
l’individuazione dell’imam "del tempo", al quale il fedele deve
credere perché investito da Dio di qualità sovrumane, in quanto in lui è impiantata una
particella divina trasmessagli da Adamo attraverso Maometto. In riferimento con questa
problematica tra gli S., che si opposero tenacemente sia agli omayyadi che agli abbasidi,
sorsero numerose tendenze e sette. Tra le principali, che ebbero come punto centrale di
contrasto proprio l’interrogativo a che spettasse la suprema direzione della
comunità musulmana, gli zaiditi (da Zaid, pronipote di ‘Alì), gli imamiti
o duodecimani, che sostenevano che con il dodicesimo imam la serie s’era
estinta, e gli ismailiti (da Isma’il, il settimo imam), ai quali si possono
collegare la setta degli Assassini (v.) ed i Drusi. Sul piano politico queste ed altre
correnti hanno avuto notevole importanza, dando origine a varie dinastie locali. In
materia di osservanza rituale, gli S. hanno una visione rigida della purezza rituale, con
evidente conseguenza per quanto concerne i rapporti con cristiani, ebrei ed anche
musulmani di altro rito. Inoltre, rispetto ai sunniti, una tradizione per essere
autorevole deve risalire esclusivamente alla famiglia del Profeta, e non eventualmente ai
compagni dello stesso. Attualmente circa il 10% dei musulmani è S., secondo le differenti
correnti, con comunità particolarmente consistenti in Iran (dal 1979 un imam
governa l’intero Paese, dopo aver esiliato l’ultimo scià Reza Pahlavi), Iraq,
Marocco e Yemen.
Scisma: Termine derivato
dal greco scisma, fenditura, spaccatura,
scissione. Nell’ambito della dottrina cristiana, significa rottura dell’unità
ecclesiale, secondo la definizione di Ireneo (Adversus haereses 4, 33, 7),
determinata dal prevalere di interessi particolari sull’unità della Chiesa e
l’amore fraterno tra i fedeli. Talvolta lo S. è connesso all’eresia (v.), ma
non sempre. Infatti la ribellione può toccare il solo campo disciplinare, senza intaccare
il dogma. I primi S. si verificarono in seguito al dibattito religioso ed alle
controversie dottrinali dei primi secoli; tra il IV ed il V secolo si ebbe la separazione
dei donatisti, degli ariani e dei monofisiti che, pur allontanando una parte dei credenti
dalla comunità cristiana, non compromisero l’unità e la stabilità della Chiesa. Ma
durante le controversie sul monofisismo, si determinarono le premesse di una separazione
ben più grave tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente. Quando nel 482
l’imperatore Zenone fece pubblicare l’Henoticon (editto di unione) per
conciliare ortodossi e monofisiti, il patriarca di Costantinopoli rese vano il tentativo
di pacificazione, originandola prima vera frattura tra chiesa romana ed orientale (S. di
Acacio, 482-519), riaffermata dall’appoggio dato dall’imperatore Costante II al
monotelismo, con la pubblicazione del Tipo o Regola intorno alla fede (648) e dalla
successiva lotta iconoclasta. Le cause dello S. d’Oriente furono molteplici:
contrasti dottrinali, tendenza dei patriarchi di Costantinopoli ad emanciparsi dalla guida
del papa di Roma, tensioni politiche che opposero gli imperatori orientali alla dinastia
franca che, appoggiata dal papato, non nascondeva le mire espansionistiche verso Oriente.
Imperatori e patriarchi operarono in senso convergente, per determinare lo S. che si
svolse in due tempi: dapprima si ebbe lo S. temporaneo (881- 886), in seguito lo S.
definitivo (1054). Nell’857 il patriarca di Costantinopoli Ignazio, e3nergico
oppositore della politica corrotta della corte, venne messo al bando e sostituito da
Fozio, legato alla famiglia imperiale, il quale, nonostante la fedeltà del popolo al
legittimo pastore, con pressioni e minacce riuscì a farsi riconoscere patriarca nel
sinodo di Costantinopoli. Ignazio allora si appellò a Nicolò I, che dichiarò
illegittima la nomina di Fozio, privandolo di ogni dignità ecclesiastica. (863). Fozio
reagì, convocando tutte le chiese d’Oriente ad un concilio generale, che dichiarò
decaduto Nicolò I e comminò la scomunica a quanti l’avevano seguito. Fra le accuse
rivolte alla Chiesa d’Occidente da parte di Fozio vi era quella di eresia per
l’introduzione nel Credo dell’espressione filioque, e quindi della tesi
che lo Spirito procede non solo dal Padre, come affermavano alcune chiese orientali, ma
anche dal Figlio. Dopo aver inutilmente tentato di coinvolgere nella disputa
l’imperatore germanico Lotario II, Fozio venne relegato in un convento, ed Ignazio,
ripreso possesso della cattedra vescovile, convocò a Costantinopoli un concilio
ecumenico, che condannò Fozio e riconobbe definitivamente la legittimità della carica di
Ignazio (877). Dopo la morte di Ignazio (877), Fozio riuscì ad installarsi di nuovo nella
sede patriarcale con l’approvazione di Giovanni VIII, quindi indisse un sinodo che
disconobbe le conclusioni del precedente concilio ecumenico. Nell’886
l’imperatore Leone fece rinchiudere Fozio in un convento, dove morì nell’891.
Ma in seguito, a causa del quarto matrimonio dell’imperatore Leone, si rinfocolarono
i contrasti tra Oriente ed Occidente, finché il patriarca Michele Cerulario determinò lo
S. definitivo, facendo chiudere tutte le chiese ed i monasteri di rito latino, e
riaffermando le accuse dottrinali contro la chiesa d’occidente. Nel 1954 Leone IX
scomunicò il patriarca ed i suoi seguaci, i quali a loro volta scomunicarono il papa di
Roma, rendendo irreparabile lo S. Nel XIV-XU secolo un altro grande S. minacciò la Chiesa
d’occidente. Alla morte di Gregorio IX (1378), che aveva posto fine alla cattività
avignonese riportando la sede pontificia a Roma, i cardinali romani chiesero
l’elezione di un papa italiano come garanzia della presenza papale a Roma. Ma
l’eletto, il vescovo di Bari Bartolomeo Prignano, divenuto papa con il nome di Urbano
VI, per la sua politica assolutistica suscitò molte opposizioni, che sfociarono nella
nomina di un antipapa nella persona di Roberto di Ginevra, il quale, assunto il nome di
Clemente VII, stabilì di nuovo la sua sede ad Avignone. Seguì un periodo di grande
confusione per la Chiesa occidentale, divisa tra due curie e due obbedienze. Neppure la
morte dei due pontefici riportò l’unità: il Sacro Collegio di Roma elesse
successivamente Bonifacio IX (1389-1404), Innocenzo VII (1404-06) e Gregorio XII
(1406-15); quello di Avignone Benedetto XIII (1394-1417). Una nuova complicazione venne
quando, per porre fine allo S., fu riunito il concilio di Pisa (1409) dal quale, anziché
la pacificazione, venne fuori un terzo pontefice, Alessandro V (1409-10), a cui successe
Giovanni XXIII (1410-15). Con l’appoggio dell’imperatore Sigismondo
d’Ungheria, Giovanni XXIII convocò un concilio a Costanza (1414-18) con
l’intento di estirpare l’eresia hussita (v.) che si stava diffondendo in Boemia,
di mettere fine allo S. e di operare una profonda riforma della Chiesa, il cui prestigio
era stato molto scosso dagli avvenimenti confusi degli ultimi anni. Gregorio e Benedetto
non si presentarono a Costanza, ed anche Giovanni, che pure aveva convocato il concilio
con l’illusione di uscirne vittorioso, fuggì da Costanza per l’ostilità che si
era creata intorno a lui a causa delle sue pretese di dominio. Il concilio continuò sotto
la presidenza a turno dei cardinali, che costrinsero Giovanni XXIII a ricomparire per
essere processato e deposto (1415). Allora Gregorio XII rinunciò al papato per far
cessare lo S., mentre Benedetto XIII, irremovibile nella difesa della sua carica, venne
pure deposto dal concilio (1417). L’11.11.1417 il conclave elesse il nuovo pontefice
Martino V, mettendo così fine al lungo S., e riportando ordine nella vita della Chiesa.
Ma i pericoli suscitati dall’affermazione dell’autorità assoluta dei pontefici
e dai conseguenti abusi, indussero i cardinali riuniti a costanza a stabilire
l’indizione periodica di concili che controllassero l’operato del papa,
rivendicando la superiorità di ogni decisione dogmatica e dottrinale.
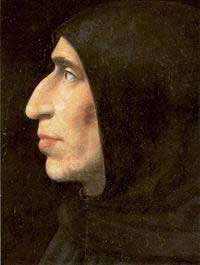 apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della
prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa
corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò
dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco
dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne
uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al
dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,
che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si
rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo
all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale
fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta
opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,
grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più
accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle
donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare
contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,
che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De
veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a
predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il
papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato
arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo
tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed
immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il
S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed
altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23
maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati
nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse
a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo
non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..
apocalittiche del S., arricchite ora di un nuovo elemento: l'annuncio della
prossima discesa in Italia di un vendicatore transalpino, che avrebbe castigato la Chiesa
corrotta gettando le basi per l'attesa rigenerazione. La discesa di Carlo VIII sembrò
dargli ragione, ed accrebbe enormemente il suo già grande prestigio. Priore di San Marco
dal 1491, sempre più in vista dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), il S. divenne
uno degli uomini più influenti della vita politica fiorentina, partecipando perfino al
dibattito costituzionale, così vivo e sentito in quegli anni. Intanto però Carlo VIII,
che il frate incontrò più di una volta senza poterne mai ottenere promesse concrete, si
rivelò alquanto venale e deludente, mentre le difficoltà per un uomo più avvezzo
all'oratoria che alla prassi politica di sostenersi nel marasma della crisi costituzionale
fiorentina si faceva evidente. Tuttavia il S. riuscì ancora a prevalere sulla violenta
opposizione degli Arrabbiati, che lo accusavano di connivenza con i medici esiliati,
grazie ad un largo seguito della borghesia e del popolo, conquistati dalla sua sempre più
accesa predicazione contro i vizi ed il lusso della vita mondana, i costumi corrotti delle
donne fiorentine, la cultura umanistica, il papato simoniaco e nepotista, in particolare
contro Alessandro VI Borgia. Firenze attraversò anzi un periodo di fanatismo collettivo,
che raggiunse il culmine con i famosi bruciamenti delle vanità, e con la proclamazione di Gesù Cristo a re di Firenze (Natale 1495). Di fronte ai ripetuti rifiuti del S. di recarsi a Roma per una spiegazione, Alessandro VI lo scomunicò (12 maggio 1497), minacciando di interdetto la città di Firenze se non gli fosse stato impedito di predicare. Il pericolo di perdere i lucrosi commerci con lo Stato Pontificio decise i fiorentini ad abbandonare S. alla sua sorte. Ma il frate non riconobbe la scomunica: scrisse più volte al papa, tentò di spiegare l’iniquità del provvedimento e difese le sue azioni, specie col Triumphus crucis e col De
veritate prophetica. La scomunica non venne revocata, ma S. tornò nuovamente a
predicare in duomo, scegliendo il testo biblico dell’Esodo (11 febbraio 1498). Il
papa reagì il 26 febbraio, ripetendo le minacce di interdetto se S non fosse stato
arrestato. Il 1° marzo S. predicò per l’ultima volta in duomo, ed il giorno dopo
tornò in San Marco da dove cricticò fortemente il papa per la sua corruzione ed
immoralità. Nel corso di gravi disordini venne assalito il convento di San Marco, ed il
S. imprigionato dalla Signoria, poi torturato, processato e condannato. Infine il S. ed
altri due frati domenicani (frà Silvestro Maruffi e frà Domenico Buonvicini) il 23
maggio 1498, alle ore 10 vennero impiccati, i loro cadaveri bruciati ed i resti gettati
nell'Arno, affinché "non se ne possi trovare reliquie, excepto non se ne andasse
a cercare nel fiume con la rete", come testimonia Pietro Somenzi. Un tentativo
non riuscito di disperdere e di annientare la memoria di un personaggio scomodo..