R.L.: Sigla massonica, quasi sempre scritta con i tre puntini (v.) in luogo dei punti,
da alcuni interpretata come Reale Loggia (v. Arte Reale), da altri, in maggioranza, come
Rispettabile Loggia (v. Abbreviazioni). In Germania è comunemente sostituita dalla sigla
J.L., dal significato di Johannis Loge (v. Massoneria Johannita))
R.S.A.A.: Sigla
abbreviativa designante il Rito Scozzese Antico ed Accettato (v.), talvolta modificata in
R.S.A.& A.
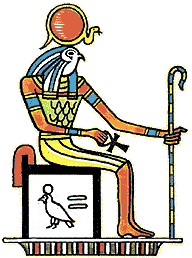 Ra: Antica divinità del
ricco pantheon egizio, fonte di energia, di calore e di luce. Ra (oppure Re’)
è all'origine della vita, è l'anima cosmica, il creatore e l'animatore dell'universo.
Come parte integrante, con Osiride, del ciclo giorno e notte, vita e morte, egli domina il
tempo. Durante le sedici ore della notte diviene Af, la materia putrida, il sole
nero, raffigurato da un corpo avvolto nelle bende, con la testa di ariete coronata dal
disco solare. Come incarnazione del principio regale che mantiene l'equilibrio del mondo,
ogni Faraone è Sa-Ra, figlio di Ra. I suoi attributi sono il disco solare con un
punto centrale, gli obelischi che rappresentano il primo raggio e la pietra Benben,
il perno del mondo, dove la fenice (il Bennu) va a consumarsi per poi rinascere.
Gli furono dedicati molti animali, tra cui la mangusta che divora i serpenti, il toro Mnevis,
il gatto maschio, il cobra, il falco e lo scarabeo Khepri. La triade Khepri-Ra-Atum
esprime una completa manifestazione della vita, Khepri al mattino, Ra a mezzogiorno e
Atum la sera. Il tempio di Ra, denominato Eliopoli (città del sole) dai greci,
portava il nome di Iunu, ovvero il Pilastro, o Perno del mondo. "Io sono
l'Eterno, sono Ra emerso dal Nun, sono il signore della Luce" (Testo dei
sarcofagi).
Ra: Antica divinità del
ricco pantheon egizio, fonte di energia, di calore e di luce. Ra (oppure Re’)
è all'origine della vita, è l'anima cosmica, il creatore e l'animatore dell'universo.
Come parte integrante, con Osiride, del ciclo giorno e notte, vita e morte, egli domina il
tempo. Durante le sedici ore della notte diviene Af, la materia putrida, il sole
nero, raffigurato da un corpo avvolto nelle bende, con la testa di ariete coronata dal
disco solare. Come incarnazione del principio regale che mantiene l'equilibrio del mondo,
ogni Faraone è Sa-Ra, figlio di Ra. I suoi attributi sono il disco solare con un
punto centrale, gli obelischi che rappresentano il primo raggio e la pietra Benben,
il perno del mondo, dove la fenice (il Bennu) va a consumarsi per poi rinascere.
Gli furono dedicati molti animali, tra cui la mangusta che divora i serpenti, il toro Mnevis,
il gatto maschio, il cobra, il falco e lo scarabeo Khepri. La triade Khepri-Ra-Atum
esprime una completa manifestazione della vita, Khepri al mattino, Ra a mezzogiorno e
Atum la sera. Il tempio di Ra, denominato Eliopoli (città del sole) dai greci,
portava il nome di Iunu, ovvero il Pilastro, o Perno del mondo. "Io sono
l'Eterno, sono Ra emerso dal Nun, sono il signore della Luce" (Testo dei
sarcofagi).
Rabbi: Termine ebraico ed
aramaico, avente il significato di mio Signore, o mio Maestro. Ai tempi di
Gesù era un appellativo rispettoso, impiegato soprattutto verso i dottori della Legge, i
cosiddetti rabbini. Nel Nuovo Testamento il termine ricorre solo nei vangeli e, ad
eccezione di Giovanni 3, 26 dove parla di San Giovanni Battista, è riferito
esclusivamente a Gesù.
Rabbino. Contaminazione
dell’ebraico rabbi (v.), mio maestro, e rabban, titolo del presidente
dell’Accademia ebraica palestinese. Il termine costituisce titolo onorifico
attribuito ad un uomo saggio, interprete della Bibbia e della Legge orale. Nel Medioevo
indicò anche il capo della comunità ebraica, mentre in Spagna ebbe rango di giudice.
Attualmente il R. ha quasi ovunque funzioni esclusivamente religiose, sia rituali che
educative.
Raca: Termine aramaico
spesso presente nel Talmud (v.), dal significato di vuoto, nel senso di incapace di
comprendere l’insegnamento impartito dal Maestro. Lo si trova anche nel Vangelo di Matteo
(26, 47-49): " … ma io vi dico: chiunque va in collera con suo fratello sarò
condannato in giudizio; e chi avrà chiamato R. suo fratello, sarà condannato nel
Sinedrio (v.)".
Radiestesia: Scienza
praticata in Cina nel 3000 a.C., trovò largo impiego in epoca etrusca e romana: gli
operatori erano rivestiti di funzioni sacerdotali. Nel Medioevo fu considerata pratica
diabolica, incorrendo nei rigori dell’autorità religiosa. Già usata nel XVI secolo
in Germania per ricerche minerarie, nel XVII secolo fu applicata per la ricerca di falde
acquifere sia in Gran Bretagna che in Francia, dove fu impiegata per finalità giuridiche:
famosa la scoperta effettuata nel 1692 dal rabdomante J. Aymar di uno degli assassini dei
coniugi Sauvatre. Propugnatore in Italia della R. è stato P. Zampa (1877-1944). Per vari
secoli la R. è stata considerata una pratica di probabile natura medianica, consistente
nella captazione di radiazioni emesse da sostanze o da corpi di norma nascosti nel
sottosuolo. Strumenti di ricerca sono il pendolo o la bacchetta (in quest’ultimo caso
si parla di rabdomanzia). Essa implica lo sfruttamento di facoltà sensoriali di
norma ignorate, ma di cui ogni essere umano sarebbe dotato. Il fenomeno si manifesta
mediante torsione della bacchetta ed oscillazioni o rotazione del pendolo;
l’interpretazione di tali momenti è connessa alla sensibilità dell’operatore.
La R. è da poco diventata materia di studio scientifico ed universitario in molti paesi,
ed avrebbe carattere biofisico: correnti radioattive ecciterebbero il sistema nervoso
dell’operatore, provocando involontarie contrazioni muscolari che causano il
movimento dello strumento impiegato. Secondo altri studiosi invece la R. costituirebbe una
forma paranormale di conoscenza (criptestesia). La Teleradiestesia compie
ricerche con il pendolo su persone o terreni anche lontani dall’operatore, purché
questi disponga di fotografie delle persone o di mappe dei terreni in oggetto. La R.
verrebbe oggi anche applicata per diagnosi di patologie a distanza, nell’inseguimento
di criminali, in teleprospezioni di cadaveri sepolti o sommersi, e di giacimenti minerari
o di tesori nascosti.
Ragione e Fede: Rapporto
già manifestato nella sapienza di Israele e, nei primi secoli cristiani, nella teologia
dei Padri della Chiesa. Entrambe le testimonianze esprimono una fondamentale simpatia
della fede per le capacità ed i cammini dell’intelligenza, ma rivelano anche il
carattere paradossale con cui spesso la fede si presenta, scontrandosi con le certezze
della ragione e le costruzioni della filosofia. La sintesi trasmessa dal cristianesimo
primitivo, come la sapienza biblica, vede la ragione operante all’interno della
visione del mondo e della storia offerta dalla fede. Nel secondo millennio la relazione
tra ragione e fede presenta aspetti nuovi. La teologia scolastica medievale tenta di
organizzare in sistema razionale la verità della fede. L’assunzione della filosofia
di Aristotele, da parte di Abelardo e di San Tommaso d’Aquino, impegna la fede al
dialogo con una costruzione della ragione autonoma dalla fede stessa. Infine la sfiducia
nella ragione, generata dall’involuzione della scolastica (XIV secolo), incrementa la
separazione, quasi che la ragione sia un ostacolo alla fede. Questa posizione è
caratteristica della Riforma protestante, mentre da parte cattolica si accentua la fiducia
nelle capacità dell’uomo, tra cui è fondamentale proprio la ragione. La tensione
tra le confessioni cristiane e l’attenzione del pensiero occidentale per la questione
delle forme e dei metodi della conoscenza, hanno fatto del problema del rapporto R.F. un
tipico problema moderno. Un’equilibrata soluzione è stata offerta dal magistero del
concilio Vaticano I, che ha difeso la capacità innata della ragione umana di giungere
alla conoscenza di Dio, ma ha affermato anche il sicuro accesso a Lui che la fede offre
all’umanità, nella condizione ferita in cui essa esiste nella storia. Inoltre il
concilio ha affermato la trascendenza della verità offerta dalla fede rispetto alle
capacità della ragione e, viceversa, la necessità della fede di presentarsi come atto
ragionevole e non cieco. Nella riflessione del XX secolo, la questione è stata liberata
da formalismi astratti. Ragione e fede appaiono intricate saldamente tra loro, sia perché
la ragione scopre una dimensione fiduciale intrinseca ai propri dinamismi di accesso alla
verità, sia perché la fede prende coscienza dei condizionamenti linguistici, dialettici
e culturali che ne segnano intrinsecamente ogni espressione.
Ragione: Scienza,
dottrina. Facoltà di pensare stabilendo rapporti e legami tra diversi concetti, e di
giudicare bene discernendo il vero dal falso, il giusto dall'errato. Nel linguaggio
filosofico s'intende sia la facoltà discorsiva del pensiero umano sia il fondamento
oggettivo ed intelleggibile di qualcosa. Tradizionalmente la R. distingue la facoltà di
conoscere l'universale, aprendo diatribe quantitative tra la conoscenza umana (razionale)
e quella animale (istinto), nonchè qualitativa tra R. umana (discorsiva) e divina
(intuizione). La Scolastica nell'analisi della differenza tra R. ed intelletto ha avviato
praticamente lo studio della differenza tra la conoscenza come ricerca e deduzione
(discorso) e la conoscenza come intuizione e penetrazione dell'universale. L'orientamento
razionalistico della filosofia moderna, da Cartesio all'Illuminismo, porta a concepire la
R. essenzialmente come guida e regola universale di condotta teorica e pratica. Secondo la
concezione radicale di Hume, R. ed abitudine rappresentano "un meraviglioso ed
inintelleggibile istinto dell'anima che ci trasporta per una serie di idee e le
arricchisce di qualità particolari a seconda delle diverse situazioni a relazioni".
Grandi filosofi moderni come Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer e Nietzsche hanno
approfondito l'argomento, su cui si sono sviluppate svariate ipotesi interpretative. Y (G.O.I.) Il termine R. si presenta sotto una grande
quantità di significati non sempre coerenti. Al ricercatore interiore dovrebbe
interessare soprattutto il rapporto razionale fra potenza (v.) ed azione. L'aggettivo razionale
deve però essere approfondito. La potenza e l'azione, essendo riferiti a noi stessi,
comportano un rapporto esistenziale. Ne consegue che la razionalità assume un aspetto
molto più vasto di quello che normalmente le viene attribuito nei casi dove sia possibile
e più facile arrivare a definizioni. Se da un lato possiamo sempre parlare di logica
raziocinante, da un altro dobbiamo anche prendere in considerazione gli equilibri di
giudizio ed anche le responsabilità inerenti a tali equilibri. In altri termini, la R.
non può essere considerata in modo del tutto astratto. Appare invece necessaria una
partecipazione distaccata, ma sempre decisamente individuale (v. Ragione e Fede).
 Raimondo
di Sangro: Principe di San Severo, Duca di Torremaggiore
(1710-1771), fu uno dei personaggi più complessi, discussi e controversi della storia
napoletana del XVIII secolo. Intorno alla sua figura ruotano molti miti e leggende, che
evocano misteri e segreti impregnanti la sua attività di scienziato, chimico, alchimista,
militare e mecenate, noto soprattutto per le sue invenzioni, quali le macchine belliche
e le macabre macchine anatomiche (v.), ben più che per le sue eccezionali
doti umane e sociali, per lo più ignorate dai biografi superficiali che se ne sono
interessati. Rampollo di una illustre casata di antica discendenza carolingia, legata alla
casa di Borgogna (di cui condivideva il blasone nobiliare), titolare nel regno di Napoli
di oltre 600 feudi, fu avviato alla carriera militare, ove raggiunse presto il grado di
maresciallo del Regio Esercito napoletano. Ancor giovane ufficiale, scrisse un’Enciclopedia
universale sull’arte della guerra ed un approfondito Trattato sui sistemi di
fortificazione, arrivando a realizzare alcune apprezzate invenzioni, come la Carrozza
anfibia. Nel 1735 venne iniziato alla Massoneria presso la Loggia La perfetta
Unione, cui aderì con entusiasmo, incurante della recente scomunica papale.
L’eccezionale carisma di cui era dotato lo portò presto ad assumervi la carica di
Maestro Venerabile, attivandosi per l’adozione degli alti gradi templari detti "di
Vendetta", nell’ambito del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Dopo
l’elevazione alla carica di Gran Maestro, dava poi alle Logge napoletane una prima
completa stesura della Costituzione Massonica, sfruttando una sua attivissima tipografia.
Per natura era spoglio di ogni falsa deferenza nei confronti dei potenti, sia verso il suo Re Carlo III che al cospetto di papa Clemente XII e dei
suoi biechi servi napoletani (il card. Spinelli ed il mons. Francesco Maria Pepe).
Eccezionale (ed incompreso) protettore dei fratelli massoni, non esitò ad adottare ogni
misura valida a consentire il prosieguo dell’attività delle Logge, a dispetto degli
innumerevoli tentativi persecutori attuati direttamente ed indirettamente dalla Chiesa.
Attraverso la sua tipografia, creò ripetute occasioni per scagliarsi contro certi
atteggiamenti della corte pontificia: · con i "quipu"
incaici aveva prodotto un’opera apologetica sulla scrittura con le cordicelle
policrome annodate, un sistema di scrittura sofisticato che il R. (noto come o’
Principe) aveva tradotto anche in chiave alchemica, ma che la miopia della Chiesa aveva
definito "merce del demonio", rendendosi artefice della totale
distruzione di immensi patrimoni culturali compresi in intere ricche biblioteche; · con la pubblicazione dell’opera già all’indice "Il
Conte di Gabalis, ovvero ragionamento sulle scienze segrete", diffondeva le
antiche tesi rosacrociane; · grande scalpore suscitava però
un suo trattato, diffuso nel 1746, dal titolo "Relazione della Compagnia dé
Liberi Muratori", edito quale opera di divulgazione della Massoneria, di richiamo
ai suoi principi universali, non asserviti ad alcun potere spirituale o temporale, in
aspra polemica con il feroce dogmatismo della Santa Romana Chiesa. R. auspicava la
divulgazione di una Massoneria universale cosmopolita fortemente esoterica, il che
scontentava sia i massoni intrallazzati con il potere politico e religioso, sia il sovrano
turbato dalle voci di cospirazione fomentate all’interno delle Logge, sia il papa per
la presenza tra i massoni di alti prelati come il vescovo di Avellino, Benedetto Latilla,
Grande Oratore dello stesso Gran Maestro. Il 17 giugno del 1751, nel turbamento creatosi
per il mancato miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, R. viene convocato
dal re Carlo III, pressato dal papa Benedetto XV, che pretende ed ottiene rassicurazioni
sui pacifici intendimenti della Massoneria, e lo convince a tranquillizzare anche la Curia
Romana attraverso una lunga e dotta epistola, redatta in forbito latino ed il italiano
volgare. Essa si rivelò un atto di grande umiltà e di profondo rispetto, mai di
sudditanza nei confronti della Chiesa, un’esaltazione dei valori etico morali della
Libera Muratoria di ispirazione templare, respingendo e disconoscendo certe derivazioni
controllate da avventurieri e sobillatori. Quando R. fu costretto a consegnare al re un
elenco di affiliati, con personaggi ambigui, ininfluenti e comunque ben poco massoni (che
comunque uscirono assolutamente indenni dalle intricate maglie di ben quattro diverse
commissioni d’inchiesta, istituite per i nobili, per i militari, per i religiosi e
per i membri della borghesia, grazie all’amicizia tra R. ed il re), molte frange
massoniche accusarono aspramente R. di alto tradimento. Il Principe R. fu bersagliato da
più parti dalle accuse più infamanti, come stregoneria e necromanzia (le macchine
anatomiche), che non si lasciò distogliere dal suo intento di dedicarsi per intero
all’Arte Reale, realizzando il "Lume Eterno". Negli ultimi anni di
vita R. fondò una Loggia degli Eletti, dalle caratteristiche esclusive, non per
casta o censo, ma per le doti richieste a chi voleva farne parte. Si trattava di qualità
umane e culturali richieste dal livello dei Lavori svolti nel suo Tempio, incentrati
sull’ermetismo, sulla cabala, sull’alchimia e sulle conoscenze templari, aspetti
esoterici che, criptati e simboleggiati, avrebbe riversato a piene mani nelle grandiose
opere d’arte del suo Tempio della Pietà, o Pietatella (v.).
Raimondo
di Sangro: Principe di San Severo, Duca di Torremaggiore
(1710-1771), fu uno dei personaggi più complessi, discussi e controversi della storia
napoletana del XVIII secolo. Intorno alla sua figura ruotano molti miti e leggende, che
evocano misteri e segreti impregnanti la sua attività di scienziato, chimico, alchimista,
militare e mecenate, noto soprattutto per le sue invenzioni, quali le macchine belliche
e le macabre macchine anatomiche (v.), ben più che per le sue eccezionali
doti umane e sociali, per lo più ignorate dai biografi superficiali che se ne sono
interessati. Rampollo di una illustre casata di antica discendenza carolingia, legata alla
casa di Borgogna (di cui condivideva il blasone nobiliare), titolare nel regno di Napoli
di oltre 600 feudi, fu avviato alla carriera militare, ove raggiunse presto il grado di
maresciallo del Regio Esercito napoletano. Ancor giovane ufficiale, scrisse un’Enciclopedia
universale sull’arte della guerra ed un approfondito Trattato sui sistemi di
fortificazione, arrivando a realizzare alcune apprezzate invenzioni, come la Carrozza
anfibia. Nel 1735 venne iniziato alla Massoneria presso la Loggia La perfetta
Unione, cui aderì con entusiasmo, incurante della recente scomunica papale.
L’eccezionale carisma di cui era dotato lo portò presto ad assumervi la carica di
Maestro Venerabile, attivandosi per l’adozione degli alti gradi templari detti "di
Vendetta", nell’ambito del Rito Scozzese Antico ed Accettato. Dopo
l’elevazione alla carica di Gran Maestro, dava poi alle Logge napoletane una prima
completa stesura della Costituzione Massonica, sfruttando una sua attivissima tipografia.
Per natura era spoglio di ogni falsa deferenza nei confronti dei potenti, sia verso il suo Re Carlo III che al cospetto di papa Clemente XII e dei
suoi biechi servi napoletani (il card. Spinelli ed il mons. Francesco Maria Pepe).
Eccezionale (ed incompreso) protettore dei fratelli massoni, non esitò ad adottare ogni
misura valida a consentire il prosieguo dell’attività delle Logge, a dispetto degli
innumerevoli tentativi persecutori attuati direttamente ed indirettamente dalla Chiesa.
Attraverso la sua tipografia, creò ripetute occasioni per scagliarsi contro certi
atteggiamenti della corte pontificia: · con i "quipu"
incaici aveva prodotto un’opera apologetica sulla scrittura con le cordicelle
policrome annodate, un sistema di scrittura sofisticato che il R. (noto come o’
Principe) aveva tradotto anche in chiave alchemica, ma che la miopia della Chiesa aveva
definito "merce del demonio", rendendosi artefice della totale
distruzione di immensi patrimoni culturali compresi in intere ricche biblioteche; · con la pubblicazione dell’opera già all’indice "Il
Conte di Gabalis, ovvero ragionamento sulle scienze segrete", diffondeva le
antiche tesi rosacrociane; · grande scalpore suscitava però
un suo trattato, diffuso nel 1746, dal titolo "Relazione della Compagnia dé
Liberi Muratori", edito quale opera di divulgazione della Massoneria, di richiamo
ai suoi principi universali, non asserviti ad alcun potere spirituale o temporale, in
aspra polemica con il feroce dogmatismo della Santa Romana Chiesa. R. auspicava la
divulgazione di una Massoneria universale cosmopolita fortemente esoterica, il che
scontentava sia i massoni intrallazzati con il potere politico e religioso, sia il sovrano
turbato dalle voci di cospirazione fomentate all’interno delle Logge, sia il papa per
la presenza tra i massoni di alti prelati come il vescovo di Avellino, Benedetto Latilla,
Grande Oratore dello stesso Gran Maestro. Il 17 giugno del 1751, nel turbamento creatosi
per il mancato miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, R. viene convocato
dal re Carlo III, pressato dal papa Benedetto XV, che pretende ed ottiene rassicurazioni
sui pacifici intendimenti della Massoneria, e lo convince a tranquillizzare anche la Curia
Romana attraverso una lunga e dotta epistola, redatta in forbito latino ed il italiano
volgare. Essa si rivelò un atto di grande umiltà e di profondo rispetto, mai di
sudditanza nei confronti della Chiesa, un’esaltazione dei valori etico morali della
Libera Muratoria di ispirazione templare, respingendo e disconoscendo certe derivazioni
controllate da avventurieri e sobillatori. Quando R. fu costretto a consegnare al re un
elenco di affiliati, con personaggi ambigui, ininfluenti e comunque ben poco massoni (che
comunque uscirono assolutamente indenni dalle intricate maglie di ben quattro diverse
commissioni d’inchiesta, istituite per i nobili, per i militari, per i religiosi e
per i membri della borghesia, grazie all’amicizia tra R. ed il re), molte frange
massoniche accusarono aspramente R. di alto tradimento. Il Principe R. fu bersagliato da
più parti dalle accuse più infamanti, come stregoneria e necromanzia (le macchine
anatomiche), che non si lasciò distogliere dal suo intento di dedicarsi per intero
all’Arte Reale, realizzando il "Lume Eterno". Negli ultimi anni di
vita R. fondò una Loggia degli Eletti, dalle caratteristiche esclusive, non per
casta o censo, ma per le doti richieste a chi voleva farne parte. Si trattava di qualità
umane e culturali richieste dal livello dei Lavori svolti nel suo Tempio, incentrati
sull’ermetismo, sulla cabala, sull’alchimia e sulle conoscenze templari, aspetti
esoterici che, criptati e simboleggiati, avrebbe riversato a piene mani nelle grandiose
opere d’arte del suo Tempio della Pietà, o Pietatella (v.).
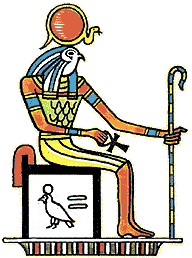 Ra: Antica divinità del
ricco pantheon egizio, fonte di energia, di calore e di luce. Ra (oppure Re’)
è all'origine della vita, è l'anima cosmica, il creatore e l'animatore dell'universo.
Come parte integrante, con Osiride, del ciclo giorno e notte, vita e morte, egli domina il
tempo. Durante le sedici ore della notte diviene Af, la materia putrida, il sole
nero, raffigurato da un corpo avvolto nelle bende, con la testa di ariete coronata dal
disco solare. Come incarnazione del principio regale che mantiene l'equilibrio del mondo,
ogni Faraone è Sa-Ra, figlio di Ra. I suoi attributi sono il disco solare con un
punto centrale, gli obelischi che rappresentano il primo raggio e la pietra Benben,
il perno del mondo, dove la fenice (il Bennu) va a consumarsi per poi rinascere.
Gli furono dedicati molti animali, tra cui la mangusta che divora i serpenti, il toro Mnevis,
il gatto maschio, il cobra, il falco e lo scarabeo Khepri. La triade Khepri-Ra-Atum
esprime una completa manifestazione della vita, Khepri al mattino, Ra a mezzogiorno e
Atum la sera. Il tempio di Ra, denominato Eliopoli (città del sole) dai greci,
portava il nome di Iunu, ovvero il Pilastro, o Perno del mondo. "Io sono
l'Eterno, sono Ra emerso dal Nun, sono il signore della Luce" (Testo dei
sarcofagi).
Ra: Antica divinità del
ricco pantheon egizio, fonte di energia, di calore e di luce. Ra (oppure Re’)
è all'origine della vita, è l'anima cosmica, il creatore e l'animatore dell'universo.
Come parte integrante, con Osiride, del ciclo giorno e notte, vita e morte, egli domina il
tempo. Durante le sedici ore della notte diviene Af, la materia putrida, il sole
nero, raffigurato da un corpo avvolto nelle bende, con la testa di ariete coronata dal
disco solare. Come incarnazione del principio regale che mantiene l'equilibrio del mondo,
ogni Faraone è Sa-Ra, figlio di Ra. I suoi attributi sono il disco solare con un
punto centrale, gli obelischi che rappresentano il primo raggio e la pietra Benben,
il perno del mondo, dove la fenice (il Bennu) va a consumarsi per poi rinascere.
Gli furono dedicati molti animali, tra cui la mangusta che divora i serpenti, il toro Mnevis,
il gatto maschio, il cobra, il falco e lo scarabeo Khepri. La triade Khepri-Ra-Atum
esprime una completa manifestazione della vita, Khepri al mattino, Ra a mezzogiorno e
Atum la sera. Il tempio di Ra, denominato Eliopoli (città del sole) dai greci,
portava il nome di Iunu, ovvero il Pilastro, o Perno del mondo. "Io sono
l'Eterno, sono Ra emerso dal Nun, sono il signore della Luce" (Testo dei
sarcofagi).