Naasseni: Termine derivato dall’ebraico nahash, serpente, usato quale sinonimo
di gnostici, noti soltanto attraverso una lunga notizia di Ippolito di Roma. Probabilmente
appartenevano alla gnosi egizia, poiché due testi tramandati dai papiri di Nag-Hammadi
(v.) sembrano coincidere con quelli sacri alla setta. Il culto del serpente che li
caratterizza li fa rientrare tra gli gnostici Ofiti (dal greco ofiz,
serpente), intesi nella loro accezione più generale,
 Nabucodonosor: Famoso
re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico
Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,
succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò
alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una
principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la
sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un
tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e
civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata
di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,
delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio
è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.
Nabucodonosor: Famoso
re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico
Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,
succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò
alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una
principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la
sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un
tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e
civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata
di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,
delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio
è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.
Nadi: Termine sanscrito
indicante i centri di forza, o canali, appartenenti al corpo astrale (v.)
dell’individuo. I tre N. principali sono: · 1) Sushumna,
ubicato all’interno del midollo spinale; · 2) Ida,
scorrente accanto a Sushumna; · 3) Pingala, che scorre
accanto e parallelamente a Sushumna, ma sul lato opposto rispetto ad Ida. Lungo il
percorso dei N. si incontrano i Chakras (v.),
Nadir: Opposto
(dall’arabo nazir) allo Zenit, è il punto di intersezione della verticale del
luogo con la sfera celeste, situato sotto l’osservatore. Viene definita direzione del
N. la direzione della verticale del luogo, orientata verso il basso.
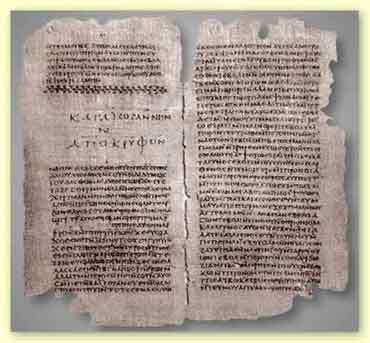 Nag Hammadi: Centro
dell’Alto Egitto, nella provincia di Qina, sulla sponda sinistra del Nilo. Nei suoi
pressi sono stati rinvenuti nel 1946 tredici codici papiracei (denominati papiri di N.)
contenuti in una giara occultata forse all’inizio del V secolo, in una tomba pagana
dell’antica Diospolis Parva, diventata poi il villaggio e quindi il monastero
pacomiano di Khenoboskion. I codici si trovano oggi al Museo Copto del Cairo, tranne il
codice Jung, posseduto dall’Istituto omonimo di Zurigo. I papiri di N. tramandano 56
testi (di cui ben 42 diversamente ignoti) prodotti da gruppi gnostici diversi, e copiati
fra il III ed il IV secolo d.C., per lo più in copto (saidico).
Nag Hammadi: Centro
dell’Alto Egitto, nella provincia di Qina, sulla sponda sinistra del Nilo. Nei suoi
pressi sono stati rinvenuti nel 1946 tredici codici papiracei (denominati papiri di N.)
contenuti in una giara occultata forse all’inizio del V secolo, in una tomba pagana
dell’antica Diospolis Parva, diventata poi il villaggio e quindi il monastero
pacomiano di Khenoboskion. I codici si trovano oggi al Museo Copto del Cairo, tranne il
codice Jung, posseduto dall’Istituto omonimo di Zurigo. I papiri di N. tramandano 56
testi (di cui ben 42 diversamente ignoti) prodotti da gruppi gnostici diversi, e copiati
fra il III ed il IV secolo d.C., per lo più in copto (saidico).
Nana: Divinità
appartenente al pantheon assiro-babilone, collegata alla generazione ed alla fecondità.
Di probabile origine indiana, forse derivata da Paredra di Nabù ed assimilata ad Istar,
dea della passione erotica, ebbe un culto estremamente licenzioso, comprendente la
prostituzione sacra. Nel sincretismo iranico mesopotanico, sia N. che Istar furono
identificate con Anahita. N. ricompare anche nella mitologia frigia, come figlia
del re fiume Sangario, e madre di Attis (v.).
Naos: Termine derivato dal
greco naoz, abitazione, indicante la cella del tempio ellenico,
ossia la parte più interna dell’edificio religioso, dove era situata la statua della
divinità. A pianta rettangolare, la cella aveva come unica apertura la porta di accesso,
sull’asse del tempio, in direzione della facciata principale. Quando le dimensioni
del N. erano notevoli, una o due file di colonnati ne sostenevano la copertura.
Natale: Festività
cristiana, fissata dalla Chiesa cattolica il 25 dicembre, data convenzionale della nascita
di Gesù Cristo. La festa fu istituita a Roma nel 336, e si diffuse nel corso del IV
secolo. Il primo accenno al N. risale alla Depositio Martyrum (354) di Dionisio
Filocalo, il quale rileva anche la sua corrispondenza con la festa pagana del dies
natalis solis invicti (la nascita di Mithra, v.). Ippolito, nel Commentarium in
Danielem, fissa il N. al 24 dicembre del 42° anno di Augusto Tertulliano (II secolo),
mentre Origene (II-III secolo, v.) ignora del tutto la festività natalizia. Tuttavia la Depositio
Episcoporum conferma la celebrazione del N. in data 25 dicembre dell’anno 336.
Dal VI secolo la liturgia cattolica prevede la celebrazione di tre messe da parte di ogni
sacerdote, simbolo della triplice nascita di Cristo: nell’eternità del Padre, nel
tempo da Maria, e nell’anima dai cristiani. A mezzanotte (dal concilio di Efeso,
431), all’alba o ad auroram (inizio VI secolo) ed al mattino (dal IV secolo).
Dopo l’anno 1000 l’uso delle tre messe si estese a tutto l’occidente
cristiano. Mentre il rito occidentale distingue tra N. (nascita di Gesù) ed Epifania
(adorazione dei Magi, v.), quello orientale accoglie la sola Epifania (battesimo di
Gesù). Nel folklore, il N. è la più tradizionale delle feste cristiane, e trova
espressione nelle diffusissime usanze del ciocco natalizio, del Presepe introdotto da San
Francesco d’Assisi (v.), dell’albero di N. e di Babbo N. La tradizione del
ceppo, collegata con l’antica festa pagana del fuoco del solstizio invernale, è
diffusa nelle campagne francesi, tedesche, inglesi, italiane (Umbria e Romagna); le ceneri
del ciocco di quercia, conservate poi per tutto l’anno, nel periodo tra N e
l’Epifania successiva vengono sparse nei campi, con diverse modalità. L’albero
di N., collegato con riti propiziatori di tipo agrario, è di origine relativamente
recente (inizio XVI secolo), e si diffuse poi in Germania (Weihnachtsbaum, o Christbaum),
nel territorio parigino, in Italia, nei paesi scandinavi ed in Russia; sotto
l’albero, un abete illuminato ed adorno, vengono posti i doni; in Italia la
tradizione dell’albero si fuse, dopo l’ultimo dopoguerra, con quello locale del
presepe. Babbo N., di origine celtica, diffuso nei paesi germanici ed anglosassoni, è
caratterizzato dalla veste rossa e dalla lunga barba bianca; si collega con il popolare
San Nicola di Bari (il tedesco Sanctus Nicholaus, popolarmente Santa Claus o
Klaus). Al N. si ispirano anche numerosi canti popolari, tra i quali i più celebri
sono l’italiano Adeste Fidelis ed il tedesco Stille Nacht.
All’usanza del ciocco natalizio si possono collegare anche quelle dei fuochi e dei
falò. La Massoneria collega il N. con il solstizio d’inverno (come evento cosmico) e
con la festività di San Giovanni Evangelista (patrono dell’Istituzione), e celebra
ritualmente la festa della Luce (v.).
Nathan Ernesto: Uomo
politico italiano di origine inglese (Londra 1845-Roma 1921). Fu uomo di fiducia di
Mazzini, anche perché era molto amico della madre Sara Levi. A Milano diresse dal 1862 il
giornale l’Unità d’Italia, e nel 1870 si trasferì’ a Roma. Membro
illustre della Massoneria, ne divenne Gran Maestro (1896-1904), mantenendo le redini
dell’Istituzione con grande vigore, e consacrando alla propaganda ed alla difesa dei
principi tutta la sua meravigliosa energia del carattere e dell’ingegno (Ulisse
Bacci, Il Libro del massone italiano, Vol. II, pag. 488, Ediz. Forni, 1972).
Cittadino italiano dal 1888, partecipò alla vita pubblica nelle file dei radicali,
segnalandosi per il suo impegno anticlericale e, come sindaco di Roma dal 1907 al 1913,
per saggi provvedimenti amministrativi.
Natron: Carbonato sodico
decaidrato, chiamato anche natrite. Reperibile come incrostazione granulare,
polverulenta o bacillare e come effervescenza. Di colore bianco sporco o giallognolo, è
solubile in acqua. Fonde a 32°C., e reagisce violentemente con acido cloridrico. Si forma
nella stagione fredda nei laghi salati dell’Africa settentrionale, della Persia,
delle Americhe e della Russia asiatica. Ha larghe applicazioni industriali. È noto
soprattutto come prodotto base, impiegato nell’antico Egitto per la mummificazione
dei cadaveri umani prima della loro sepoltura.
Natura: Secondo la
Tradizione, il termine N. è sinonimo di Creato, e viene inteso in una forma assai più
ampia rispetto a quello che viene preso in considerazione dalle scienze naturali. La N. è
considerata il luogo dove si manifesta la vita, perciò comprende anche tutte quelle
manifestazioni che spaziano nell'indefinibile dello spirito. In questo senso include il
Macrocosmo ed il Microcosmo e, conseguentemente, tutte le creature e gli eventi che legano
in qualche modo i due mondi suddetti. Per questi motivi si deve proporre all'attenzione
dei ricercatori la presenza di Leggi naturali di grandissima portata spirituale, che
condizionano e regolano tutte le manifestazioni della vita. Sempre tradizionalmente viene
caldamente raccomandato ai ricercatori di cercare di leggere nel Gran Libro della N. Un
compito arduo che potrebbe forse essere facilitato se si partisse dalla semplice
considerazione che ogni essere non è altro che un tassello perfettamente inserito nel
gran mosaico della N. stessa, in cui il ricercatore stesso è al contempo artefice e
spettatore.
Naturismo: Movimento
formatosi a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, per opera di Saint-Georges de Bouhelier e
Maurice Le Blond, come reazione verso la civiltà industriale e l’urbanesimo. Nel
complesso il movimento tendeva ad un ritorno dell’uomo ad un’ipotizzata
preesistente vita naturale, alla cui base doveva esserci un contatto immediato con la
natura, da realizzarsi sia con un’alimentazione vegetariana sia con la
semplificazione del vestiario, fino alla sua totale soppressione (nudismo). In etnologia
si presenta come un indirizzo che riguarda i popoli primitivi, come legati a leggi
naturali. In medicina il N. riconosce alla natura capacità risanatrici, e si ricollega
all’ippocraticismo.
Navigazione: Termine corrente impiegato sia nel complesso delle apparecchiature elettroniche usate per il controllo automatico del volo aerospaziale, sia per definire l'attività di collegamento tra vari utenti della rete informatica internazionale (Internet). Negli ultimi decenni le informazioni a disposizione dell'essere umano sono diventate sempre più numerose. Probabilmente presto si potrebbe non essere più in grado di seguire direttamente il loro flusso. La conoscenza basata su sintesi dirette delle informazioni esplicitabili non sarà più possibile, dal punto di vista della completezza, per la maggior parte degli uomini. Saranno solo possibili, in materia di informazioni esplicite, sintesi di sintesi parziali, preparate da intermediari che cercheranno di portarle all'attenzione degli altri. Un tale tipo di conoscenza non appare essere particolarmente desiderabile per l'uomo libero. Non diversamente dal passato, sarà molto forte la tentazione di proporre informazioni in forma dogmatica. Tuttavia, la crescita collettiva interiore del genere umano rende sempre più improbabile una simile via, che costituirebbe un'involuzione vera e propria. Appare, perciò, sempre più probabile un'evoluzione che, pur utilizzando la massa delle informazioni esplicite, si dovrà basare essenzialmente sulla coscienza. In altre parole nel campo dell’informazione la coscienza delle forme dovrebbe giocare ruoli sempre più importanti nella crescita dell'umanità. Altrettanto si può ipotizzare per la percezione dell'intima natura dinamica delle informazioni stesse e delle forze ad esse legate. Non essendo possibile legare le forme e le forze a conoscenze esplicitabili, appare sin da ora che la responsabilità di interpretare artisticamente le informazioni ricada sui navigatori della coscienza. È per tali motivi che si dovrebbero incoraggiare le esperienze interiori basate sulla N. a vista, seguendo l'Arte, quindi l'Intuizione (v.) e le risonanze degli eventi con i valori sacrali individuali.
Nazareni: Termine
derivato dalla denominazione di Gesù Cristo, usata in Matteo 2, 23, in quanto
nativo di Nazareth (v.). Nome dispregiativo assegnato ai primi cristiani. Furono così
denominati anche i seguaci di una setta giudaizzante fiorita in Palestina nel II secolo,
che cercavano di conciliare le regole del culto ebraico con quello cristiano, riconoscendo
valido il solo Vangelo di Matteo. È anche il nome di alcune sette cristiane del XIX
secolo: N. ungheresi, fondata in Ungheria nel 1839, N. tedeschi, fondata in
Svizzera da J.J. Wirz (1778-1858) e diffusa poi anche nella Germania meridionale, Chiesa
del N., detta dei Seguaci di Cristo, fondata in California (Stati Uniti) nel
1895; questi praticano il battesimo per immersione, con l’imposizione delle mani, e
ritengono peccato grave il possesso di armi.
Nazareth: Città dello
Stato di Israele, capoluogo del distretto settentrionale a SE di Haifa, alle falde del
monte Tabor. È divisa nei tre quartieri: arabo, greco e latino. N. è indicata dai
Vangeli come il luogo in cui Maria ricevette l’Annunciazione, ed in cui Gesù
trascorse la sua giovinezza, dimorandovi fino al giorno del suo battesimo. "Morto
Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto, e gli disse: Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre, e va nel paese d’Israele; perché sono morti
coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua
madre, ed entrò nel paese d’Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea
Archelao al posto di re Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò
nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata N.,
perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: Sarà chiamato Nazareno"
(Matteo 2, 19-23). La città fu conquistata prima dagli Arabi (636) e poi dai
Crociati (1099), che la elessero a Vescovado, e venne rasa al suolo nel 1363 dal mamelucco
Baihars. I suoi monumenti furono in parte ricostruiti dai Francescani a partire dal 1620.
Oltre al santuario dell’Annunciazione, edificato nel 1620 ed ampliato nel 1730 e nel
1877, vi sorgono la chiesa ortodossa di San Gabriele (XVIII secolo) ed il forte di Dahur
el-‘Omar (1725).
Nazca: Civiltà precolombiana, sviluppatasi in
epoca preincaica nelle fertili valli di N., un’oasi agricola che è l’area di
produzione dei vini peruviani ubicata a Sud di Paracas, nel Perù meridionale. Circa 2.500
anni fa, N. era infatti il centro di tale civiltà, ed era molto avanzato sia in
astronomia che nell’arte ceramica. Caratteristica principale della ceramica N. è
l’ansa a ponte, che appoggia i due estremi su due tubi cilindro-conici che portano la
doppia imboccatura. Elemento predominante della decorazione sono le figure gorgoniche. Nel
IX secolo d.C. venne travolta da un movimento religioso militare e poi, definitivamente,
dall’occupazione incaica, che ne incorporò il territorio nell’impero di Cuzco.
Verso il 900 d.C. la regione di N. fu invasa da un popolo di montanari, provenienti dalla
roccaforte di Tihiauanaco, presso il lago Titicaca, a 3.800 metri sulle Ande boliviane. I
Tiahianaco portarono a Nord la tecnica delle "linee", tuttora visibili,
costituite da una serie di rettangoli e quadrati, o figure di enormi uccelli, ragni e
falene, tracciate sulla terra del deserto, lunghe a volte parecchi chilometri (da 0,5 ad
8); il loro significato è ancora oscuro. Nel deserto peruviano, a circa 320 km. a Sud di
Lima, si trova un altopiano posto tra le valli Inca e Nazca. Lungo tale altopiano, su
un’area che misura circa 60 km. di lunghezza per meno di due di larghezza, da un
aeromobile è visibile un complesso di linee perfettamente diritte, molte ad andamento
parallelo, altre che si intersecano, che formano enormi forme geometriche.
All’interno ed accanto a tali linee vi sono anche aree trapezoidali,  strani
simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono
essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché
inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le
avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda
molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare
che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.
Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per
consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale
destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che
visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che
l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un
astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una
riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle
linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza
fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.
Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore
inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti
delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato
rettilineo. I
strani
simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono
essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché
inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le
avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda
molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare
che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.
Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per
consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale
destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che
visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che
l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un
astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una
riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle
linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza
fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.
Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore
inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti
delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato
rettilineo. I 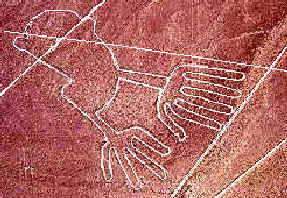 fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e
meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.
Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche
se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari
per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.
A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande
raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,
ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del
Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda
un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta
zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un
condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,
visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero
rimane ancora irrisolto.
fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e
meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.
Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche
se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari
per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.
A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande
raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,
ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del
Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda
un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta
zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un
condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,
visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero
rimane ancora irrisolto.
Nazirei: Termine
derivato dall’ebraico nazir, separato, presso gli antichi Ebrei indicava
individui consacrato temporaneamente a Yahweh mediante l’adempimento di determinati
voti (astinenza da alcoolici e bevande inebrianti) e di oblighi rituali (libera crescita
dei capelli ed astensione dai contatti con cadaveri). Furono N. Sansone (Giudici
13, 2-7; 16, 17), Samuele (I Samuele 1, 11) e lo stesso Paolo di Tarso (Atti
degli Apostoli 18, 18; 21, 23-26). L’uso continuò fino all’epoca talmudica
(IV-V secolo d.C.).
Neanderthal, Uomo di: Resti di uno scheletro di tipo umano ritrovati nel 1856 in una cava di calcare
nella valle di Neander, presso Düsseldorf, di cui diede notizia C. Fuhlrott. Questo
scheletro, il primo di una serie di reperti coevi in Europa ed in Asia Minore e Centrale
formanti tre gruppi razziali diversi, risale al periodo interglaciale riss-würmiana, ed
alla successiva glaciazione würmiana fra i 70.000 ed i 35.000 anni fa. L’uomo di N.,
per la fronte ed il mento appena segnato, lo sviluppo marcato delle arcate sopraorbitarie,
il collo corto e grosso, la statura intorno ai 150 cm., la positura eretta e la capacità
cerebrale compresa tra i 1200 ed i 1600 cmc., presenta tratti pitecoidi che ricordano il
pitecantropo ed il sinantropo. In molti luoghi i resti dell’Homo neanderthalensis sono
stati rinvenuti associati con l’industria mousteriana. In Italia i ritrovamenti sono
avvenuti nel Lazio, a Saccopastore ed al Circeo.
Necromanzia: V.
Negromanzia.
Necropoli: Termine
con cui si indica un gruppo di sepolcri di epoca anteriore a quella cristiana. Per
l’importanza data da sempre alla sepoltura ed al culto dei defunti in ogni tipo di
cultura e di società, la N. ha concentrato interessi e significati che sono rimasti
protetti nel tempo, e quindi disponibili agli studi archeologici molto più di quanto lo
sia stata qualsiasi altra opera costruita dall’uomo. La struttura della N. fu
determinata quando ancora la forma della città non aveva ragione d’essere, vivendo
le popolazioni in luoghi e modi differenziati e non stabilizzati. Appare quindi come una
prima definizione di quello che sarà in seguito lo schema urbano: fin dalle epoche più
remote ad es. in tutta la penisola italica le N. costituiscono, secondo forme diverse
corrispondenti a culture differenziate, vere e proprie organizzazioni urbane sotterranee
(Cassibile, N. delle stazioni terramaricole padane), che culminano nella visione
prettamente urbana o pianificata dello schema delle N. etrusche (Populonia, Tarquinia,
Chiusi, ecc.).
 Nabucodonosor: Famoso
re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico
Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,
succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò
alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una
principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la
sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un
tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e
civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata
di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,
delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio
è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.
Nabucodonosor: Famoso
re di Babilonia (m. 562 a.C.), figlio di Nabopolassar, più volte citato nell’Antico
Testamento. Si distinse per le sue imprese militari già sotto il regno del padre e,
succedutogli nel 604, inaugurò una fase politica di espansione, che nel 586 lo portò
alla conquista della Palestina ed alla distruzione di Gerusalemme. Sposo di una
principessa meda, intrattenne buoni rapporti con lo Stato iranico, garantendosi la
sicurezza dei confini orientali. Nonostante che la tradizione biblica lo presenti come un
tiranno crudele, il suo regno fu caratterizzato da una grande fioritura culturale e
civile, che si espresse nella costruzione di una Babilonia monumentale e splendida, dotata
di nuove mura, palazzi e templi, ed economicamente assai prospera: tutte opere di pace,
delle quali soprattutto il re si compiace nelle iscrizioni che ha lasciato. Al personaggio
è ispirata l’opera lirica Nabucco, dal diminutivo del nome.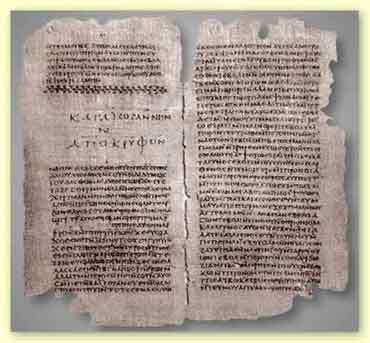
 strani
simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono
essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché
inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le
avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda
molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare
che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.
Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per
consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale
destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che
visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che
l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un
astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una
riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle
linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza
fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.
Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore
inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti
delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato
rettilineo. I
strani
simboli, e raffigurazioni di uccelli ed animali tracciati in scala gigantesca, che possono
essere individuate soltanto dall’alto. Infatti tali forme sono pressoché
inapprezzabili a livello del terreno, e non furono mai scoperte finché un idrovolante le
avvistò intorno al 1930. L’altopiano con tali forme, spesso rettangolari, ricorda
molto un aeroporto, tanto da indurre lo scrittore svizzero Erich von Damken ad ipotizzare
che fossero state tracciate per agevolare l’atterraggio di antiche navi aerospaziali.
Al riguardo occorre notare che il terreno dell’altopiano è troppo soffice per
consentire l’atterraggio di aeromobili. Resta quindi l’interrogativo su quale
destinazione avessero le forme di Nazca. L’esploratore americano Paul Kosok, che
visitò Nazca nel 1940, pensò che le linee avessero un significato astronomico, e che
l’altopiano venisse utilizzato come gigantesco osservatorio. Gerald Hawkins, un
astronomo americano, controllò tale teoria nel 1968, immettendo in un computer una
riproduzione delle linee, ed impiegando un programma di controllo delle coincidenze delle
linee con importanti eventi astronomici. Il numero di linee che trovarono una coincidenza
fu tanto irrilevante da far cadere del tutto la teoria dell’osservatorio.
Probabilmente la miglior teoria d’interpretazione fu elaborata dall’esploratore
inglese Tony Morrison che, effettuando ricerche sulle strade usate dagli antichi abitanti
delle montagne andine, scoprì una tradizione che interessava percorsi a tracciato
rettilineo. I 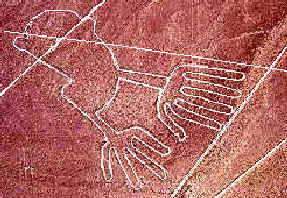 fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e
meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.
Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche
se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari
per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.
A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande
raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,
ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del
Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda
un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta
zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un
condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,
visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero
rimane ancora irrisolto.
fedeli si sarebbero spostati da tracciato a tracciato pregando e
meditando. Spesso il tracciato era semplicemente costituito da una pila di pietre.
Morrison è dell’opinione che le linee di Nazca avessero una finalità simile, anche
se su vasta scala. I simboli potevano essere impiegati quali accessori rituali particolari
per cerimonie religiose. Le linee di Nazca non sono le sole del genere esistenti in Perù.
A circa 1500 km a Sud, su un fianco della Montagna Solitaria, vi è la più grande
raffigurazione umana del mondo. Questo gigante, detto di Atacama, è alto circa 135 metri,
ed è circondato da linee del tutto simili a quelle di Nazca. Inoltre, lungo la costa del
Pacifico, ai piedi delle colline dei monti preandini, è disegnata una figura che ricorda
un gigantesco candelabro. Infine a Sud della Sierra Pintada (monte dipinto), una vasta
zona è ricoperta di grandi raffigurazioni comprendenti spirali, cerchi, guerrieri ed un
condor. Gli archeologi sono oggi in gran parte propensi a sostenere che tali figure,
visibilissime da terra, servissero da guida agli antichi mercanti Inca. Ma il mistero
rimane ancora irrisolto.