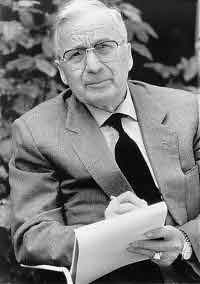 Loggia P2: Nel Grande
Oriente d'Italia è sempre esistita, fin dai tempi di Garibaldi (1877), una Loggia
composta di persone importanti che preferivano non rendere ufficiale la loro appartenenza
all'Istituzione, soprattutto per evitare il problema dei postulanti, ovvero le
inevitabili richieste di favori e raccomandazioni. Per tale motivo quella Loggia era stata
definita "Loggia coperta". In passato avevano fatto parte di questa
Loggia personaggi come Saffi, Carducci, Crispi, Bertani, Bovio, Regnoli ed Orlando. Resta
il fatto che la P2 non può essere definita vera Loggia massonica. Infatti, fin dalla sua
fondazione, era considerata un ricettacolo che potesse mantenere attivi e vincolati
all’Ordine uomini che, per la loro posizione sociale, non avrebbero potuto essere
membri di Logge ordinarie e soprattutto frequentarne i Lavori. Inoltre alcuni suoi membri
si reputavano troppo importanti per dover ripetere i gesti teatrali della
ritualità muratoria. Una premessa massonicamente aberrante. La Loggia infatti è il punto
d’incontro dei Liberi Muratori, che si riuniscono per la celebrazione dei riti
massonici, per la loro formazione culturale e spirituale, per l’approfondimento dei
rapporti fraterni ed il sostegno ad iniziative umanitarie. La P2 invece non si riuniva
mai. I suoi affiliati erano personalità del mondo politico, militare, finanziario ed
accademico, per le quali la superloggia era una sorta di salvacondotto che esonerava dalla
frequentazione dei Lavori massonici di una Loggia normale. A partire dal 1960 tale Loggia
("Propaganda 2", più nota come "P2"), subì una degenerazione di tipo essenzialmente affaristico, che coinvolse una minoranza dei suoi molti componenti. Era allora presieduta da un massone aretino, Licio Gelli, un Maestro Venerabile che si era conquistata la fiducia del Gran Maestro in carica Giordano Gamberini grazie alla sua grande efficienza organizzativa ed al suo dichiarato disinteresse verso promozioni all’interno dell’Ordine. Mentre la P2 si sviluppava incontrollatamente, superando il migliaio di affiliati, per lo più interessati ad inerpicarsi lungo i sentieri d’una ambiziosa scalata politica ed economica, inaccettabile sia per la Massoneria che per la società civile e democratica. Il Gelli sarebbe stato presto sistematicamente al centro delle attenzioni di tutti i mezzi di
Loggia P2: Nel Grande
Oriente d'Italia è sempre esistita, fin dai tempi di Garibaldi (1877), una Loggia
composta di persone importanti che preferivano non rendere ufficiale la loro appartenenza
all'Istituzione, soprattutto per evitare il problema dei postulanti, ovvero le
inevitabili richieste di favori e raccomandazioni. Per tale motivo quella Loggia era stata
definita "Loggia coperta". In passato avevano fatto parte di questa
Loggia personaggi come Saffi, Carducci, Crispi, Bertani, Bovio, Regnoli ed Orlando. Resta
il fatto che la P2 non può essere definita vera Loggia massonica. Infatti, fin dalla sua
fondazione, era considerata un ricettacolo che potesse mantenere attivi e vincolati
all’Ordine uomini che, per la loro posizione sociale, non avrebbero potuto essere
membri di Logge ordinarie e soprattutto frequentarne i Lavori. Inoltre alcuni suoi membri
si reputavano troppo importanti per dover ripetere i gesti teatrali della
ritualità muratoria. Una premessa massonicamente aberrante. La Loggia infatti è il punto
d’incontro dei Liberi Muratori, che si riuniscono per la celebrazione dei riti
massonici, per la loro formazione culturale e spirituale, per l’approfondimento dei
rapporti fraterni ed il sostegno ad iniziative umanitarie. La P2 invece non si riuniva
mai. I suoi affiliati erano personalità del mondo politico, militare, finanziario ed
accademico, per le quali la superloggia era una sorta di salvacondotto che esonerava dalla
frequentazione dei Lavori massonici di una Loggia normale. A partire dal 1960 tale Loggia
("Propaganda 2", più nota come "P2"), subì una degenerazione di tipo essenzialmente affaristico, che coinvolse una minoranza dei suoi molti componenti. Era allora presieduta da un massone aretino, Licio Gelli, un Maestro Venerabile che si era conquistata la fiducia del Gran Maestro in carica Giordano Gamberini grazie alla sua grande efficienza organizzativa ed al suo dichiarato disinteresse verso promozioni all’interno dell’Ordine. Mentre la P2 si sviluppava incontrollatamente, superando il migliaio di affiliati, per lo più interessati ad inerpicarsi lungo i sentieri d’una ambiziosa scalata politica ed economica, inaccettabile sia per la Massoneria che per la società civile e democratica. Il Gelli sarebbe stato presto sistematicamente al centro delle attenzioni di tutti i mezzi di  informazione, per oscure
grosse operazioni finanziarie, scandali d’ogni genere e propositi di interferenze
politiche (s’era addirittura parlato di golpe). Nella primavera del 1981 ne nacque
comunque un clamoroso scandalo che, a causa della notorietà dei personaggi coinvolti,
assunse grandi dimensioni, scatenando una campagna di stampa di straordinaria virulenza
diretta contro l’intera Istituzione Massonica. Dalle accuse di malversazione si
passò a quelle di golpismo, per cui quasi tutte le Case massoniche vennero
perquisite, le documentazioni e gli elenchi degli associati regolari sequestrati.
L'infondatezza di queste accuse fu riconosciuta dalla Corte di Assise di Roma che, il 16
aprile 1994, assolse Licio Gelli dall'accusa di cospirazione politica. Il caso si era
sgonfiato, ma non senza lasciare profonde cicatrici nelle Logge del Grande Oriente
d'Italia che, in seguito all'esperienza negativa, ha poi definitivamente assunto una
configurazione che inibisce in assoluto le Logge coperte. Il massone Lupi ha così
liquidato la pseudo fratellanza piduistica: "Dal ripristino integrale del costume
muratorio dovrà derivare la gioia del recupero della vera fraternità. Questa non è più
tale quando le è giocoforza imbattersi nella mortificante discriminazione, nella chiusura
di gruppo, la quale, insondabile e cristallina entro i delicati confini della docetica e
della maestranza, non è ammissibile nelle manifestazioni e nelle attività esterne,
quando a proprio libito coopta, oppure emargina ed isola. La fraternità, nella sfera
sottile, ha i suoi irrepetibili e incomunicabili afflati; ma sul piano delle attività
esteriori, organizzative o di governo, è in ultima istanza un fatto corale, e pertanto
non può prescindere da un costume di mutuo incontro: non si ama il fratello se non lo si
conosce, e nulla si edifica se lo si ignora". V. anche la voce P2.
informazione, per oscure
grosse operazioni finanziarie, scandali d’ogni genere e propositi di interferenze
politiche (s’era addirittura parlato di golpe). Nella primavera del 1981 ne nacque
comunque un clamoroso scandalo che, a causa della notorietà dei personaggi coinvolti,
assunse grandi dimensioni, scatenando una campagna di stampa di straordinaria virulenza
diretta contro l’intera Istituzione Massonica. Dalle accuse di malversazione si
passò a quelle di golpismo, per cui quasi tutte le Case massoniche vennero
perquisite, le documentazioni e gli elenchi degli associati regolari sequestrati.
L'infondatezza di queste accuse fu riconosciuta dalla Corte di Assise di Roma che, il 16
aprile 1994, assolse Licio Gelli dall'accusa di cospirazione politica. Il caso si era
sgonfiato, ma non senza lasciare profonde cicatrici nelle Logge del Grande Oriente
d'Italia che, in seguito all'esperienza negativa, ha poi definitivamente assunto una
configurazione che inibisce in assoluto le Logge coperte. Il massone Lupi ha così
liquidato la pseudo fratellanza piduistica: "Dal ripristino integrale del costume
muratorio dovrà derivare la gioia del recupero della vera fraternità. Questa non è più
tale quando le è giocoforza imbattersi nella mortificante discriminazione, nella chiusura
di gruppo, la quale, insondabile e cristallina entro i delicati confini della docetica e
della maestranza, non è ammissibile nelle manifestazioni e nelle attività esterne,
quando a proprio libito coopta, oppure emargina ed isola. La fraternità, nella sfera
sottile, ha i suoi irrepetibili e incomunicabili afflati; ma sul piano delle attività
esteriori, organizzative o di governo, è in ultima istanza un fatto corale, e pertanto
non può prescindere da un costume di mutuo incontro: non si ama il fratello se non lo si
conosce, e nulla si edifica se lo si ignora". V. anche la voce P2.
 Loggia: Termine derivato dal francese loge e dal franco tedesco laubja,
pergola. Ambiente le cui murature perimetrali sono in parte o completamente sostituite da
colonnati o pilastri, in modo da ottenere un ambiente coperto ma aperto su quasi tutti i
lati. La funzione della L. è di accogliere riunioni di persone od attività pubbliche al
riparo dalle intemperie, in climi nei quali non è necessaria una chiusura totale. La L.
permette inoltre di sfruttare i vantaggi del contatto con altri spazi pubblici aperti,
come una piazza, al pari di quanto offre il porticato. Loggetta o loggiato sono tremini
che indicano rispettivamente la L. usata a scopo decorativo più che funzionale, e la L.
con funzione di raccordo coperto tra due edifici. Tra i più famosi esempi di L.
ricordiamo al L. dei Lanzi a Firenze (XIV secolo), di Banci di Cione e Simone di Francesco
Talenti (1376-82), e la L. del Capitanio a Vicenza di Andrea Palladio (1565). Y (Massoneria) La L. rappresenta sia il locale (Tempio)
adibito alle riunioni rituali sia, estensivamente, l’assemblea stessa dei Fratelli.
Il nome deriva dalle baracche costruite sul luogo di lavoro dalle corporazioni edilizie
medievali, che servivano anche per le riunioni dei soci muratori e costruttori per la
discussione dei progetti di costruzione. Secondo il quinto principio concordato
nell’Assemblea di Torino del 1862 della Fratellanza dei liberi Muratori (v.), la
Loggia è il luogo particolare dove si riuniscono i L.M., nel quale essi apprendono ad
amare ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita, ed a
pensare, a volere ed a vivere come uomini completamente formati e padroni di sé, nello
spirito della Patria e dell'Umanità. Risvegliare e fortificare questo spirito,
contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni fratello, preparare e
sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei Lavori della Loggia. Y (G.O.I.) La L., corpo primario e fondamentale della Comunione, è la collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine. (Art. 16 della Costituzione dell'Ordine). La L. si riunisce almeno una volta al mese, lavora secondo la Costituzione, il Regolamento dell'Ordine ed il Regolamento interno. Il Regolamento interno (o di Loggia) non può contenere norme in difformità con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, e dev'essere approvato dalla Giunta del G.O.I. Le riunioni dei liberi Muratori si svolgono nel Tempio, con l'osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi. I Lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione. I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con la presenza di almeno sette Fratelli. In mancanza del Maestro Venerabile è necessaria la presenza delle altre Luci (Art. 50 del Regolamento dell'Ordine). La L. è composta dai Fratelli iscritti nel piè di lista della L. stessa. Ogni singola L., pur restando all'obbedienza del Grande Oriente, resta pienamente sovrana ed indipendente, sia sul piano organizzativo che a livello gestionale. Il nome di L. deriva simbolicamente dal luogo dove, nei cantieri medioevali, i muratori si riunivano per discutere i piani di costruzione delle cattedrali erette alla gloria di Dio. Perciò la L. costituisce il luogo dove i Massoni si riuniscono in assemblea per lavorare congiuntamente alla realizzazione del progetto del proprio ed altrui perfezionamento, in armonia con il progetto della vita. Il progetto viene concepito e vissuto sacralmente. Per questi motivi la L. viene chiamata Tempio, come simbolo della sacralità del Lavoro interiore che porta alla realizzazione del progetto. Talvolta la L. viene anche chiamata Officina, come simbolo del Lavoro che vi viene svolto. Per ulteriori dettagli sui diversi aspetti della L., v. anche: Struttura, Metodi, Competenze, Maestro Venerabile, Dignitari ed Ufficiali di Loggia, Consiglio delle Luci, Colpe e Sanzioni della Loggia e Cancellazione delle Logge.
Loggia: Termine derivato dal francese loge e dal franco tedesco laubja,
pergola. Ambiente le cui murature perimetrali sono in parte o completamente sostituite da
colonnati o pilastri, in modo da ottenere un ambiente coperto ma aperto su quasi tutti i
lati. La funzione della L. è di accogliere riunioni di persone od attività pubbliche al
riparo dalle intemperie, in climi nei quali non è necessaria una chiusura totale. La L.
permette inoltre di sfruttare i vantaggi del contatto con altri spazi pubblici aperti,
come una piazza, al pari di quanto offre il porticato. Loggetta o loggiato sono tremini
che indicano rispettivamente la L. usata a scopo decorativo più che funzionale, e la L.
con funzione di raccordo coperto tra due edifici. Tra i più famosi esempi di L.
ricordiamo al L. dei Lanzi a Firenze (XIV secolo), di Banci di Cione e Simone di Francesco
Talenti (1376-82), e la L. del Capitanio a Vicenza di Andrea Palladio (1565). Y (Massoneria) La L. rappresenta sia il locale (Tempio)
adibito alle riunioni rituali sia, estensivamente, l’assemblea stessa dei Fratelli.
Il nome deriva dalle baracche costruite sul luogo di lavoro dalle corporazioni edilizie
medievali, che servivano anche per le riunioni dei soci muratori e costruttori per la
discussione dei progetti di costruzione. Secondo il quinto principio concordato
nell’Assemblea di Torino del 1862 della Fratellanza dei liberi Muratori (v.), la
Loggia è il luogo particolare dove si riuniscono i L.M., nel quale essi apprendono ad
amare ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita, ed a
pensare, a volere ed a vivere come uomini completamente formati e padroni di sé, nello
spirito della Patria e dell'Umanità. Risvegliare e fortificare questo spirito,
contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni fratello, preparare e
sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei Lavori della Loggia. Y (G.O.I.) La L., corpo primario e fondamentale della Comunione, è la collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine. (Art. 16 della Costituzione dell'Ordine). La L. si riunisce almeno una volta al mese, lavora secondo la Costituzione, il Regolamento dell'Ordine ed il Regolamento interno. Il Regolamento interno (o di Loggia) non può contenere norme in difformità con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine, e dev'essere approvato dalla Giunta del G.O.I. Le riunioni dei liberi Muratori si svolgono nel Tempio, con l'osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi. I Lavori debbono avere inizio non prima che siano trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione. I Lavori non possono essere aperti in forma rituale se non con la presenza di almeno sette Fratelli. In mancanza del Maestro Venerabile è necessaria la presenza delle altre Luci (Art. 50 del Regolamento dell'Ordine). La L. è composta dai Fratelli iscritti nel piè di lista della L. stessa. Ogni singola L., pur restando all'obbedienza del Grande Oriente, resta pienamente sovrana ed indipendente, sia sul piano organizzativo che a livello gestionale. Il nome di L. deriva simbolicamente dal luogo dove, nei cantieri medioevali, i muratori si riunivano per discutere i piani di costruzione delle cattedrali erette alla gloria di Dio. Perciò la L. costituisce il luogo dove i Massoni si riuniscono in assemblea per lavorare congiuntamente alla realizzazione del progetto del proprio ed altrui perfezionamento, in armonia con il progetto della vita. Il progetto viene concepito e vissuto sacralmente. Per questi motivi la L. viene chiamata Tempio, come simbolo della sacralità del Lavoro interiore che porta alla realizzazione del progetto. Talvolta la L. viene anche chiamata Officina, come simbolo del Lavoro che vi viene svolto. Per ulteriori dettagli sui diversi aspetti della L., v. anche: Struttura, Metodi, Competenze, Maestro Venerabile, Dignitari ed Ufficiali di Loggia, Consiglio delle Luci, Colpe e Sanzioni della Loggia e Cancellazione delle Logge.
Logica: Disciplina
filosofica che studia le condizioni formali delle inferenze (v.) e del ragionamento deduttivo. La nascita della L. come scienza autonoma si deve ad Aristotele, il quale analizza gli oggetti propri della L. (concetti, categorie, proposizioni, termini e sillogismi) indipendentemente dal problema psicologico della loro origine e da quello del contenuto reale. Quest’ultimo aspetto del problema diventa l’oggetto proprio della L. medievale. Ci si chiede cioè se i generi e le specie (concetti predicabili di più cose) siano esistenti nelle cose stesse, e ne predichino i caratteri comuni, o se invece siano solo nomi che non esistono nelle cose né nell’intelletto: oppure ancora se essi esistano solo nell’intelletto e non nelle cose. È il cosiddetto problema delle universali (v.), al centro della disputa tra realisti e nominalisti. Con il Novum
Organum di Francesco Bacone, la L. diventa metodologia della scienza basata sull’induzione
(v.). In quest’opera, di importanza capitale, è evidenziato che "L’uomo
non sa che studiando i fatti e traendone delle deduzioni, scopre l’origine della
natura. La L. attuale è incapace di arricchire la scienza. Bisogna ben guardarsi
dal trarre troppo rapidamente da fatti particolari delle leggi generali; occorre rigettare
tutte quelle conoscenze acquisite troppo in fretta, e sottometterle ad un nuovo
esame". È proprio la problematica attorno alla metodologia della nuova scienza della natura, accanto alla rinascita della geometria euclidea nel XVI secolo, che porta ad una nuova impostazione del problema della L. stessa. Tale problema verte attorno al rigore logico, che costituisce il fondamento di ogni sapere, compreso quello filosofico (Cartesio). Hobbes formula l’idea della L. come combinazione di simboli e regole convenzionali, modellata sul calcolo matematico. Quest’idea fu sviluppata da Leibniz e, nel XVIII secolo, dai suoi seguaci, nel tentativo di sistemare il complesso delle strutture logico-linguistiche in modo da costituire un linguaggio scientifico universale. Kant, nella Critica della ragion pura, distingue una L- generale, che altro non è che la L. formale di tradizione aristotelica, ed una L. trascendentale, o dottrina delle forme pure a priori del pensiero. L’idealismo, e principalmente Hegel, vedendo nel reale il manifestarsi dello Spirito razionale, identificava L. e metafisica; la deduzione delle categorie del pensiero diventava la deduzione delle categorie della realtà. Questa è la L. concreta che Hegel (ed in seguito Croce) oppone alla L. formale aristotelica. Nella seconda metà del XIX secolo, mentre nell’ambito del positivismo la L. intesa come teoria del pensiero è trattata con metodi naturalistici (Sigwart, Wundt, ecc.), Husserl, riprendendo le teorie logiche di Bolzano, ripropone l’idea della L. formale pura, ovvero della L. come dottrina delle proposizioni in sé indipendenti da fattori psicologici e contenutistici. Gli sviluppi della L. formale pura hanno portato alla creazione della L. matematica.
Logos: Termine greco (logoz) indicante il discorso, l’ordine razionale e la ragione.
Nel suo senso filosofico più rilevante, indica una ragione od intelligenza cosmica che
fornisce ordine ed intelligibilità al mondo. Questa concezione adottata dapprima da
Eraclito (v.), trova poi pieno svolgimento negli stoici, per cui la ragione del mondo è
nello stesso tempo il fato (v.), la provvidenza e la natura. Nel pensiero cristiano il L.
è la seconda persona della santissima Trinità, e si identifica con l’opera di
illuminazione e di redenzione di Cristo. Nel neoplatonismo di Plotino (v.), è
l’aspetto creativo e formatore assegnato all’anima del mondo o nouz, ovvero la ragione.
Lollardi: Termine
derivato dall’inglese lollard, derivazione a sua volta dall’olandese lollaerd,
da lollen, mormorare, pregare a bassa voce. Indica una setta di eretici seguaci di
G. Lollar arso vivo a Colonia nel 1322, e poi di Wycliff. Tale setta si identifica con il
gruppo dei Poor Preachers, società di missionari laici fondata nel 1380 dallo
stesso Wycliff. Dopo la sua morte (1384), i suoi insegnamenti furono variamente
interpretato e modificati, tanto che si giunse ad una dottrina assai più rigida ed ostile
al potere costituito di quanto non lo fosse stata quella originale. I L. sostenevano
l’assoluta autonomia del popolo sia dalla Chiesa che dai sovrani, e criticavano
aspramente la Chiesa romana per la soppressione della transustanziazione (v.), per il
celibato ed il lusso sacerdotale, per la venerazione dei santi e delle immagini, per il
sacramento della confessione, e soprattutto per la vendita delle indulgenze. Furono a
lungo perseguitati dalla monarchia inglese in accordo con il potere ecclesiastico, ma
continuarono a propagandare la propria fede, guadagnando proseliti nell’Inghilterra
meridionale. Ebbero seguaci e sostenitori anche fra la nobiltà, come con John Oldcastle,
che nel 1414 venne arrestato da Enrico V, e che poi, riuscito a fuggire, venne nuovamente
catturato ed infine giustiziato (1417). L’arresto di John Oldcastle provocò una
ribellione dei L. che, usciti così allo scoperto, furono catturati in gran numero a St.
Giles’s Field, e messi a morte nel 1414. La durezza della repressione provocò una
crisi all’interno del movimento, che tuttavia sopravvisse ancora a lungo. Verso il
1450, sotto il regno di Enrico VII, si ebbe una ripresa delle persecuzioni, che spazzò
via quasi completamente la setta. Le idee dei L. si propagarono anche in Boemia, dove
prepararono il terreno alla diffusione della dottrina di Huss (v.).
Lotta
per le Investiture:
Definizione generica del contrasto tra papato ed impero
caratterizzante alcuni decenni della storia medievale, tra la fine dell'XI e
l'inizio del XII secolo. L'origine e le cause risalgono però ben più
addietro, identificandosi sostanzialmente nell'integrazione della Chiesa nel
sistema feudale. L'uso di dare in concessione feudi a vescovi ed abati,
risalente almeno all'epoca degli Ottoni e dovuto soprattutto alla necessità
di limitare lo strapotere dei grandi feudatari laici, provocò una progressiva
ingerenza dell'imperatore nell'investitura dei vescovi. I vescovi,
dipendenti dal loro principe poiché feudatari, venivano da questi prescelti in
base a criteri politici ben più che religiosi o spirituali, causa questa
fondamentale della decadenza morale della Chiesa sul finire del primo millennio
della sua storia. Inoltre la nomina stessa dei vescovi sfuggiva sempre più ad
ogni controllo od approvazione del pontefice, mentre nell'investitura feudale
si venne gradualmente sovrapponendo e confondendo quella spirituale, che avrebbe
dovuto spettare al solo potere religioso. Papa Gregorio VII (1073-1085) fu il
primo pontefice che si oppose energicamente a tale stato di cose, nel tentativo
di avocare alla sola Chiesa il diritto di investitura dei vescovi, sostenendo
anzi la piena superiorità del potere religioso su quello laico: ingaggiò con
Enrico IV un'aspra lotta, dalla quale uscì sconfitto. Il contrasto doveva
proseguire con i successori di Gregorio (Urbano II, Pasquale II e Gelasio II) e
di Enrico IV (Enrico V), finché si giunse nel 1122 all'accordo tra papa
Callisto II e l'imperatore Enrico V, noto sotto il nome di Concordato di Worms.
Tale accordo stabiliva che l'investitura spirituale veniva distinta da quella
temporale, la prima spettando al pontefice, la seconda all'imperatore. Il
Concordato di Worms concluse pertanto la L.
Luce: Radiazione
elettromagnetica emessa dai corpi, che colpisce la retina dell'occhio producendo il
fenomeno della visione. Le prime ipotesi sulla natura della L. risalgono agli antichi
filosofi greci, ma la prima teoria rigorosamente scientifica è dovuta a Newton che, nella
sua Ottica (1704), ne sostenne la natura corpuscolare. Egli affermò che la L. è
costituita da corpuscoli materiali emessi dai corpi, viaggianti secondo traiettorie
rettilinee con velocità dipendente dal mezzo in cui si muovono. Tale teoria doveva
soppiantare quella precedentemente sostenuta da C. Huygens (1690), per cui la L.
consisteva in un moto ondulatorio dell'etere, materia elastica che compenetra lo spazio.
Nel XIX secolo fondamentali esperimenti condotti da A. Fresnel convalidavano la vecchia
natura ondulatoria della L., che poi C. Maxwell dimostrò essere costituita da onde
elettromagnetiche e non da onde elastiche. Sul finire dell'800 gli studi sull'emissione e
sull'assorbimento dell'energia portarono a formulare l'ipotesi quantistica dell'energia
radiante, ed a stabilire che la L. è costituita da quanti o fotoni. Le
radiazioni che formano la L. hanno una lunghezza d'onda compresa tra 400 e 780 nanometri.
Le varie lunghezze d'onda sono percepite dall'occhio come coloro diversi, osservabili sia
nel fenomeno naturale dell'arcobaleno sia scomponendo la L. bianca attraverso un prisma di
vetro. La velocità di propagazione della L. è di circa 300.00 km/sec. Y (Religione) Secondo l'Antico Testamento, dopo la creazione
del cielo e della terra, Dio pensò di creare qualcosa di nuovo che si distinguesse dalle
tenebre dominanti. Fu allora ch'Egli disse: "Fiat Lux", "Sia la
L.", e la L. fu. Dio vide che la L. era cosa buona, e la separò dalle tenebre, e
chiamò la L. giorno e le tenebre notte. (Genesi: 1, 3-5). Y
(Massoneria) Il giuramento, come la Promessa solenne, viene prestato dal
Massone sul Vangelo di San Giovanni, che inizia così: "In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste. In lui era la vita, e la vita era la Luce degli uomini; la Luce splende nelle
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta". Si tratta di un testo che non
può non far riflettere gli Iniziati. Esso divinizza l’Intelligenza che,
mentre sbroglia gradualmente il Caos, si comunica agli esseri umani, dapprima sotto
forma di istinto, poi di coscienza e di comprensione sempre più completa. La vita
universale sembra un immenso lavoro costruttivo che non potrebbe essere eseguito
ciecamente. Se vi è un’organizzazione progressiva, dunque coordinazione, significa
che interviene un discernimento. Ma non tutti i costruttori sono illuminati in ugual
misura. Alcuni obbediscono docilmente a leggi di cui non hanno coscienza, mentre altri
sono giunti ad un livello iniziatico più o meno elevato, nella misura in cui essi hanno
saputo discernere il piano della Grande Opera (v.). Da questo punto di vista per
l’Apprendista è sufficiente essere fermamente deciso ad istruirsi in un’Arte di
cui possiede solo una vaga nozione tecnica. Il Compagno si esercita nella pratica, pur
andando ancora a tentoni, impegnandosi in tentativi spesso infruttuosi. Per evitare
l’empirismo occorre elevarsi alla Maestria, a meno che non si benefici di un vero
Maestro illuminato. Resta da svelare il mistero dell’Illuminazione. Se alcuni
uomini si rivelano più chiaroveggenti di altri, potendo istruire ed utilmente guidare i
propri simili, resta oscura l’origine della loro capacità di attingere una
comprensione superiore, come la sorprendente lucidità di cui danno prova. Un compito
certo agevolato da perseveranti studi, profonde meditazioni ed una lunga esperienza; ma
alla fin fine la loro superiorità si basa sull’affinamento delle loro facoltà
pensanti. Sono diventati più sensibili alle vibrazioni della luce iniziatica, da cui
deriva la loro iniziazione ai misteri mai rivelati agli uomini comuni. La L. che illumina
progressivamente l’iniziato potrebbe essere fatta risalire al Logos di Platone
(v.), al suo Grande Architetto o Demiurgo, ma è saggio fermarsi al Maestro
Hiram. Un’entità questa che è la personificazione del pensiero iniziatico, ovvero
di quell’insieme di idee che sopravvivono anche allorché nessun cervello vibra più
sotto la loro influenza. Quanto è prezioso non muore, sussiste allo stato latente fino al
giorno in cui si offrono possibilità di manifestazione. È allora che Hiram risorge nella
persona di ogni nuovo Maestro Massone. Secondo la Tradizione di cui sono impregnati
i rituali, la L. rappresenta quindi una facoltà latente nell'essere umano, destata e resa
potenzialmente disponibile attraverso l'Iniziazione. Tale facoltà può anche essere
acquisita, sebbene raramente, attraverso l'Intuizione. Si definisce dunque L. quanto di
più elevato vi sia nell'Intelligenza e nella Volontà dell'essere umano. Per Intelligenza
non s'intende tanto la facoltà del ragionamento, quanto la capacità di percezione della
Verità, realizzata con il semplice sguardo influenzato dalla Saggezza. L'illustre Massone
rosacrociano Karl von Eckhartshusen (1752-1803), nel suo volume "La Nuèe sur le
Sanctuaire" sostiene: "Come per un uomo privo di organi la L. non esiste,
anche se altri ne possono godere e gioire, così molti uomini non possono gioire di
qualcosa di cui invece altri possono. Un uomo potrebbe essere organizzato in modo tale da
sentire, intendere, vedere e gustare cose che un altro non potrebbe, perché privo
dell'organo necessario. Ammettendo ciò, se questi cercassero spiegazioni plausibili a
tale fatto, sarebbe assolutamente inutile, in quanto le idee che uno ha ricevuto dal suo
organo particolare cozzerebbero contro quelle dell'altro che non potrà mai afferrarle.
Siccome ognuno riceve le proprie idee dai suoi sensi, e considerato quindi che tutte le
operazioni della ragione non sono che forme di astrazione di impressioni sensibili, ne
consegue che è veramente impossibile crearsi delle idee su molte cose fin quando non
avremo ricevuto delle sensazioni su tali cose. Questo perché ogni nostro organo è o
diventa sensibile soltanto per noi stessi, e non per altri". Y
(G.O.I.) Chiamiamo con questo stesso nome
quell'aspetto che caratterizza il verificarsi di fenomeni esteriori, come anche quello di
eventi interiori. Certamente non si tratta della stessa L. Dovrebbe sempre stupire il
fatto che si sia quasi unanimemente concordi nel dare il nome di L. o di tenebre ad
aspetti di fenomeni interiori, aspetti che però non sono misurabili come quelli
esteriori. Una tale indefinibile concordanza universale ripropone ancora una volta, sotto
un differente punto di vista, l'esistenza di una oggettività interiore, che dovrebbe far
riflettere profondamente sulla superficialità di molte affermazioni dogmatiche, che
restringono la realtà oggettiva solo a quanto può essere misurato. Il fatto che la L.
possa essere oggetto di valutazioni individuali, per esempio in relazione alle tenebre,
può costituire una base per riaffermare l'importanza della centralità dell'uomo nella
valutazione dei fenomeni che riguardano l'esistenza. Ferma restando la fallibilità dei
giudizi troppo personali, è possibile proporre una via di conquista di superiori forme di
imparziali giudizi, ottenibili attraverso un duro lavoro di disciplina interiore.
Luci: Termine che in
Massoneria indica i tre primi Dignitari cui è affidato il governo di ogni Loggia, ovvero
il Maestro Venerabile (v.), il Primo Sorvegliante (v.) ed il Secondo Sorvegliante (v.).
Quando essi si riuniscono per l’adozione di decisioni formano il Consiglio delle L.
(v.), mentre una loro riunione, convocata per adottare provvedimenti disciplinari nei
confronti di Fratelli ritenuti colpevoli di colpa massonica, viene chiamato Consiglio di
Disciplina (v.). Attributi delle tre L. della Loggia sono rispettivamente la Saggezza
(Minerva), la Bellezza (Venere) e la Forza (Ercole).
Luna: Unico satellite
naturale della Terra, intorno alla quale compie un moto di rivoluzione della durata di 27
giorni, 7 ore, 43 minuti ed 11,5 secondi (mese siderale), compiendo unitamente alla Terra
stessa una rivoluzione attorno al Sole della durata di 365,25 giorni. La distanza che la
separa dal nostro pianeta è mediamente di 384.400 km., il suo diametro è di circa 3470
km. ed il suo volume è 1/49 di quello terrestre. Ruota intorno al proprio asse alla
velocità esatta di un mese siderale, per cui rivolge alla Terra sempre lo stesso
emisfero. Durante il mese sinodico varia naturalmente la sua posizione rispetto alla Terra
ed al Sole, e quindi l’illuminazione riflessa visibile (fasi lunari). A partire dal
1969 è stata avviata l’esplorazione diretta del suolo lunare, sviluppata dagli Stati
Uniti nell’ambito del programma Apollo, culminato con lo sbarco di uomini sulla L. I
suoi campioni rocciosi sono di natura basaltica, e vi sono stati rilevati solo tre nuovi
minerali. Y (Massoneria) Il simbolo della L. è presente
nel Tempio massonico sia all’Oriente, alla sinistra del Maestro Venerabile, sia nel
quadro di Loggia (v.). Simboleggia l’immaginazione, che riveste le idee di una forma
appropriata. Rappresenta inoltre la comprensione e la femminilità passiva. I Lavori di
Loggia si chiudono a Mezzanotte, quando la L. è al Nadir, momento in cui si suppone che
irradi il suo massimo splendore, che si propaga ad illuminare lo spirito del Libero
Muratore, istigandone la spiritualità e la volontà di ricerca. La L. corrisponde
all’elemento Acqua.
Lupetto:
Termine che definisce il figlio di un Massone, che si accinge
all'Iniziazione seguendo le orme del genitore. Durante la cerimonia non porta
una benda sugli occhi, ma indossa solo un velo trasparente che gli copre il
capo, in quanto si presume che conosca già qualcosa della Libera Muratoria.
Probabilmente tale denominazione risale ai Misteri di Iside (v.), dove tale nome
designava i figli degli iniziati.
Lustrazione: Derivazione
dal latino lustratio, da lustrare, lavare, purificare, analogo al greco louw, lavare. Cerimonia di purificazione celebrata dagli antichi
Romani prima dei riti religiosi, e prima e dopo taluni atti della vita pubblica e privata.
Si purificavano persone, animali e cose. Ogni cinque anni il censore uscente celebrava una
cerimonia di purificazione generale, chiamata lustratio populi o lustrum.
Altri riti di L. venivano celebrati durante i Suovetaurilia, quando gli animali
(porco, pecora o toro), prima del sacrificio, venivano fatti girare tre volte intorno al
popolo radunato extra moenia nel Campo Marzio. Anche gli Ambarvalia, antica
festività romana volta a purificare i campi, prevedeva riti di L.
Luteranesimo: Termine
tradotto dal tedesco Luthertum, impiegato per indicare complessivamente la dottrina
religiosa elaborata dal riformista Martin Lutero (v.), la teologia sviluppata dai suoi
successori e l'insieme delle Chiese evangeliche derivate dalla Riforma luterana. Dopo la
morte di Lutero il L., ottenuto il riconoscimento da parte di Carlo V (Dieta di Augusta
del 1555), sulla base del principio del cuius regio eius religio, per cui i sudditi
dovevano aderire alla religione del sovrano, si diffuse in quasi tutti gli stati germanici
e nei Paesi scandinavi: in Danimarca (1536), in Norvegia (1547) ed in Svezia (1527-40).
Successivamente l'espansione del L. fu contrastata dalla penetrazione del calvinismo (v.)
nei paesi bassi e nelle Fiandre, del calvinismo e di altre correnti riformate in Ungheria,
Polonia, Boemia e Moravia, e dalla controriforma (v.). Nella seconda metà del XVII secolo
esso si trovò limitato alla Germania orientale e settentrionale, ed ai paesi scandinavi.
Dottrinalmente, dopo la morte di Martin Lutero, le polemiche circa il valore delle opere
per la salvezza e la schiavitù dell'arbitrio umano tra melantoniani ed i seguaci rigidi,
e la cosiddetta disputa osiandrina sull'essenza della giustificazione, diedero
luogo a parecchie scissioni, cui si cercò di rimediare con le formule di concordia,
culminanti nel Libro di concordia (1581). In epoca moderna, contro la rigida
ortodossia, tendenze riformiste sono state rappresentate dal pietismo (XVII secolo) e dal
protestantesimo liberale nei secoli XVIII e XIX (Ritschl e Harnack). Nel mondo d'oggi i
luterani sono circa 70 milioni, diffusi in Germania, Scandinavia e Stati Uniti,
intercollegati nella Federazione luterana mondiale.
Lutero Martino: Dal
nome tedesco di Martin Luther, teologo e riformatore (1483-1546), fondatore del
Luteranesimo (v.). Sacerdote dell’Ordine degli Agostiniani eremitani ed osservanti,
secondo la tradizione nel 1517 affisse alla porta della cattedrale di Colonia le sue
famose 95 tesi, proponendovi la pubblica discussione sulla campagna di indulgenze
predicata dal domenicano J. Tetzel per la costruzione di san Pietro. Egli respingeva il
valore delle indulgenze ottenute per denaro ed applicabili anche alle anime del
Purgatorio, riprendendo il concetto di penitenza come metanoia (v.) e, pur cercando
di scindere la responsabilità dei predicatori da quella del pontefice, sottintendevano
severe critiche alla Chiesa. Minacciato di scomunica con la bolla Exsurge domine (1520)
M., forte della diffusa ostilità popolare nei confronti del papato, dell'appoggio armato
dei potenti cavalieri tedeschi e della protezione dell'Elettore, rispose dando
pubblicamente alle fiamme sia la bolla che i testi del diritto canonico (1520), dopo aver
pubblicato dall'agosto all'ottobre precedenti tre trattati programmatici della sua
Riforma. Punti fondamentali dei primi due sono la dottrina del sacerdozio universale dei
credenti, la negazione del monopolio pontificio nell'interpretazione delle sacre
scritture, l'interpretazione dipendente unicamente dalla fede e nella convocazione del
concilio, l'attacco contro la tirannide papale, che trae la sua sola ragione d'essere
dall'amministrazione dei sacramenti. Questi, ridotti a tre, Battesimo, Penitenza ed
eucarestia, non sono oggettivi segni efficaci di grazia, ma traggono la loro validità
unicamente dalla fede di chi li riceve. Infine M. nega la dottrina della Messa come
sacrificio. Fu infine condannato definitivamente per eresia nel 1521, con la bolla Decet
Romanum Pontificem. Nel 1525 contrasse matrimonio con l'ex suora Katharina von Bora,
che gli diede sei figli. Organizzò poi la Chiesa nazionale tedesca posta, in contrasto
con l'idea iniziale del sacerdozio universale, sotto la tutela dei principi territoriali.
Infine dedicò i suoi ultimi anni di vita alla predicazione ed all'insegnamento (v. Martin
Lutero).
Lutto Massonico: Tra i vari rituali riconosciuti dal Grande Oriente d’Italia, il Rituale per
i Funerali Massonici (v.) viene adottato per celebrare il L. nel Tempio parato in nero.
Luxor: Nome derivato dall’arabo el-Uqsur, città dell’Alto Egitto posta
sulla riva destra del Nilo. Situata a breve distanza da Karnak (v.), nella zona
dell’antica Tebe, nell’Egitto faraonico L. costituiva la sede dell’harem
del dio Amon. Una volta l’anno la statua del dio lasciava la sua residenza di Karnak
per fare visita a L., dove assumeva le forme del dio Min. A L. sorgeva un tempio del Medio
Regno, che il faraone Amenophis III (XVIII Dinastia, 1578-1318 a.C.) ricostruì in
granito, ampliandolo ed abbellendolo. Fu lui a disporre la decorazione delle pareti
interne delle grandi sale ipostile, dal tetto sorretto da una selva di colonne lotiformi.
Sul prolungamento dell’harem Ramses II fece edificare un cortile circondato da un
colonnato. Fra le colonne era posta una serie di grandi statue, ed il primo pilone era
preceduto da due obelischi di granito, uno dei quali, donato alla Francia nel 1836, si
trova attualmente a Parigi al centro della Place de la Concorde. Nella corte del tempio
sorge la piccola moschea di Abu’l-Haggag.
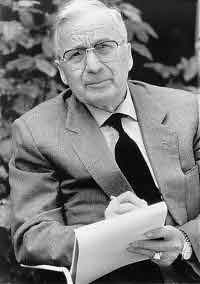 Loggia P2: Nel Grande
Oriente d'Italia è sempre esistita, fin dai tempi di Garibaldi (1877), una Loggia
composta di persone importanti che preferivano non rendere ufficiale la loro appartenenza
all'Istituzione, soprattutto per evitare il problema dei postulanti, ovvero le
inevitabili richieste di favori e raccomandazioni. Per tale motivo quella Loggia era stata
definita "Loggia coperta". In passato avevano fatto parte di questa
Loggia personaggi come Saffi, Carducci, Crispi, Bertani, Bovio, Regnoli ed Orlando. Resta
il fatto che la P2 non può essere definita vera Loggia massonica. Infatti, fin dalla sua
fondazione, era considerata un ricettacolo che potesse mantenere attivi e vincolati
all’Ordine uomini che, per la loro posizione sociale, non avrebbero potuto essere
membri di Logge ordinarie e soprattutto frequentarne i Lavori. Inoltre alcuni suoi membri
si reputavano troppo importanti per dover ripetere i gesti teatrali della
ritualità muratoria. Una premessa massonicamente aberrante. La Loggia infatti è il punto
d’incontro dei Liberi Muratori, che si riuniscono per la celebrazione dei riti
massonici, per la loro formazione culturale e spirituale, per l’approfondimento dei
rapporti fraterni ed il sostegno ad iniziative umanitarie. La P2 invece non si riuniva
mai. I suoi affiliati erano personalità del mondo politico, militare, finanziario ed
accademico, per le quali la superloggia era una sorta di salvacondotto che esonerava dalla
frequentazione dei Lavori massonici di una Loggia normale. A partire dal 1960 tale Loggia
("Propaganda 2", più nota come "P2"), subì una degenerazione di tipo essenzialmente affaristico, che coinvolse una minoranza dei suoi molti componenti. Era allora presieduta da un massone aretino, Licio Gelli, un Maestro Venerabile che si era conquistata la fiducia del Gran Maestro in carica Giordano Gamberini grazie alla sua grande efficienza organizzativa ed al suo dichiarato disinteresse verso promozioni all’interno dell’Ordine. Mentre la P2 si sviluppava incontrollatamente, superando il migliaio di affiliati, per lo più interessati ad inerpicarsi lungo i sentieri d’una ambiziosa scalata politica ed economica, inaccettabile sia per la Massoneria che per la società civile e democratica. Il Gelli sarebbe stato presto sistematicamente al centro delle attenzioni di tutti i mezzi di
Loggia P2: Nel Grande
Oriente d'Italia è sempre esistita, fin dai tempi di Garibaldi (1877), una Loggia
composta di persone importanti che preferivano non rendere ufficiale la loro appartenenza
all'Istituzione, soprattutto per evitare il problema dei postulanti, ovvero le
inevitabili richieste di favori e raccomandazioni. Per tale motivo quella Loggia era stata
definita "Loggia coperta". In passato avevano fatto parte di questa
Loggia personaggi come Saffi, Carducci, Crispi, Bertani, Bovio, Regnoli ed Orlando. Resta
il fatto che la P2 non può essere definita vera Loggia massonica. Infatti, fin dalla sua
fondazione, era considerata un ricettacolo che potesse mantenere attivi e vincolati
all’Ordine uomini che, per la loro posizione sociale, non avrebbero potuto essere
membri di Logge ordinarie e soprattutto frequentarne i Lavori. Inoltre alcuni suoi membri
si reputavano troppo importanti per dover ripetere i gesti teatrali della
ritualità muratoria. Una premessa massonicamente aberrante. La Loggia infatti è il punto
d’incontro dei Liberi Muratori, che si riuniscono per la celebrazione dei riti
massonici, per la loro formazione culturale e spirituale, per l’approfondimento dei
rapporti fraterni ed il sostegno ad iniziative umanitarie. La P2 invece non si riuniva
mai. I suoi affiliati erano personalità del mondo politico, militare, finanziario ed
accademico, per le quali la superloggia era una sorta di salvacondotto che esonerava dalla
frequentazione dei Lavori massonici di una Loggia normale. A partire dal 1960 tale Loggia
("Propaganda 2", più nota come "P2"), subì una degenerazione di tipo essenzialmente affaristico, che coinvolse una minoranza dei suoi molti componenti. Era allora presieduta da un massone aretino, Licio Gelli, un Maestro Venerabile che si era conquistata la fiducia del Gran Maestro in carica Giordano Gamberini grazie alla sua grande efficienza organizzativa ed al suo dichiarato disinteresse verso promozioni all’interno dell’Ordine. Mentre la P2 si sviluppava incontrollatamente, superando il migliaio di affiliati, per lo più interessati ad inerpicarsi lungo i sentieri d’una ambiziosa scalata politica ed economica, inaccettabile sia per la Massoneria che per la società civile e democratica. Il Gelli sarebbe stato presto sistematicamente al centro delle attenzioni di tutti i mezzi di  informazione, per oscure
grosse operazioni finanziarie, scandali d’ogni genere e propositi di interferenze
politiche (s’era addirittura parlato di golpe). Nella primavera del 1981 ne nacque
comunque un clamoroso scandalo che, a causa della notorietà dei personaggi coinvolti,
assunse grandi dimensioni, scatenando una campagna di stampa di straordinaria virulenza
diretta contro l’intera Istituzione Massonica. Dalle accuse di malversazione si
passò a quelle di golpismo, per cui quasi tutte le Case massoniche vennero
perquisite, le documentazioni e gli elenchi degli associati regolari sequestrati.
L'infondatezza di queste accuse fu riconosciuta dalla Corte di Assise di Roma che, il 16
aprile 1994, assolse Licio Gelli dall'accusa di cospirazione politica. Il caso si era
sgonfiato, ma non senza lasciare profonde cicatrici nelle Logge del Grande Oriente
d'Italia che, in seguito all'esperienza negativa, ha poi definitivamente assunto una
configurazione che inibisce in assoluto le Logge coperte. Il massone Lupi ha così
liquidato la pseudo fratellanza piduistica: "Dal ripristino integrale del costume
muratorio dovrà derivare la gioia del recupero della vera fraternità. Questa non è più
tale quando le è giocoforza imbattersi nella mortificante discriminazione, nella chiusura
di gruppo, la quale, insondabile e cristallina entro i delicati confini della docetica e
della maestranza, non è ammissibile nelle manifestazioni e nelle attività esterne,
quando a proprio libito coopta, oppure emargina ed isola. La fraternità, nella sfera
sottile, ha i suoi irrepetibili e incomunicabili afflati; ma sul piano delle attività
esteriori, organizzative o di governo, è in ultima istanza un fatto corale, e pertanto
non può prescindere da un costume di mutuo incontro: non si ama il fratello se non lo si
conosce, e nulla si edifica se lo si ignora". V. anche la voce P2.
informazione, per oscure
grosse operazioni finanziarie, scandali d’ogni genere e propositi di interferenze
politiche (s’era addirittura parlato di golpe). Nella primavera del 1981 ne nacque
comunque un clamoroso scandalo che, a causa della notorietà dei personaggi coinvolti,
assunse grandi dimensioni, scatenando una campagna di stampa di straordinaria virulenza
diretta contro l’intera Istituzione Massonica. Dalle accuse di malversazione si
passò a quelle di golpismo, per cui quasi tutte le Case massoniche vennero
perquisite, le documentazioni e gli elenchi degli associati regolari sequestrati.
L'infondatezza di queste accuse fu riconosciuta dalla Corte di Assise di Roma che, il 16
aprile 1994, assolse Licio Gelli dall'accusa di cospirazione politica. Il caso si era
sgonfiato, ma non senza lasciare profonde cicatrici nelle Logge del Grande Oriente
d'Italia che, in seguito all'esperienza negativa, ha poi definitivamente assunto una
configurazione che inibisce in assoluto le Logge coperte. Il massone Lupi ha così
liquidato la pseudo fratellanza piduistica: "Dal ripristino integrale del costume
muratorio dovrà derivare la gioia del recupero della vera fraternità. Questa non è più
tale quando le è giocoforza imbattersi nella mortificante discriminazione, nella chiusura
di gruppo, la quale, insondabile e cristallina entro i delicati confini della docetica e
della maestranza, non è ammissibile nelle manifestazioni e nelle attività esterne,
quando a proprio libito coopta, oppure emargina ed isola. La fraternità, nella sfera
sottile, ha i suoi irrepetibili e incomunicabili afflati; ma sul piano delle attività
esteriori, organizzative o di governo, è in ultima istanza un fatto corale, e pertanto
non può prescindere da un costume di mutuo incontro: non si ama il fratello se non lo si
conosce, e nulla si edifica se lo si ignora". V. anche la voce P2.