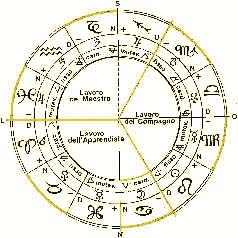L.I.D.U.: Abbreviazione della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo,
un’associazione che si richiama alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nel cui
preambolo recita: "L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la
presente Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e
di queste libertà, e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed
internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione".
Labaro: Sinonimo di
insegna, gagliardetto, era molto usato dagli antichi come stendardo. Di forma quadrata o
rettangolare, viene appeso con anelli o strisce ad un supporto orizzontale, in genere
fissato a sua volta ad un’asta, così da restare sempre disteso. La Massoneria ha
adottato il L. per le sue insegne istituzionali, dal Grande Oriente ai Collegi alle
singole Logge. L’Obbedienza italiana ha adottato per le Logge la forma rettangolare,
con il L. appeso al lato più corto e mantenuto disteso, avente come fondo un tessuto
normalmente di colore verde, in genere bordato di rosso, sul quale sono ricamate in oro la
dedica A.G.D.G.A.D.U., l’emblema ed il nome distintivo, ed il numero della Loggia,
nonché l’Oriente in cui opera. Nel Tempio Massonico il L. di Loggia viene esposto
nel corso delle Tornate rituali nell’angolo Nord-Ovest del Tempio, ovvero opposto
allo stendardo (v.) nazionale, secondo quanto disposto dall’Art. 17 della
Costituzione dell’Ordine.
 Labirinto:
Termine greco, laburindoz, che
definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,
su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti
culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea
consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.
Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,
cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il
Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il
modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato
il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e
delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi
ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per
la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è
presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze
neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma
meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,
dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.
quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della
Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è
tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione
pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente
usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al
riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato
nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,
esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli
undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata
equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità
ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della
fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano
come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato
fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),
in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel
corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La
simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una
fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul
significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato
risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è
il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno
riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei
morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie
rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,
nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di
destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".
Labirinto:
Termine greco, laburindoz, che
definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,
su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti
culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea
consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.
Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,
cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il
Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il
modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato
il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e
delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi
ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per
la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è
presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze
neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma
meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,
dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.
quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della
Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è
tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione
pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente
usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al
riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato
nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,
esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli
undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata
equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità
ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della
fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano
come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato
fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),
in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel
corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La
simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una
fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul
significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato
risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è
il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno
riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei
morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie
rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,
nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di
destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".
Lacrime d'Argento: Generalmente le lacrime sono simbolo del dolore, talvolta anche della meditazione
e dell’intercessione. Alcune tribù dell’Amazzonia consideravano come gocce
d’acqua le lacrime versate dai bambini condotti al sacrificio per impetrare dalle
divinità la pioggia. La Massoneria impiega le L. nei paramenti neri fissati alle pareti e
sugli scranni dei Dignitari, come anche nel Quadro di Loggia (v.) in Grado di Maestro
Massone (v.). Esse sono qui simbolo dei raggi di Luna che illuminano con discrezione le
tenebre della notte, e sono quindi simbolo del silenzio e della meditazione.
Laicismo: Termine con
il quale viene convenzionalmente definito l’insieme delle dottrine politiche che
sostengono il principio della separazione totale della Chiesa dallo Stato laico, come
conseguenza dell’indifferenza ideologica dello Stato stesso. Il L. quindi è una
componente fondamentale del liberalismo, e le sue origini si identificano con quelle del
pensiero liberale, nel periodo delle grandi lotte religiose del XVIII secolo. Risulta non
appropriato il richiamo a suggestivi ma ingannevoli precedenti, come il separatismo
teorizzato da Dante nel suo De Monarchia. Il principio della separazione fra Stato
e Chiesa, derivato da quello della libertà di coscienza, in effetti venne sancito dalla
Rivoluzione francese, e soltanto dopo il fallimento della costituzione civile del clero
del 1791, anche se principi analoghi erano già stati inseriti nella Costituzione degli
Stati Uniti d’America. Travolte dalla restaurazione, gli ideali laicisti lentamente
ricomparvero nella legislazione ecclesiastica degli stati europei, dopo le rivoluzioni del
1831 e del 1848. Trovarono un solido fondamento teoretico nella filosofia del positivismo
(v.), e furono compiutamente adottate dalla costituzione della terza repubblica francese
(1870) e. in Italia, dalla legge delle guarentigie (1871), votata dopo la presa di Roma e
la fine del potere temporale del papato. Dopo l’unità d’Italia il L. fu
patrimonio del pensiero liberale, e fu sempre duramente combattuto dalla Chiesa, come
evidenziato dalle encicliche Quanta cura di Pio IX e Quas primas di Pio XI.
Infine il Concilio Vaticano II, nella costituzione Gaudium et Spes, ha finito con
il formulare taluni principi in tema di rapporti con lo stato che, senza identificarsi con
quelli laicisti, vi sono tuttavia decisamente vicini.
Laico: Dal greco laicoz, popolare o profano, derivato a sua volta da laoz, popolo, indica non tanto l’appartenenza quale membro
quanto la condizione di sudditanza. Nell’ambito della dottrina cristiana e del
diritto canonico, il termine indica il comune fedele che, in forza del battesimo ricevuto,
appartiene alla Chiesa ed è partecipe della sua vita, pur senza far parte della gerarchia
ecclesiastica (contrapposto quindi a chierico), ma cui fanno comunque capo comuni diritti
e doveri. L’espressione è assente nel Nuovo Testamento, e compare per la prima volta
nell’uso cristiano nel 96 d.C., con Clemente Romano, per qualificare il semplice
fedele, a differenza del diacono e del presbitero. La funzione ecclesiale e
d’apostolato del L. nella Chiesa, che è stata al centro di accesi dibattiti
teologici ed ecclesiologici, si è venuta estendendo attraverso una forma di delega di
alcune funzioni ad essa proprie (Azione cattolica ed istituti religiosi), sia in seguito
alla riscoperta di una serie di valori religiosi originali concernenti i L. in quanto
tali, e nelle loro più specifiche attività professionali e sociali. Frate, fratello o
sorella L. o converso, è il religioso non investito degli ordini sacri che si dedica al
servizio di una comunità religiosa, aiutando i sacerdoti nei compiti materiali ed
attendendo ai servizi manuali e profani. L’aggettivo L., contrapposto ad
ecclesiastico, religioso, confessionale, si riferisce a quanto è estraneo all’ambito
di pertinenza diretta od indiretta della chiesa (beneficio L., pensione L., prebenda L.) o
che si ispira a concezioni di autonomia rispetto all’autorità ecclesiastica
(assistenza L., scuola L. e Stato L.).. Può anche essere attribuito ad un atteggiamento
ostile o polemico, a seconda del modo in cui si verifica la constatazione o
l’affermazione di indipendenza o di autonomia. Come voce arcaica L. assumeva anche il
significato di ignorante, incolto, ignorante, in contrapposizione a chierico nel senso di
dotto.
 Lalibelà: Nome di villaggio dell’Etiopia settentrionale, chiamato anche Lalibala, nel
Lasta. È noto per le sue dieci chiese in roccia risalenti, secondo la tradizione, al XII
secolo. Sono tutte ricavate nel tufo tenero, ed hanno pianta rettangolare, evidenziando
affinità architettoniche con i templi monolitici dell’India (v. Ajanta). La maggiore
del gruppo è la chiesa di Madhanye ‘Alem, a cinque navate, quelle di Maryam e di
Golgota presentano interessanti sculture. In particolare quest’ultima comprende la
cripta di Sellasyè, con rilievi sulle pareti e sul tabernacolo in pietra, con figure di
santi dei quattro evangelisti. Le "croix patteé" scolpite in quasi tutte
queste chiese ha scatenato la fantasia di vari scrittori, che vi hanno visto
l’intervento dei Cavalieri Templari nella loro realizzazione.
Lalibelà: Nome di villaggio dell’Etiopia settentrionale, chiamato anche Lalibala, nel
Lasta. È noto per le sue dieci chiese in roccia risalenti, secondo la tradizione, al XII
secolo. Sono tutte ricavate nel tufo tenero, ed hanno pianta rettangolare, evidenziando
affinità architettoniche con i templi monolitici dell’India (v. Ajanta). La maggiore
del gruppo è la chiesa di Madhanye ‘Alem, a cinque navate, quelle di Maryam e di
Golgota presentano interessanti sculture. In particolare quest’ultima comprende la
cripta di Sellasyè, con rilievi sulle pareti e sul tabernacolo in pietra, con figure di
santi dei quattro evangelisti. Le "croix patteé" scolpite in quasi tutte
queste chiese ha scatenato la fantasia di vari scrittori, che vi hanno visto
l’intervento dei Cavalieri Templari nella loro realizzazione.
Lama: Dal tibetano bLama, venerabile, corrispondente al sanscrito guru, titolo
d'onore spettante ai monaci dei grandi monasteri buddhisti-lamaisti (v. Lamaismo) del
Tibet e della Mongolia. I L. venivano consacrati dopo un lungo periodo di iniziazione, e
sottoposti a 250 diverse regole disciplinari.
Lamaismo: Derivazione di lama (v.). Religione basata sulle credenze e sulle
istituzioni del Tibet, derivate dal buddhismo mahayana. Introdotto dal Nepal nel
632 d.C., ad opera del re Sron-brtsan-sgam-po, e sovrapposto all'originaria religione
sciamanistica Bon, il buddhismo mahayana venne permeato di elementi tantrici nel 747 per
iniziativa del filosofo indù Padmasambhava, e riformata più tardi dal
"mago" bengalese Atisa (982-1054), dal monaco Rinc'en-bza-po
(958-1055) e nel XIV secolo da Tson-k'a-pa (1357-1419), fondatore della setta dGelugs-pa.
Nel XIV secolo questa setta, affermando la reincarnazione di alcuni Bodhisattva in
corpi-fantasma (sprul-sku), fissò le basi per una monarchia sacerdotale, quella
lamaistica, che ha governato il Tibet fino a pochi decenni fa. I Lama tibetani furono
anche protagonisti della conversione dei Mongoli, e attraverso la dinastia mongola Yüan
(1280-1378), il L. si affermò anche in Cina, dove verrà seguito fin sotto la dinastia manciù
dei Ching (1644-1911). Nel L. l'orientamento filosofico del buddhismo originario è stato
profondamente modificato da contaminazioni della religione Bon (esorcismo, magia,
strapotere sacerdotale) e del mantra (ritualismo, culto di divinità minori, di
religiosi e di incarnazioni viventi del Buddha o lama incarnati). L'organizzazione della
gerarchia lamaista, sotto molti aspetti simile a quella cattolica, si concretizza nelle
figure del Dalai-lama (v.), con poteri politici e sede a Lhasa fino
all'occupazione cinese del Tibet, e del Tashi-lama, con poteri essenzialmente
religiosi e sede a Tashi-lhum-po, considerati la doppia incarnazione del Bodhisattva
tibetano Chenresik. Il Dalai-lama era assistito dai k'am-po
(consiglieri) e dai lama dei monasteri più importanti. L'autorità politica del L. è
stata tuttavia vanificata nel 1959 con l'occupazione militare del Tibet da parte della
Cina comunista. Il Dalai Lama stesso ha dovuto trasferirsi dal Tibet nei vicini
Laddakh, Sikkim, Bhutan, Nepal ed India limitrofa. Il L. sopravvive oggi nel Tibet, e
presso comunità tibetane esuli in territorio indiano. Il Pantheon del L. comprende cinque
dhyani-buddha con cinque bodhisattva, seguiti da mille Buddha incarnati
prima e dopo Sakyamuni, e comprende anche molti demoni. I testi sacri del L.,
codificati agli inizi del XIV secolo, sono il bKa'-agyur (parola tradotta, in 108
libri), che comprende la traduzione dei sutra (v.), ed il bsTan-agyur
(dottrina tradotta, in 225 libri), collezione di commenti al bKa'-agyur e testi
originari dottrinali e filosofici. I riti del L. comprendono una miriade di oggetti
cultuali, come campane, amuleti, rosari, dorje (fulmini, cioè armi per combattere
i demoni), e soprattutto il k'or-lo (mulino rotante o da preghiera).
Lamentazioni: Uno
degli Agiografi della Bibbia (v.), quarto dei cinque rotoli, che nella Vulgata è
posto dopo Geremia. È una raccolta di cinque canti (qinah, elegia) che evocano la
caduta di Gerusalemme sotto l’assedio di Nabucodonosor (587 a.C.). I primi quattro
sono in forma di acrostico alfabetico, mentre il quinto, più popolare, è una preghiera
collettiva che invoca la misericordia divina. I canti, pur apparendo composti
nell’immediatezza della catastrofe, non sembrano essere opera di Geremia, a cui la
tradizione li attribuisce, né di un solo poeta. Le L. fanno parte della liturgia
cattolica della settimana santa, già variamente musicate in epoca gregoriana; divennero
un testo molto sfruttato dai polifonisti del XVI e del XVII secolo. In particolare ne
composero Archadelt. Palestrina, Morales, Victoria ed Allegri.
Lampada di Salomone: v. Menorah.
 Lancia di Longino: La Heilige Lance (Lancia sacra) che, secondo la leggenda, era stata usata
dal pretoriano Longino per trafiggere il costato di Cristo crocifisso, era custodita da un
secolo in una bacheca ricoperta da una teca di cristallo, nella Weltliche Schatzkammer
(la stanza dei tesori mondiali) del palazzo dell'Hofburg, a Vienna, tra i cimeli
del Sacro Romano Impero appartenuti agli Asburgo. Nel marzo 1938, subito dopo l’Anschluss
con cui Hitler aveva forzatamente annesso l'Austria alla Germania nazista, la Heilige
Lance fu trasferita a Norimberga, e collocata nella chiesa di Santa Caterina, il luogo in
cui il grande musicista Richard Wagner (adepto come il fuehrer nazista di società
iniziatiche) aveva ambientato uno dei brani più suggestivi dei Maestri Cantori. Hitler
era un fanatico cultore di cose magiche, ed era intimamente convinto che esistessero
oggetti dotati di immensi poteri, il cui possesso o la cui conoscenza avrebbe permesso
alla Germania di diventare la dominatrice del mondo. Tra questi oggetti c'era anche la
Lancia di Longino, l'arma che, nelle narrazioni dedicate a Re Artù e al Graal, aveva
inferto al Re Pescatore il colpo doloroso, gettando l’Inghilterra nella
desolazione. Ma la lancia non portò fortuna al fanatico dittatore. Dopo la sconfitta di
Stalingrado, Hitler ordinò che essa fosse trasferita in un nascondiglio segreto a prova
di bomba. Fu scelta una galleria sotto l'antica fortezza di Norimberga, attrezzata come
una camera blindata. Il 13 ottobre 1944 l'aviazione alleata sferrò un attacco definitivo
sulla Germania; la Oberan Schmied Gasse (Vicolo superiore dei fabbri), in cui era
celata l'entrata al tunnel con la camera blindata, venne completamente distrutta. Qualcuno
notò delle strane aperture che conducevano al sottosuolo, e presto si diffuse la voce che
nel terreno sottostante si trovasse un misterioso bunker corazzato. Il 20 aprile 1945 gli
alleati occuparono Norimberga. Il suo borgomastro, Willy Lebel, che conosceva il
nascondiglio della lancia, si suicidò, e qualcuno perquisì il suo appartamento per
assicurarsi che non vi fossero elementi atti a condurre gli americani al bunker nascosto.
Ma gli uomini dell'American Intelligence non rinunciarono alla ricerca: infatti,
qualche mese prima, il Premier britannico Winston Churchill aveva parlato dell'importante necessità
strategica di recuperare l'arma. Alle 14 e10 del 30 Aprile 1945, lo stesso giorno in
cui Hitler si suicidava a Berlino, la Heilige Lance venne recuperata dagli americani. Il
Generale Patton ammise successivamente che, per qualche istante, fu tentato di tenerla:
anche lui, infatti, era un conoscitore di cose occulte, ed era al corrente dei suoi
presunti poteri. Poi prevalse il buon senso: la Heilige Lance fu restituita all'Austria,
ed è ancora possibile ammirarla nel posto dov’era precedentemente: nella Weltliche
Schatzkammer dell'Hofburg di Vienna. Nel saggio Adolf Hitler and the Secrets
of the Holy Lance (Adolfo Hitler ed i segreti della Lancia Sacra), pubblicato a
tiratura limitatissima da una piccola casa editrice di Stelle, Illinois, (U.S.A.), il
Colonnello Howard A. Buechner ed il Capitano Wilhelm Bernhardt asseriscono che Himmler,
braccio destro del führer nazista, fece realizzare segretamente da un artigiano
giapponese un perfetto duplicato della Lancia sacra. Nel 1945 la falsa Heilige
Lance fu spedita a Norimberga, ove subì le vicissitudini riportate, mentre quella vera fu
trasportata da un sottomarino (l’U Boat 530), in un nascondiglio segretissimo
tra le montagne del ghiacciaio Muhlig Hiffman, nell’Antartide. La lancia
sarebbe stata recuperata da una misteriosa (ed organizzatissima) setta denominata Ordine
dei Cavalieri della Lancia Sacra, ed ora riposerebbe in un nuovo nascondiglio,
sorvegliata dai cavalieri, il cui obiettivo pare sia il mantenimento della giustizia e
della pace nel mondo.
Lancia di Longino: La Heilige Lance (Lancia sacra) che, secondo la leggenda, era stata usata
dal pretoriano Longino per trafiggere il costato di Cristo crocifisso, era custodita da un
secolo in una bacheca ricoperta da una teca di cristallo, nella Weltliche Schatzkammer
(la stanza dei tesori mondiali) del palazzo dell'Hofburg, a Vienna, tra i cimeli
del Sacro Romano Impero appartenuti agli Asburgo. Nel marzo 1938, subito dopo l’Anschluss
con cui Hitler aveva forzatamente annesso l'Austria alla Germania nazista, la Heilige
Lance fu trasferita a Norimberga, e collocata nella chiesa di Santa Caterina, il luogo in
cui il grande musicista Richard Wagner (adepto come il fuehrer nazista di società
iniziatiche) aveva ambientato uno dei brani più suggestivi dei Maestri Cantori. Hitler
era un fanatico cultore di cose magiche, ed era intimamente convinto che esistessero
oggetti dotati di immensi poteri, il cui possesso o la cui conoscenza avrebbe permesso
alla Germania di diventare la dominatrice del mondo. Tra questi oggetti c'era anche la
Lancia di Longino, l'arma che, nelle narrazioni dedicate a Re Artù e al Graal, aveva
inferto al Re Pescatore il colpo doloroso, gettando l’Inghilterra nella
desolazione. Ma la lancia non portò fortuna al fanatico dittatore. Dopo la sconfitta di
Stalingrado, Hitler ordinò che essa fosse trasferita in un nascondiglio segreto a prova
di bomba. Fu scelta una galleria sotto l'antica fortezza di Norimberga, attrezzata come
una camera blindata. Il 13 ottobre 1944 l'aviazione alleata sferrò un attacco definitivo
sulla Germania; la Oberan Schmied Gasse (Vicolo superiore dei fabbri), in cui era
celata l'entrata al tunnel con la camera blindata, venne completamente distrutta. Qualcuno
notò delle strane aperture che conducevano al sottosuolo, e presto si diffuse la voce che
nel terreno sottostante si trovasse un misterioso bunker corazzato. Il 20 aprile 1945 gli
alleati occuparono Norimberga. Il suo borgomastro, Willy Lebel, che conosceva il
nascondiglio della lancia, si suicidò, e qualcuno perquisì il suo appartamento per
assicurarsi che non vi fossero elementi atti a condurre gli americani al bunker nascosto.
Ma gli uomini dell'American Intelligence non rinunciarono alla ricerca: infatti,
qualche mese prima, il Premier britannico Winston Churchill aveva parlato dell'importante necessità
strategica di recuperare l'arma. Alle 14 e10 del 30 Aprile 1945, lo stesso giorno in
cui Hitler si suicidava a Berlino, la Heilige Lance venne recuperata dagli americani. Il
Generale Patton ammise successivamente che, per qualche istante, fu tentato di tenerla:
anche lui, infatti, era un conoscitore di cose occulte, ed era al corrente dei suoi
presunti poteri. Poi prevalse il buon senso: la Heilige Lance fu restituita all'Austria,
ed è ancora possibile ammirarla nel posto dov’era precedentemente: nella Weltliche
Schatzkammer dell'Hofburg di Vienna. Nel saggio Adolf Hitler and the Secrets
of the Holy Lance (Adolfo Hitler ed i segreti della Lancia Sacra), pubblicato a
tiratura limitatissima da una piccola casa editrice di Stelle, Illinois, (U.S.A.), il
Colonnello Howard A. Buechner ed il Capitano Wilhelm Bernhardt asseriscono che Himmler,
braccio destro del führer nazista, fece realizzare segretamente da un artigiano
giapponese un perfetto duplicato della Lancia sacra. Nel 1945 la falsa Heilige
Lance fu spedita a Norimberga, ove subì le vicissitudini riportate, mentre quella vera fu
trasportata da un sottomarino (l’U Boat 530), in un nascondiglio segretissimo
tra le montagne del ghiacciaio Muhlig Hiffman, nell’Antartide. La lancia
sarebbe stata recuperata da una misteriosa (ed organizzatissima) setta denominata Ordine
dei Cavalieri della Lancia Sacra, ed ora riposerebbe in un nuovo nascondiglio,
sorvegliata dai cavalieri, il cui obiettivo pare sia il mantenimento della giustizia e
della pace nel mondo.
Landmarks: Termine
inglese traducibile in limiti, termini, segni di confine, linee di demarcazione. Fu usato
per la prima volta nel 1721, ed è poi stato citato negli atti costitutivi delle Grandi
Logge che hanno giurisdizione nelle Obbedienze delle varie nazioni. Il termine viene
spesso confuso con regole e principi fondamentali della Massoneria. Vari studiosi ne hanno
infatti elencati anche 25, come il Mackey nel 1858. In realtà non sono molti, come
confermato dall'insigne studioso Roscoe Pound, Gran Maestro della Gran Loggia del
Massachussets, che ne elenca sette, sottolineando che il loro rispetto da parte di ogni
Massone dev'essere assoluto ed irrinunciabile, e la loro validità resta immutabile nel
tempo: 1) Monoteismo; 2) Credenza nell'immortalità attraverso la filosofia massonica; 3)
Il volume della Legge sacra, parte indispensabile dell'arredamento della Loggia; 4) La
leggenda di Hiram del 3° grado; 5) Il segreto massonico; 6) Il simbolismo dell'Arte
Operativa; 7) Il Massone dev'essere libero e di buoni costumi. Secondo Luigi Sessa (La
questione dei Landmarks, Ediz. Bastogi, Foggia, 1985), al termine d'una indagine
razionale e scientifica, conclude che "Gli autentici L. da conservare con cura,
cioè quelli previsti dalla 39a Regolazione, sono e restano soltanto confini. linee di
demarcazione da non superare. I L. garantiscono l'esistenza stessa dell'Istituzione per
quanto concerne la sua autenticità ed identità di ordine iniziatico. Essi garantiscono
le Istituzioni confinanti che la Massoneria non diverrà mai loro concorrente, invadendo
la loro sfera di competenza, violando cioè i limiti o confini esistenti. La mancanza di
demarcazione tra i territori porta alla confusione dei poteri iniziatici, religiosi e
politici; a conflitti e lotte spesso insanabili tra le Logge; alla distorta ed umiliante
strumentalizzazione dell'Istituzione massonica da parte di altri. Tali confini hanno le
tre caratteristiche dell'universalità, dell'immutabilità e dell'antichità, che
contraddistinguono i L. massonici. Come confini dell'Istituzione i L. sono universali,
perché tutte le Logge, in quanto depositarie della Tradizione muratoria, devono
conservare in ogni tempo e luogo i confini che le distinguono dalle istituzioni profane.
Come confini dell'istituzione, i L. sono inalterabili, soprattutto nel senso che sono
insopprimibili. Infatti anche se le vicende contingenti possono apportare modifiche
all'andamento dei confini, il Deposito tradizionale deve sempre restare conservato in
confini insopprimibili e, come tali, immutabili per l'inalterabile essenza iniziatica
dell'Istituzione. Infine, i L. sono antichi, esistendo da tempo immemorabile; se essi sono
intrinsecamente congeniti alla Tradizione, non possono essere coevi con la Tradizione
stessa, quindi la loro origine si perde nella notte dei tempi". I L. richiamano
il passo del Deuteronomio, in cui è scritto: "Non sposterai i termini del tuo
Prossimo, stabiliti dai tuoi antenati, nell'eredità che avrai nel paese di cui l'Eterno,
il tuo Dio, ti dà il possesso" (XIX, 14).
Lanterna: Figura
simbolica di norma associata a Platone (v.): la L. è simbolo della luce da essa emanata
che rischiara le tenebre, mentre il grande filosofo è ricordato quale sommo maestro delle
dottrine filosofiche che costituiscono la base dell’esoterismo, Luce
dell’Umanità. Il motto a lui attribuito (In Tenebris Lux) giustifica ancor
più questa associazione. La L. ovviamente compare spesso tra i simboli massonici come di
svariate istituzione esoteriche.
Lapidazione: Antico
supplizio consistente nel getto di sassi contro una persona colpevole di delitti
particolarmente gravi, come l’empietà, l’omicidio, la bestemmia e
l’adulterio. A seconda del tempo e del luogo in cui veniva praticata, rappresentava
lo sfogo spontaneo di un’ira collettiva, oppure pena prescritta dalle leggi. Gli
Ebrei dell’epoca di Mosé praticavano la L. contro gli idolatri, gli adulteri ed i
violatori del sabato. Presso gli antichi Greci questo supplizio è noto fin dal V secolo
a.C. Si narra che Eschilo evitò a stento la L. cui era stato condannato come
oltraggiatore dei culti ufficiali. I Macedoni uccidevano mediante L. i condannati a morte;
nel caso di rei di omicidio, essi venivano consegnati ai parenti della vittima, e toccava
all’accusatore scagliare la prima pietra. Presso i Romani la L., raramente applicata,
veniva eseguita solo contro i militari o, da parte del popolo, contro i cristiani. Il
protomartire Stefano fu appunto lapidato. In campo religioso si ha notizia di una L.
simbolica, sostituzione di quella reale; per esempio si lapidava un cadavere per non
essere preda dei suoi malefici. Anche il Cristo fu minacciato di L.: "Gli dissero
i Giudei: Non hai ancora cinquant’anni ed hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: In
verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse, Io Sono: Allora raccolsero pietre
per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio" (Giovanni
8, 57-59).
Lapis Philosophorum: Espressione alchemica impiegata tra le tante per indicare la Pietra Filosofale.
Lapsi: Termine con il
quale venivano designati i cristiani che, sotto la persecuzione di Decio (250 d.C.),
abiurarono la loro fede per evitare la tortura. A seconda delle dimostrazioni date dalla
loro abiura, venivano classificati in sacrificati (che offrivano sacrifici), thurificati
(che offrivano aromi alle immagini degli dei), traditores (che avevano
pubblicamente ammesso d’aver tradito la patria), libellotici (che avevano
rilasciato dichiarazioni scritte di abiura) ed acta facientes (che versavano denaro
per ottenere l’iscrizione negli elenchi di quanti accettavano i decreti imperiali).
Quando le persecuzioni volsero al termine, il problema della riconciliazione con i molti
L., che avevano chiesto di essere riammessi nella Chiesa, suscitò profonde controversie
nell’ambito della Chiesa stessa. A Roma, all’atteggiamento conciliante di papa
Cornelio, si oppose il rigore del movimento novaziano, mentre in Africa, dove i L. erano
molto numerosi, si ebbe la condanna di Cipriano, vescovo di Cartagine, che nel concilio
del 251 prescrisse che il perdono fosse accordato in base alle diverse circostanze
dell’abiura.
Larga Osservanza: V. Ordine della Stretta Osservanza.
Lari: Divinità romane (Lares
o Lar) che proteggevano le attività ed i luoghi domestici. L’origine del
culto ha elementi cronii: infatti in Grecia vennero chiamati daimonez,
ed il nome latino deriva dall’etrusco Lasa, una tipica divinità infera. In un
periodo ancora più antico esistevano già i Lares familiares e quelli compitales,
che proteggevano i compita (crocicchi) di campagna, per poi diventare protettori
delle strade (viatorii, viales e semitales), dei poderi, ed infine dello
stesso Stato (praestites, permarini, militares). Tra le più antiche raffigurazioni
vi è quella dei L. praestites, seduti col elmo, lancia, mantello ed un cane, che
simboleggia le custodia loro affidata. La più diffusa iconografia è quella dei L. di
aspetto giovanile, con tunica corta, alti calzari, mantello tenuto sulle braccia, corone
di fiori e foglie ed attributi quali il rython, la cornucopia e la situla
(v), un vaso tronco conico o cilindrico, con manico fissato ad anelli applicati
sull’orlo. Possono essere in atteggiamento di danza come di riposo. Molto diffuse
furono anche le statuette in bronzo. Esistono infine le are dei vicomagistri e, tra gli
affreschi pompeiani, quello in cui i L. appaiono associati al culto della Venere su una
quadriga di elefanti.
Lavori Massonici: V. Tornata.
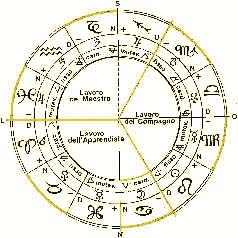 Lavoro: (L. interiore): Il Massone svolge il proprio lavoro in gruppo, insieme con gli altri fratelli di Loggia, o singolarmente. Il suo è un lavoro di ricerca e di costruzione. Nel suo compito egli si avvale degli esempi e del consiglio che gli vengono dagli altri fratelli, pur non trascurando l'aspetto che, per il suo stato di iniziato, ognuno è maestro di se stesso. Il massone per svolgere il suo lavoro utilizza gli strumenti che gli provengono dall'Arte. Essi sono di due diverse natura. La prima è esoterica, in riferimento alle varie forme del pensiero che non sono comunicabili, come l'intuizione, la riflessione, la contemplazione, la meditazione. I simboli, i rituali e le allegorie sono mezzi sfruttati per facilitare l'insegnamento di tali forme di pensiero. La seconda natura è essoterica e si riferisce al raziocinio, alla disciplina e al rigore interiore, che sempre devono accompagnarsi ai lavori interiori. È molto difficile distinguere il confine fra le due diverse nature, esoterica ed essoterica, degli strumenti della Massoneria. In ogni modo, per utilizzarli bene occorre conoscere a fondo l'Arte che comporta la padronanza dei metodi speculativi e operativi della Massoneria. Y (L.
massonico): La libertà interiore, almeno
considerandola nella sua potenza, dovrebbe essere concepita senza limiti. Succede, invece
che siamo soggetti a profonde restrizioni interiori, che ci impediscono non solo la
libertà di manifestarci ma addirittura di concepire un accrescimento dei nostri limiti.
La maggior parte delle volte siamo noi stessi a costruire i nostri limiti, in genere
persuasi da irrazionali timori nei riguardi del diverso. Questo avviene più o meno
inconsapevolmente. Tradizionalmente un tale timore o paura è definito "il
guardiano della soglia", che con il suo aspetto quasi terrificante ci impedisce di procedere oltre. È allora che vengono costruite barriere difensive interiori, utili solo ad imprigionarci in una sterile solitudine. Se invece si riesce a concepire il diverso come libera espressione della Natura, ci si accorge della assoluta inconsistenza dei guardiani della soglia, che non esistono se non nella nostra mente. Superata la soglia, invece di rischi e pericoli si scopre un mondo pieno di ricchezza, nel quale possiamo specchiarci in piena libertà. Il L. massonico nella Loggia propone proprio di accettare il diverso degli altri, quale fonte per l'accrescimento della nostra ricchezza interiore. Tale diversità è evidenziata dalle 12 Colonne riportanti i segni dello Zodiaco, da Ariete ai Pesci: una realtà inconfutabile che il Massone deve assolutamente accettare. Secondo il Mosca, tutto il Lavoro Muratorio si svolge, in ciascuno dei tre Gradi, su tre diversi livelli: fisico (Apprendista), animico (Compagno d’Arte) e spirituale (Maestro). · 1) In Grado di
Apprendista il Lavoro Muratorio deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano
fisico, con l’assunzione di un atteggiamento di carattere positivo-attivo, con
riferimento preponderante all’elemento Fuoco (primo di Ariete)ed agli altri elementi
primi (Terra prima di Toro, Aria prima di gemelli, Acqua prima di Cancro). Si tratta cioè
di incanalare lo slancio entusiastico, il desiderio, il volere, l’essere fuoco del
neo Iniziato, la sua forza, nella conquista del Silenzio, nella ricerca razionale e nella
profondità dell’osservazione, nell’apertura all’interiorità e
nell’avviamento del cammino sul sentiero di rettitudine e di elevazione che è il
solo mezzo per rendere effettiva e reale l’Iniziazione virtuale ricevuta dalla
Loggia. · 2) In Grado di Compagno d’Arte il Lavoro
deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano animico, con l’assunzione di
un atteggiamento di carattere negativo-ricettivo, con riferimento preponderante
all’elemento Acqua (seconda di Scorpione) ed agli altri elementi secondi (Fuoco
secondo di Leone, Terra seconda di Vergine, Aria seconda di Bilancia). Si tratta cioè di
indagare sempre più in sé stessi, di dominare la psiche e gli autocondizionamenti del
carattere e della passionalità, di verificare le proprie capacità sensoriali, di vincere
le emozioni e le suggestioni, di superare la fantasia nei suoi aspetti di ombra e di
irrealtà, per attingere all’immaginazione ed aprirsi alla dimensione artistica ed
all’archetipo della Bellezza. · 3) In Grado di Maestro
il lavoro deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano spirituale, con
l’assunzione di un atteggiamento di carattere equilibrante, con riferimento
preponderante all’elemento Aria (terza di Acquario) ed agli altri elementi terzi
(Fuoco terzo di Sagittario, Terra terza di Capricorno, Acqua terza di Pesci). Si tratta
cioè di dominare la mente, di conquistare la più difficile delle libertà, quella
interiore, dagli idoli e dalle incrostazioni dogmatiche e dottrinarie, di acquisire tutto
il "sapere saputo" per giungere alla Conoscenza, nonché di aprirsi
all’intuizione della Legge che è dentro e fuori di noi e, purificati, perseguire la
concretizzazione degli ideali a cui aspiriamo. Gli antichi rituali spiegano che: Tre
Fratelli formano una Loggia "semplice"; Cinque Fratelli formano una
Loggia "giusta"; Sette Fratelli formano una Loggia "giusta e
perfetta". · La Loggia semplice corrisponde
all’uomo pensante, ovvero analogicamente all’Uomo che: è formato da fisico
(Sole), Anima (Luna) e Spirito (Mercurio); si pone sui tre piani (fisico, animico e
spirituale) la problematica dell’esistenza, e cerca la risposta ai quesiti "Chi
siamo, da dove veniamo, dove andiamo". Questo è il livello in cui si esplica il
Lavoro dell’Apprendista, contraddistinto dal numero 3 (età, passi, gradini,
batteria, toccamento, il Delta luminoso, ecc.). · La Loggia giusta
corrisponde all’uomo che prende coscienza di sé, cioè analogicamente
all’Uomo che: oltre alle componenti qualitative citate acquisisce la Forza (Marte) e
la Bellezza (Venere); indaga e padroneggia la Legge Binaria, anche nel suo aspetto di Bene
e di Male, con tutte le relative implicazioni interiori. Questo è il livello in
cui si esplica il Lavoro del Compagno, contraddistinto dal numero 5 (età, passi, gradini,
Maestria, cioè analogicamente all’Uomo che: oltre alle cinque componenti qualitative
citate, prende coscienza della Giustizia (Giove) e del rigore (Saturno); è padrone della
Legge Binaria sui tre piani, ed applica la Giustizia ed il Rigore a sé stesso, ai
fratelli, all’Umanità, come espressione della legge Cosmica, esercitando il suo
libero arbitrio. È il livello in cui si esplica il Lavoro del maestro, che è
contraddistinto dal numero 7 e più (età, batteria, gradini, Menorah o candelabro a sette
braccia, ecc.). tutte le indicazioni qui riportate, essendo espresse nell’ambito
della scienza esoterica, sono del tutto scevre da qualsiasi implicazione moralistica e
profana. Inoltre va ricordato che il Tempio è rappresentazione del Cosmo, per cui i
riferimenti planetari non attengono al dominio dell’astrologia intesa volgarmente.
Essi non sono che l’esemplificazione analogica delle sette energie o forze collegate
dalla tradizione ai sette pianeti. Il fatto che la scienza astronomica abbia scoperto
urano, Nettuno e Plutone non scardina gli antichi schemi interpretativi. Questi tre ultimi
pianeti posti oltre l’orbita di Saturno potrebbero benissimo essere collocati in uno
schema simbolico che tenga conto di dieci, anziché di sette, distinzioni, come avviene
difatti nell’antica chiave tradizionale della Qabalah (v.), a base denaria, ed in
altre implicazioni, come l’Albero Sefirotico (v.). L’intero Lavoro Muratorio
citato, compresi i riferimenti alle energie elementali, zodiacali e planetarie (i sette
pianeti luminari comprendono anche il Sole e la Luna), possono essere rappresentati
sinteticamente dallo schema riportato, definibile come la schematizzazione del lavoro
Muratorio singolo e di gruppo, nei tre diversi Gradi. Infatti gli Apprendisti lavorano sui
segni legati ai quattro elementi primi, attinenti il piano fisico, i Compagni sui segni
legati ai quattro elementi secondi, attinenti il piano animico, ed i Maestri sui segni
legati ai quattro elementi terzi, attinenti il piano spirituale. Nella simbologia
Muratoria i dodici segni zodiacali corrispondono a qualità e conquiste interiori, ovvero:
· Primo Grado (Apprendista): piano fisico, attivo,
volitivo, razionale e solare - Ariete: spirito d’iniziativa, razionalità - Toro:
volontà, capacità creativa - Gemelli: agilità mentale, adattabilità - Cancro:
interiorizzazione, sensibilità; · Secondo Grado (Compagno
d’Arte): piano animico, ricettivo, psichico, lunare – Leone: sincerità,
attività realizzativa – Vergine: discernimento, analisi interiore – Bilancia:
equilibrio, elevazione verso la spiritualità – Scorpione: rigenerazione emozionale,
trasmutazione; · Terzo Grado (Maestro): piano
spirituale, intellettuale, equilibrante, mercuriale – Sagittario: saggezza,
speculazione supercosciente – Capricorno: concretezza, realizzazione degli ideali
spirituali – Acquario: intuizione, formulazione degli ideali universali – Pesci:
superamento della natura emozionale, purificazione. In conclusione, rappresentando la
Loggia l’Uomo ed il Cosmo, può avere una composizione ideale, in senso analogico, di
22 Fratelli. Infatti 22 sono le energie viste nei vari schemi di riferimento, e
precisamente: 3 energie elementali primarie (Fuoco, Acqua ed Aria, che si concretizzano
nel quarto elemento Terra), 7 energie planetarie e 12 energie zodiacali.
Lavoro: (L. interiore): Il Massone svolge il proprio lavoro in gruppo, insieme con gli altri fratelli di Loggia, o singolarmente. Il suo è un lavoro di ricerca e di costruzione. Nel suo compito egli si avvale degli esempi e del consiglio che gli vengono dagli altri fratelli, pur non trascurando l'aspetto che, per il suo stato di iniziato, ognuno è maestro di se stesso. Il massone per svolgere il suo lavoro utilizza gli strumenti che gli provengono dall'Arte. Essi sono di due diverse natura. La prima è esoterica, in riferimento alle varie forme del pensiero che non sono comunicabili, come l'intuizione, la riflessione, la contemplazione, la meditazione. I simboli, i rituali e le allegorie sono mezzi sfruttati per facilitare l'insegnamento di tali forme di pensiero. La seconda natura è essoterica e si riferisce al raziocinio, alla disciplina e al rigore interiore, che sempre devono accompagnarsi ai lavori interiori. È molto difficile distinguere il confine fra le due diverse nature, esoterica ed essoterica, degli strumenti della Massoneria. In ogni modo, per utilizzarli bene occorre conoscere a fondo l'Arte che comporta la padronanza dei metodi speculativi e operativi della Massoneria. Y (L.
massonico): La libertà interiore, almeno
considerandola nella sua potenza, dovrebbe essere concepita senza limiti. Succede, invece
che siamo soggetti a profonde restrizioni interiori, che ci impediscono non solo la
libertà di manifestarci ma addirittura di concepire un accrescimento dei nostri limiti.
La maggior parte delle volte siamo noi stessi a costruire i nostri limiti, in genere
persuasi da irrazionali timori nei riguardi del diverso. Questo avviene più o meno
inconsapevolmente. Tradizionalmente un tale timore o paura è definito "il
guardiano della soglia", che con il suo aspetto quasi terrificante ci impedisce di procedere oltre. È allora che vengono costruite barriere difensive interiori, utili solo ad imprigionarci in una sterile solitudine. Se invece si riesce a concepire il diverso come libera espressione della Natura, ci si accorge della assoluta inconsistenza dei guardiani della soglia, che non esistono se non nella nostra mente. Superata la soglia, invece di rischi e pericoli si scopre un mondo pieno di ricchezza, nel quale possiamo specchiarci in piena libertà. Il L. massonico nella Loggia propone proprio di accettare il diverso degli altri, quale fonte per l'accrescimento della nostra ricchezza interiore. Tale diversità è evidenziata dalle 12 Colonne riportanti i segni dello Zodiaco, da Ariete ai Pesci: una realtà inconfutabile che il Massone deve assolutamente accettare. Secondo il Mosca, tutto il Lavoro Muratorio si svolge, in ciascuno dei tre Gradi, su tre diversi livelli: fisico (Apprendista), animico (Compagno d’Arte) e spirituale (Maestro). · 1) In Grado di
Apprendista il Lavoro Muratorio deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano
fisico, con l’assunzione di un atteggiamento di carattere positivo-attivo, con
riferimento preponderante all’elemento Fuoco (primo di Ariete)ed agli altri elementi
primi (Terra prima di Toro, Aria prima di gemelli, Acqua prima di Cancro). Si tratta cioè
di incanalare lo slancio entusiastico, il desiderio, il volere, l’essere fuoco del
neo Iniziato, la sua forza, nella conquista del Silenzio, nella ricerca razionale e nella
profondità dell’osservazione, nell’apertura all’interiorità e
nell’avviamento del cammino sul sentiero di rettitudine e di elevazione che è il
solo mezzo per rendere effettiva e reale l’Iniziazione virtuale ricevuta dalla
Loggia. · 2) In Grado di Compagno d’Arte il Lavoro
deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano animico, con l’assunzione di
un atteggiamento di carattere negativo-ricettivo, con riferimento preponderante
all’elemento Acqua (seconda di Scorpione) ed agli altri elementi secondi (Fuoco
secondo di Leone, Terra seconda di Vergine, Aria seconda di Bilancia). Si tratta cioè di
indagare sempre più in sé stessi, di dominare la psiche e gli autocondizionamenti del
carattere e della passionalità, di verificare le proprie capacità sensoriali, di vincere
le emozioni e le suggestioni, di superare la fantasia nei suoi aspetti di ombra e di
irrealtà, per attingere all’immaginazione ed aprirsi alla dimensione artistica ed
all’archetipo della Bellezza. · 3) In Grado di Maestro
il lavoro deve tendere alla realizzazione (padronanza) sul piano spirituale, con
l’assunzione di un atteggiamento di carattere equilibrante, con riferimento
preponderante all’elemento Aria (terza di Acquario) ed agli altri elementi terzi
(Fuoco terzo di Sagittario, Terra terza di Capricorno, Acqua terza di Pesci). Si tratta
cioè di dominare la mente, di conquistare la più difficile delle libertà, quella
interiore, dagli idoli e dalle incrostazioni dogmatiche e dottrinarie, di acquisire tutto
il "sapere saputo" per giungere alla Conoscenza, nonché di aprirsi
all’intuizione della Legge che è dentro e fuori di noi e, purificati, perseguire la
concretizzazione degli ideali a cui aspiriamo. Gli antichi rituali spiegano che: Tre
Fratelli formano una Loggia "semplice"; Cinque Fratelli formano una
Loggia "giusta"; Sette Fratelli formano una Loggia "giusta e
perfetta". · La Loggia semplice corrisponde
all’uomo pensante, ovvero analogicamente all’Uomo che: è formato da fisico
(Sole), Anima (Luna) e Spirito (Mercurio); si pone sui tre piani (fisico, animico e
spirituale) la problematica dell’esistenza, e cerca la risposta ai quesiti "Chi
siamo, da dove veniamo, dove andiamo". Questo è il livello in cui si esplica il
Lavoro dell’Apprendista, contraddistinto dal numero 3 (età, passi, gradini,
batteria, toccamento, il Delta luminoso, ecc.). · La Loggia giusta
corrisponde all’uomo che prende coscienza di sé, cioè analogicamente
all’Uomo che: oltre alle componenti qualitative citate acquisisce la Forza (Marte) e
la Bellezza (Venere); indaga e padroneggia la Legge Binaria, anche nel suo aspetto di Bene
e di Male, con tutte le relative implicazioni interiori. Questo è il livello in
cui si esplica il Lavoro del Compagno, contraddistinto dal numero 5 (età, passi, gradini,
Maestria, cioè analogicamente all’Uomo che: oltre alle cinque componenti qualitative
citate, prende coscienza della Giustizia (Giove) e del rigore (Saturno); è padrone della
Legge Binaria sui tre piani, ed applica la Giustizia ed il Rigore a sé stesso, ai
fratelli, all’Umanità, come espressione della legge Cosmica, esercitando il suo
libero arbitrio. È il livello in cui si esplica il Lavoro del maestro, che è
contraddistinto dal numero 7 e più (età, batteria, gradini, Menorah o candelabro a sette
braccia, ecc.). tutte le indicazioni qui riportate, essendo espresse nell’ambito
della scienza esoterica, sono del tutto scevre da qualsiasi implicazione moralistica e
profana. Inoltre va ricordato che il Tempio è rappresentazione del Cosmo, per cui i
riferimenti planetari non attengono al dominio dell’astrologia intesa volgarmente.
Essi non sono che l’esemplificazione analogica delle sette energie o forze collegate
dalla tradizione ai sette pianeti. Il fatto che la scienza astronomica abbia scoperto
urano, Nettuno e Plutone non scardina gli antichi schemi interpretativi. Questi tre ultimi
pianeti posti oltre l’orbita di Saturno potrebbero benissimo essere collocati in uno
schema simbolico che tenga conto di dieci, anziché di sette, distinzioni, come avviene
difatti nell’antica chiave tradizionale della Qabalah (v.), a base denaria, ed in
altre implicazioni, come l’Albero Sefirotico (v.). L’intero Lavoro Muratorio
citato, compresi i riferimenti alle energie elementali, zodiacali e planetarie (i sette
pianeti luminari comprendono anche il Sole e la Luna), possono essere rappresentati
sinteticamente dallo schema riportato, definibile come la schematizzazione del lavoro
Muratorio singolo e di gruppo, nei tre diversi Gradi. Infatti gli Apprendisti lavorano sui
segni legati ai quattro elementi primi, attinenti il piano fisico, i Compagni sui segni
legati ai quattro elementi secondi, attinenti il piano animico, ed i Maestri sui segni
legati ai quattro elementi terzi, attinenti il piano spirituale. Nella simbologia
Muratoria i dodici segni zodiacali corrispondono a qualità e conquiste interiori, ovvero:
· Primo Grado (Apprendista): piano fisico, attivo,
volitivo, razionale e solare - Ariete: spirito d’iniziativa, razionalità - Toro:
volontà, capacità creativa - Gemelli: agilità mentale, adattabilità - Cancro:
interiorizzazione, sensibilità; · Secondo Grado (Compagno
d’Arte): piano animico, ricettivo, psichico, lunare – Leone: sincerità,
attività realizzativa – Vergine: discernimento, analisi interiore – Bilancia:
equilibrio, elevazione verso la spiritualità – Scorpione: rigenerazione emozionale,
trasmutazione; · Terzo Grado (Maestro): piano
spirituale, intellettuale, equilibrante, mercuriale – Sagittario: saggezza,
speculazione supercosciente – Capricorno: concretezza, realizzazione degli ideali
spirituali – Acquario: intuizione, formulazione degli ideali universali – Pesci:
superamento della natura emozionale, purificazione. In conclusione, rappresentando la
Loggia l’Uomo ed il Cosmo, può avere una composizione ideale, in senso analogico, di
22 Fratelli. Infatti 22 sono le energie viste nei vari schemi di riferimento, e
precisamente: 3 energie elementali primarie (Fuoco, Acqua ed Aria, che si concretizzano
nel quarto elemento Terra), 7 energie planetarie e 12 energie zodiacali.
 Labirinto:
Termine greco, laburindoz, che
definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,
su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti
culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea
consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.
Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,
cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il
Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il
modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato
il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e
delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi
ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per
la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è
presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze
neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma
meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,
dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.
quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della
Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è
tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione
pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente
usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al
riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato
nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,
esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli
undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata
equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità
ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della
fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano
come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato
fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),
in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel
corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La
simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una
fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul
significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato
risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è
il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno
riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei
morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie
rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,
nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di
destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".
Labirinto:
Termine greco, laburindoz, che
definisce l’edificio fatto costruire, secondo il mito greco, dal re Minosse di Creta,
su progetto dell’artefice Dedalo. L’origine del nome risale ad ambienti
culturali come la Lidia e la Licia, mentre le scoperte relative alla lingua micenea
consentono di documentare la forma da-pu-ri-to (daburintho), in epoca piuttosto antica.
Secondo il mito, nel L. fu rinchiuso il Minotauro (v.), mostro metà uomo e metà toro,
cui venivano periodicamente sacrificati 14 fanciulli inviati da Atene come tributo. Il
Minotauro fu ucciso dall’eroe Teseo con l’aiuto di Arianna, che gli insegnò il
modo di uscire per mezzo del filo e della corona di luce. Vari studiosi hanno identificato
il L. con il palazzo minoico di Cnosso: la presenza in tale edificio di oggetti votivi e
delle asce bipenni (v.) sembrò confortare tale ipotesi, poiché il termine ascia (labruz) è di origine lidia, ed è accostato al L. Altri studiosi
ritengono invece che il L. si identifichi con un luogo oscuro, difficile da percorrere per
la tortuosità della pianta ed i trabocchetti che vi sono predisposti; tale luogo è
presente non solo nel mondo greco, ma genericamente nel Mediterraneo, con ascendenze
neolitiche (Malta, Egitto, Lemno ed Etruria). L’iconografia è resa da una forma
meandroide, che appare in molti monumenti: di particolare interesse le monete di Cnosso,
dove l’immagine del Minotauro è inserita in una cornice a meandro. Oltre al L.
quadrato, si conoscono raffigurazioni di tipo circolare, come nelle oinochòe della
Tagliatella (fine VII secolo a.C.) ed in opere di ambiente nordico. In epoca romana è
tema diffuso nell’arte del mosaico, prestandosi particolarmente alla decorazione
pavimentale (Pompei, Gallia, Spagna e Renania). In epoca cristiana viene frequentemente
usato come simbolo delle difficoltà del cammino per raggiungere il regno di Dio. Al
riguardo risulta molto significativa l'immagine riportata, che raffigura il L. intarsiato
nel pavimento della cattedrale di Chartres. Simbolo del tortuoso cammino di redenzione,
esso veniva percorso dai pellegrini in ginocchio che, in circa un'ora, completavano gli
undici meandri concentrici per un totale di 262 metri. Questa attività veniva considerata
equivalente a un pellegrinaggio in Terrasanta, e permetteva di ottenere dalle autorità
ecclesiastiche lo stesso numero di indulgenze. Nel Medioevo il L. fu anche simbolo della
fratellanza dei Liberi Muratori, costruttori di Cattedrali. Gli Alchimisti lo indicavano
come centro alchemico o L. di Salomone. Uno splendido esempio di L. in mosaico era stato
fatto costruire dal Principe Raimondo di Sangro sul pavimento della sua Pietatella (v.),
in materiale artificiale durissimo di sua invenzione, che purtroppo è stato eliminato nel
corso di interventi di ristrutturazione effettuati verso la fine del XIX secolo. La
simbologia massonica latina accosta i viaggi preiniziatici del neofita al L., una
fenomenologia che il Fratello K. Kerenyi così sintetizza: "Agli interrogativi sul
significato delle leggende, delle raffigurazioni e delle tradizioni sul L. ha dato
risposta lo storico delle religioni di Leida, Brede Kristensen, secondo il quale il L. è
il mondo degli inferi; con le sue tortuosità ed i suoi vicoli ciechi, tra i quali nessuno
riesce a trovare una via d’uscita, non può rappresentare altro che il mondo dei
morti. Resta il dubbio che sia veramente questo l’elemento distintivo delle varie
rappresentazioni del L., e non piuttosto il fatto che una via d’uscita ci sia sempre,
nonostante le sue tortuosità, un riferimento alla capacità dell’essere umano di
destreggiarsi all’infinito attraverso ogni tipo di morte".