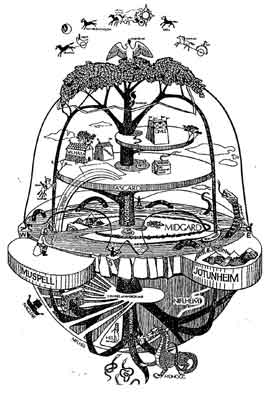Ibaditi:
Termine derivato dall'arabo Ibadiyya che identifica una setta eretica musulmana, ramo dei
Kharigiri, fondata da ‘Abd Allah ibn
Ibad al-Murri at Tamini, vissuto in Mesopotania nel VII-VIII secolo. Gli I.
conquistarono l'Oman, e fondarono poi alcuni staterelli nell'Africa
settentrionale: quello dei Midrariti di Sigilmasa (722-776); quello dei
Rustamidi di Tahart (757-924) ed altri stati minori. Gli I. sono tuttora diffusi
in Algeria (Mzab), Tunisia (Gerba), Tripolitania (Gebel Nefusa), Oman e
Zanzibar, ove si distinguono per i costumi molto rigidi e soprattutto per la
loro profonda dedizione allo studio del Corano.
Ibis: Termine usato per designare varie specie di uccelli della famiglia
Treschiornitidi ed all'ordine Ciconiformi. L'I. sacro (Threskiornis æthiopicus),
detto anche uccello sacro d'Etiopia, ha piumaggio candido con testa e collo neri, privi di
piume. Anche le punte delle remiganti sono di colore nero. L'apertura alare è di circa 75
cm., e frequenta le rive dei fiumi e dei laghi. Attualmente è protetto, essendo diventato
raro. L'I. eremita (Comatibis eremita) è di colore nero con riflessi metallici, e
lo si trova nell'Africa settentrionale. L'I. rosso (Guara guara) ha piumaggio
rossastro con penne remiganti nere, e vive in Amazzonia. L'I. era l'uccello sacro
dell'antico Egitto, raffigurato in rilievi e pitture tombali. Nei geroglifici (v oppure t) indica
il verbo "risplendere" e derivati. L'I. sacro incarnava il dio Thot (Hermes
o Mercurio). Ad Ermopolis, città consacrata a Thot, furono rinvenuti migliaia di I.
mummificati, spesso contenuti entro statuine cave, di legno o bronzo.
I.B.M.:
Acronimo massonico rappresentante le iniziali delle parole
sacre dei primi tre gradi dell'Apprendista (v.), del Compagno d'Arte (v.) e
del Maestro Massone (v.). Alcuni studiosi lo fanno derivare da “Jacobus
Burgundus Molay”, ultimo Gran Maestro dell'Ordine Templare (v.), arso
vivo nel 1314 sotto il regno di Filippo il Bello come eretico, reo di non aver
voluto rivelare i segreti dell'Ordine presieduto.
Iconoclastia: Termine
derivato dal greco bizantino eiconoclastthz, rompere
l’immagine, impiegato per definire l’eresia cristiana nata durante il periodo
del cesaropapismo bizantino (VIII-IX secolo), la quale , pur ammettendo il culto di
Cristo, della Vergine e dei Santi, vietava qualsiasi raffigurazione di questi, nonché
qualsiasi forma di culto alle loro immagini od icone. Proclamata ufficialmente (728)
dall’imperatore Leone III l’Isaurico (717-41), l’I. suscitò polemiche di
carattere religioso e dottrinale fra le opposte fazioni degli iconoclasti e degli
iconoduli, oltre a gravi rivolte popolari. Gregorio III lanciò la scomunica contro
l’I. durante il Concilio di Roma del 731, ma l’eresia permase anche sotto il
figlio di Leone III, Costantino V Copronimo, che anzi la riconfermò con un editto (741) e
con un concilio riunito nel palazzo di Hieria sul Bosforo ((754), comminando pene severe
contro gli iconoduli. Nel 780, alla morte dell’imperatore Leone IV, gli iconoclasti
avevano ancora il sopravvento. Tuttavia l’imperatrice vedova Irene, in un concilio di
Nicea (787), ristabilì l’ortodossia iconodulica. Con Leone V l’Armeno (813-20)
la parte degli iconoclasti riprese il sopravvento, che conservò fino alla morte
dell’imperatore Teofilo (842), ed all’avvento di Teodora, reggente per il
minorenne Michele III, la quale in un concilio di Costantinopoli (843) ristabilì
l’ortodossia. Altri concili (869 e 879) ribadirono la dottrina iconodulica; tuttavia
le contese occasionate dalla questione iconoclastica approfondirono la divisione fra
Occidente ed Oriente.
Iconologia: Termine
usato dalla critica d’arte per definire lo studio del rapporto tra il motivo
mitologico, letterario o religioso, e la sua rappresentazione artistica. L’interesse
per l’interpretazione iconologica delle forme artistiche, affermato a partire dagli
anni ’30., si è esteso anche all’architettura, in particolare dopo gli ormai
classici Studies in Iconology (1939) di E. Panofsky, ponendo in rilievo le
componenti degli stili storici (tipologiehe, dimensionali e matematiche, decorative, ecc.)
come portatrici di precisi valori semantici, allegorici e simbolici. In questo senso
l’I. della scuola di Aby Warburg ha precise relazioni con la Filosofia delle forme
simboliche di E. Cassirer, per cui Panofsky ha potuto parlare della prospettiva
rinascimentale come "forma simbolica", capace di definire non solo le
regole della visione, ma un’intera filosofia delle configurazioni artistiche. Oggi i
metodi dell’I., associati ad altre chiavi di interpretazione dei fenomeni artistici,
appaiono indispensabili per una conoscenza scientifica del significato delle opere
d’arte.
Idealismo: Comprende ogni concezione filosofica tendente a risolvere la realtà in una serie di atti spirituali oggettivi e soggettivi, per cui l'oggetto della conoscenza si riduce a rappresentazione o a idea. Definisce anche il modo di pensare, di vivere e di agire proprio di quanti credono in un ideale tendendo a realizzarlo ed a conquistarlo. Per Marx, ed ancor più per Lenin, l'I. rappresenta il punto più elevato del pensiero borghese, un punto contenente l'analisi materialistica della realtà. Da questo particolare punto di vista l'I., raggiunto il massimo del proprio sviluppo con la scoperta del carattere dialettico della realtà, va rovesciato nel materialismo. È una filosofia diversa, non più fondata sullo spirito ma sulla materia e sui rapporti sociali materiali. L'I. moderno trae origine dalla metafisica della coscienza di Descartes, dall'I. sostanzialistico di Spinoza (la materialità è un attributo dell'essere), dall'immaterialismo di Leibniz (monadi come centri di attività spirituali) ed dall'empirismo di Berkeley e di Locke (l'essere corrisponde all'essere percepiti). Di qui nasce la filosofia di Kant, da lui stesso definita I. trascendentale, in cui si ritrova la netta distinzione tra momento conoscitivo e mondo fenomenico. In seguito nasce il nuovo I. tedesco di Fichte (con accento soggettivo), di Schelling (con accento oggettivo) e di Hegel, che ripropone l'ipotesi di una teoria complessiva della realtà basata sulla razionalità interna e sullo svolgimento dialettico dei suoi vari momenti. Il neo I. italiano di Croce (criticamente) e di
Gentile (con il suo attualismo) si richiama pure alla tradizione hegeliana, seppure
variamente rielaborata.
Identità: Qualificazione
di una persona, di un luogo, di una cosa per cui essa è tale e non altra. Significa anche
uguaglianza completa ed assoluta. (G.O.I.) La Libertà ci consente di esprimerci
nelle nostre manifestazioni e, per conseguenza, di prendere coscienza della nostra I.
rispetto al mondo che ci circonda. Tuttavia, avviene che nel difficile confronto con il
mondo esterno si prendano spesso, come riferimenti, modelli che ben poco hanno a che fare
con la nostra essenza. Per tali motivi la nostra I. risulta falsata ai nostri stessi
occhi. Tutto questo è profondamente innaturale e conduce ad ansia, insicurezza e sfiducia
in noi stessi. La libertà interiore ci consente di approfondire la ricerca della nostra
reale I., sempre che si sappiano superare i falsi modelli, che sovente rappresentano veri
e propri dogmi non messi in discussione. Il desiderio di ricerca di una vera e convincente
I. rappresenta il primo passo verso una crescita interiore.
Idolatria: Termine
derivato dal greco eidwlon, immagine, e latreia,
culto, che definisce l’adorazione di immagini cui vengono attribuiti poteri divini.
Il concetto di I., nella teologia vetero e neotestamentaria, si estende a comprendere
qualsiasi culto diverso dalla religione rivelata. Proibita dal primo comandamento
del Decalogo mosaico, l’I. viene considerata grave infrazione dei rapporti fra Yahweh
ed Israele. Nel cristianesimo dei primi secoli veniva espiata soltanto mediante una
punizione pubblica. Tale termine venne impiegato da J. Luddock nel 1875, per indicare a
livello etnologico una fase religiosa anteriore a quella delle divinità creatrici. Gli
idoli, o feticci, sono rappresentati con aspetto antropologico o talvolta zoomorfico (v.
anche Feticismo).
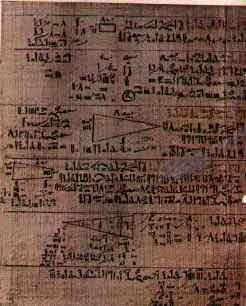 Ieratico: Scrittura
nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere
considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più
elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.
venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,
testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,
testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì
continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito
dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.
Ieratico: Scrittura
nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere
considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più
elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.
venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,
testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,
testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì
continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito
dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.
Ierocrazia: Termine
di derivazione greca che definisce la branca della teocrazia (v.) in cui si esprime
l’attribuzione del potere politico alla casta sacerdotale, un fenomeno che ha
caratterizzato la storia dell’ebraismo primitivo (v.).
Ierodulia: Termine
derivato dal greco ieroz, sacro, e doulia,
servitù, che definisce la prostituzione sacra o cultuale praticata da uomini e donne nel
corso di cerimonie nei templi di Afrodite (v.), i cui proventi erano devoluti per coprire
le necessità del tempio stesso. Nell’antica Grecia era chiamato ierodulo lo
schiavo addetto ai servizi minori del tempio, come la preparazione dei sacrifici e la cura
degli arredi sacri. L’istituto della I., che secondo alcuni studiosi avrebbe
sostituito il sacrificio umano, era forse di origine semitica, e fu diffuso in occidente
dai Fenici. La I. è severamente condannata dall’Antico Testamento: "Tra le
figlie ed i figli di Israele non ci sia alcuna prostituta né alcun prostituto. Non
portare nella casa del signore Iddio tuo il guadagno di una meretrice, né la mercede di
un prostituto, per qualsiasi voto, perché entrambe sono abominazioni davanti al Signore
Iddio tuo" (Deuteronomio 23, 18-19).
Ierofante: Termine derivato dalle voci greche ieros (sacro) e jainw (mostrare).
Nell'antica Grecia veniva così chiamato il capo del sacerdozio addetto al tempio di
Eleusi (v.), ed era una carica tradizionalmente riservata alla famiglia degli Eumolpidi.
Si sa molto poco delle sue funzioni, come d'altra parte dei misteri eleusini: Sembra che
in effetti il I. mostrasse agli iniziati determinati oggetti sacri nel corso dei riti.
Ogni anno teneva un discorso (hrorrhsiz) pubblico agli
iniziandi, prima della partenza della solenne processione che li avrebbe condotti da Atene
ad Eleusi. Talvolta viene erroneamente denominato Gerofante.
Ierogamia: Termine
usato nella storia delle religioni per indicare i complessi riti religiosi, in molte
religione antiche, relativi alle nozze fra due divinità, o fra una divinità ed un
mortale. Durante la festa di Capodanno, in Babilonia, venivano rinnovate le nozze tra il
dio della città e la dea celeste Ishtar. Nell’antico Egitto riti analoghi
commemoravano le nozze di Nut (cielo) e Geb (terra). Anche nell’induismo e nel
buddhismo tantrico il dio si unisce alla sua sakti (v.).
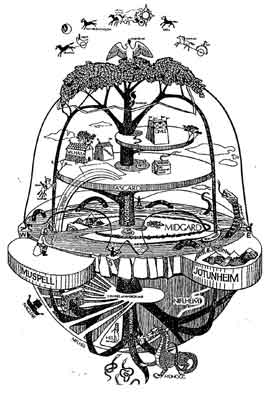 Iggdrasil: Nome della
quercia sacra sotto la cui ombra si raccoglievano giornalmente i severi dei giustizieri
della Scandinavia. Essa aveva tre radici: una si stendeva fino alla dimora degli dei, era
qui che gli dei pronunciavano le loro sentenze, da essa sgorgava la santa fonte del tempo
passato, era vigilata da tre vergini Norne (simili alle Parche) che distribuivano l'età
agli uomini con l'aiuto di varie Fate, dispensatrici delle sorti umane, liete e tristi; la
seconda si allungava fino alla terra dei Giganti, da essa sgorgava la fonte della saggezza
alla quale s'era dissetato Mimis, il padre universale, lasciandovi cadere in pegno
uno dei suoi occhi; l'ultima radice ricopriva l'inferno, vi dimorava il mostruoso serpente
Niddhogger, e le sue ramificazioni si levavano fino al cielo avviluppando il mondo.
L'I. era insidiato da molti nemici: quattro cervi ne brucavano le foglie, un'aquila era
appollaiata sulla sua cima, ed uno scoiattolo scorrazzava su e giù per suscitare
discordia tra i cervi e l'aquila.
Iggdrasil: Nome della
quercia sacra sotto la cui ombra si raccoglievano giornalmente i severi dei giustizieri
della Scandinavia. Essa aveva tre radici: una si stendeva fino alla dimora degli dei, era
qui che gli dei pronunciavano le loro sentenze, da essa sgorgava la santa fonte del tempo
passato, era vigilata da tre vergini Norne (simili alle Parche) che distribuivano l'età
agli uomini con l'aiuto di varie Fate, dispensatrici delle sorti umane, liete e tristi; la
seconda si allungava fino alla terra dei Giganti, da essa sgorgava la fonte della saggezza
alla quale s'era dissetato Mimis, il padre universale, lasciandovi cadere in pegno
uno dei suoi occhi; l'ultima radice ricopriva l'inferno, vi dimorava il mostruoso serpente
Niddhogger, e le sue ramificazioni si levavano fino al cielo avviluppando il mondo.
L'I. era insidiato da molti nemici: quattro cervi ne brucavano le foglie, un'aquila era
appollaiata sulla sua cima, ed uno scoiattolo scorrazzava su e giù per suscitare
discordia tra i cervi e l'aquila.
Ignazio di Loyola: Religioso spagnolo (castello di Loyola, Azpeitia, Guipùzcoa, 1491 - Roma,
31.7.1556) il cui nome completo era Inigo Lòpez de Recalde y Onaz y Loyola. Appartenne
alla nobile famiglia basca degli Onaz y Loyola, figlio di Bertràn Yanez, ebbe
un’educazione militare e cavalleresca. Tra il 1518 ed il 1521 fu ufficiale al seguito
del viceré di Navarra. Nel maggio del 1521 fu ferito nel corso della difesa di Pamplona
contro i Francesi; la convalescenza nel castello di Loyola fu una tappa decisiva per la
sua vocazione religiosa, peraltro stimolata dalla lettura della Vita Christi di
Ludolfo di Sassonia. Durante alcuni soggiorni eremitici nel Montserrat ed a Mantesa di
Catalogna (1522-23), scrisse la prima stesura degli Exercicios espirituales para vencer
a si mismo, che vennero poi progressivamente rielaborati fino al 1541. Dopo un viaggio
in Palestina (1523-24), studiò a Barcellona, Alcalà e Salamanca (1524-27); a Parigi dal
1528, frequentò i corsi di filosofia dei Domenicani, e raccolse i primi sei seguaci, cui
si unì con il cosiddetto voto di Montmartre (15.8.1534); nel 1535 ottenne il titolo di Magister
artium. Il suo programma comprendeva, oltre al voto di povertà e castità,
l’apostolato militante in Terrasanta o, comunque, al servizio del papa. Consacrato
sacerdote a Venezia (1537), alla fine dello stesso anno si recò a Roma per mettersi a
disposizione di Paolo III che, il 27.9.1540, approvò le Constituciones con las
Declaraciones (la cui ultima stesura fu redatta nel 1550) e la fondazione
dell’ordine Societas Jesu (S.J.), o Compagnia di Gesù (v. Gesuiti), della
quale I. fu il primo "generale". Mentre l’ordine si andava
estendendo, dopo aver affidato ai membri della sua Compagnia il compito
dell’insegnamento (1547) I. fondò numerose scuole, tra cui il Collegio romano
(1551), ed il Collegio germanico (1552), e tenne una fitta corrispondenza con ogni parte
del mondo. I. esercitò un influsso decisivo sulla Controriforma (v.), e venne santificato
nel 1622.
IHS:
Monogramma
cristiano, trascrizione latina delle prime tre letteredel nome greco di Gesù
(greco IHS [OUS], latino IHS oppure JHS),
nella quale la lettera greca H (h) è stata erroneamente assimilata alla latina
H (h). Quindi il latino Ihesus o Jhesus.
Già in uso nel II-IV secolo, il monogramma si diffuse soprattutto in Italia ed
poi in Spagna (XIV-XV secolo) ad opera di Bernardino da Siena e Vincenzo Ferrer,
predicatori della devozione al nome di Gesù. Ignazio da Loyola (v.) lo adottò,
sormontato da una croce, come emblema dei Gesuiti (v.).
Ilemorfismo: Dottrina
basata sui concetti espressi da Aristotele (v.) sulla natura degli esseri. Quindi
l’I. ritiene che la costituzione di tutti i corpi sia composta da due diversi
elementi: una materia prima inerte, ed una forma, elemento attivo ed agente.
Illuminati di Baviera: Ordine, ma essenzialmente movimento di pensiero, di mera ispirazione massonica,
fondato nel 1776 da Adam Weishaupt (1748-1830), un gesuita, professore di diritto canonico
dal temperamento collerico e violento. Denominato inizialmente Società dei
Perfettibili, si adoprò per disseminare tempesta in tutta Europa, in nome della
libertà e dell'uguaglianza, mirando all'abolizione delle leggi in vigore giudicate
inique. Gli storici sostengono che questo movimento ebbe per mezzo il nichilismo
(dottrina negante in modo radicale determinati sistemi di valori) e per fine il comunismo
primitivo più integrale, proponendosi così la distruzione dell’ordinamento
politico e sociale esistente. Nel corso di un importante convento massonico tenutosi a
Wilhelmsbad, il movimento degli I. si scontrò contro il muro d'indifferenza eretto dalle
varie obbedienze massoniche del tempo, che avevano sperato di conquistare alla loro causa.
Furioso e deluso, il Weishaupt (che aveva nel frattempo assunto il nome di battaglia Spartacus)
richiese allora ai suoi seguaci di disseminarsi segretamente nelle diverse logge, di
impadronirsi dei segreti dei lavori iniziatici e di sfruttarle per preparare la grande
Rivoluzione. Quel tentativo doveva fallire, ma qualche illuminato, diventato libero
muratore grazie alla debolezza dei sistemi di reclutamento, si sarebbe lasciato poi andare
a dichiarazioni estremiste, in nome di un Ordine massonico che non poteva che
disapprovarle. Come conseguenza, molti storici avrebbero in seguito confuso la Massoneria
con l’Ordine degli I., attribuendogli così fisionomia e finalità, impropriamente
connesse alle prime intenzioni, che l’Ordine stesso non aveva mai avuto. Nel 1783 gli
I. furono sospettati di trame rivoluzionarie, tanto che vennero dapprima incolpati di
complotti contro le istituzioni dello Stato e della Chiesa, e poi perseguitati. In seguito
il duca Elettore di Baviera emetteva un’ordinanza contro tutte le fratellanze sorte
senza concessione sovrana, dopodiché, nel 1785, l’Ordine venne definitivamente
vietato dal Re di Baviera, e messo al bando anche negli altri Stati tedeschi.
Illuminismo: Termine
che indica un vasto movimento culturale, manifestatosi nel corso del XVIII secolo tra la
rivoluzione inglese e quella francese. In campo filosofico e scientifico ha origine
dall’empirismo inglese; in quello politico e giuridico dal giusnaturalismo; nel
dibattito religioso dal deismo (V:) e dal materialismo. La pedagogia (con J.J. Rousseau) e
l’estetica (con A.G. Baumgarten) si costituiscono come discipline autonome nel
periodo illuminista. Scopo dichiarato degli illuministi è quello di portare i lumi della
ragione in ogni campo dell’attività umana, per rinnovare non soltanto il metodo
scientifico, ma anche la vita sociale, la cultura e le istituzioni. Si combattono i
pregiudizi, che impediscono il cammino della civiltà e si oppongono al progresso. Tra i
caratteri principali, la rinnovata fiducia nella ragione, capace di chiarire e risolvere
tutti i problemi dell’uomo, la polemica contro la tradizione filosofica medievale, la
certezza che un’era migliore stava nascendo; la ricerca di un nucleo di verità
morali originario e comune a tutti gli uomini e superiore ad ogni forma di dogma, di
superstizione e d’intolleranza; impegno a diffondere ogni tipo conoscenza,
soprattutto quella di carattere scientifico, per abbattere il passato e preparare la nuova
era. Una delle idee fondamentali dell’I. fu quella del diritto naturale (o diritto di
natura, o diritto delle genti, o diritto universale) da cui derivò quello spirito di
universale giustizia e libertà, che ebbe tanta parte nelle rivoluzioni francese ed
americana. I maggiori rappresentanti dell’I. furono: in Francia Voltaire e gli
enciclopedisti come Diderot e d’Alembert; in Germania Lessing; in Italia Genovesi,
Beccaria ed altri.
Iloteismo: Termine
derivato dal greco ulh, materia, e deoz,
dio, che quindi significa la divinità nella natura, indicando l’identificazione tra
i due principi. È sinonimo di Panteismo (v.).
Imam: Vocabolo arabo che
nell’Islamismo ortodosso o sunnita ha assunto il significato di capo della comunità
universale musulmana, ossia di Califfo (v.), o di sovrano di uno Stato musulmano. Per gli
Sciiti I. sono invece i monarchi musulmani per volontà divina, cioè Alì, genero di
Maometto (v.) ed i suoi discendenti in linea diretta maschile (dodici o sette). Coloro che
ammettono gli I. in questo senso sono detti imamiti ( in arabo Imamiyyah).
Più genericamente I. è colui che dirige la preghiera rituale comune nelle moschee, senza
lacuna implicazione di ordinazione sacerdotale. L’ufficio divenne fisso solo nel XIX
secolo e nell’Impero Ottomano a partire dal 1871; nel 1925 in Turchia ebbe anche
varie funzioni soppresse, conservate comunque negli altri paesi arabi durante
l’occupazione coloniale. Si dicono infine I. anche coloro che eccellono nelle scienze
o nelle lettere.
Immaginazione: Facoltà
di pensare senza regole fisse, e di associare liberamente i dati dell'esperienza
sensibile. (G.O.I.) La libertà interiore implica la nostra capacità di manifestarci in forme da noi liberamente e deliberatamente scelte, senza costrizioni e vincoli che ci provengono da altre sorgenti incontrollabili. A prima vista potrebbe sembrare che tali sorgenti siano tutte collocate al di fuori di noi, ma non è così. È ben vero che spesso si è profondamente condizionati dagli eventi esterni, ma le insidie più subdole provengono proprio da noi stessi. Tradizionalmente viene detto che è la nostra forma imperfetta a tenere la chiave della nostra prigione, ma che è la nostra personalità profana, simboleggiata da Saturno, il vecchio per eccellenza, quella che determina la nostra forma imperfetta. L'I., ossia l'azione nel profondo (imum ago),
può aiutarci a concepire nella nostra coscienza i modi d'essere che ci possono portare
oltre i limiti del nostro carcere. Si deve però considerare accuratamente la profonda
differenza che distingue l'I. dalla fantasia.
Immagine: Termine che
la filosofia definisce la rappresentazione mentale di un'esperienza percettiva che si dà
in assenza di questa. Già la filosofia medioevale aveva insistito sull'I. sia come specie
sensibile che come specie intelligibile. Gli empiristi inglesi la intendono come invece
solo come copia, rappresentazione sbiadita della percezione sensibile. A partire dal XIX
secolo, con Galton, Ribot e Wundt, l'I. è stata studiata dalla psicologia moderna.
Recentemente Sartre ne ha rimesso in discussione l'interpretazione complessiva, legando
l'I. ad un processo di irrealizzazione, non risultato di una coscienza sbiadita, ma di una
particolare forma di coscienza, tipicamente propria dell'artista. Attualmente il tema
dell'I., oltre alla psicologia, interessa vasti settori commerciali ed industriali,
coinvolgendo il campo dell'arte figurativa ed molto più in generale quello delle
comunicazioni e delle pubbliche relazioni.
Immanentismo: Termine
generico abbracciante tutte le posizioni filosofiche che risolvono il problema della
realtà nel suo complesso, oppure dell'assoluto, all'interno del mondo dell'esperienza
variamente inteso. Quindi l'I. si oppone alle filosofie della trascendenza (v.), sia
classiche che medioevali, e caratterizza gran parte del pensiero moderno e contemporaneo,
dalle diverse forme di panteismo, all'empirismo ed al materialismo del Settecento, al
kantismo, all'idealismo tedesco, al positivismo, al marxismo, fino alle correnti
esistenzialistiche e fenomenologiche contemporanee.
Immanenza: Nel
pensiero filosofico indica l'appartenenza al soggetto od all'agente, significando presenza.
Nel pensiero classico l'I. riguarda soprattutto il piano degli esseri viventi, i cui atti
sono appunto definiti immanenti, ovvero che procedono autonomamente dal vivente stesso.
Nel pensiero moderno l'I. è riferita al piano della conoscenza, concepibile solo partendo
dal pensiero individuale, vale a dire dall'io penso di Kant. Oppure, più
radicalmente, riducendo la realtà alla percezione soggettiva (Berkeley) od allo spirito
(v. idealismo). Dal livello gnoseologico (v.) il principio di I. è stato anche esteso a
quello etico e storico, soprattutto in rapporto all'elaborazione dell'idealismo. (G.O.I.)
La coscienza dell'Immanenza è indirettamente legata alla percezione di forze preziose. Se si riesce a superare la contingenza degli eventi, al di la delle manifestazioni si può percepire la presenza di qualcosa che ci sovrasta, che in un certo senso ci fa chiaramente comprendere l'esistenza dell'istante presente. Si tratta di un'esperienza che coinvolge una coscienza esistenziale e che, allorché compresa, ci accompagna poi per sempre. In generale l'I. viene percepita in modo passivo: ovvero semplicemente c'è, esiste, e non abbiamo modo di influenzarla. Talvolta appare favorevole, mentre altre volte si presenta sotto forma vagamente minacciosa, generando un'ansia opprimente, decisamente temuta da quanti l'hanno provata. È tuttavia possibile il superamento dei suoi aspetti enigmatici e la penetrazione della sua essenza. Nell'I. si possono anche scoprire fonti di risonanze veramente insperate.
In Eminenti: È il nome della prima enciclica papale con cui si condanna la Massoneria, proibendo ai cattolici di farne parte. Emessa dal papa Clemente XII il 24 aprile 1738, essa tra l'altro sostiene: "Associazioni segrete si diffondono generalmente col nome di massoneria,
o sotto altre denominazioni, secondo le lingue. Sono uomini di tutte le religioni e sette,
paghi di una parvenza presunta di una certa qual rettitudine naturale. Essi si riuniscono
fra loro in stretto legame segreto, secondo leggi ed usanze stabilite, ed agiscono in pari
tempo in comune, impegnandosi con un giuramento pronunciato sulla Sacra Scrittura e sotto
pena di gravi pene ad uno scrupoloso silenzio. Per sbarrare la via tanto larga che
potrebbe condurre alla penetrazione non punita dell'ingiustizia, anche in base ad altri
motivi a noi noti, giusti e legittimi, abbiamo ritenuto giusto ed abbiamo deciso di
condannare e proibire le dette società, circoli, associazioni segrete, assemblee o bande
clandestine note col nome di massoni, o con qualsiasi altra denominazione. Noi vogliamo
inoltre, ed ordiniamo, che sia vescovi che prelati, superiori ed ordinari, nonché gli
inquisitori destinati in ogni luogo, data la eresia maligna, procedano ed indaghino contro
i trasgressori, quali che siano il loro stato, la dignità, il rango, la nobiltà, la
priorità, ed infliggano a questi le pene meritate, se veramente sospetti di eresia, e li
reprimano, perché noi diamo e conferiamo a tutti e ad ognuno di essi l'autorità di
procedere contro i trasgressori e punirli, anche ricorrendo all'ausilio del braccio
secolare". La condanna è stata nel tempo esplicitamente rinnovata da vari altri
pontefici, a seconda dei climi politici che la storia ha presentato. Tra atti, encicliche
e bolle, sono ormai circa trecento le conferme della scomunica (v.) della Libera Muratoria
emesse ad oggi dalla Chiesa di Roma.
Inana Yoga: Espressione
impiegata nella filosofia indiana, che significa "Filosofia della sapienza", ed
indica uno dei tre sentieri che portano l’essere umano alla Liberazione. Gli altri
due sono il Karma Yoga (v.) ed il Raya Yoga (v.). È alla base dei sistemi
filosofico-religiosi Vedanta (v.) e Samkya (v.). Questa dottrina ritiene realizzabile
l’assoluta liberazione attraverso la comprensione dei grandi Misteri
dell’Universo.
Inca: Termine con cui gli
antichi Peruviani indicavano i sovrani ed i principi di stirpe regia. A partire dal XIII
secolo, gli I. di un piccolo clan della provincia di Cuzco estesero progressivamente il
loro potere, e costituirono nella regione delle Ande centrali un vasto impero. I sovrani
detenevano l’autorità suprema, sia politica che militare e religiosa, essendo
considerati figli del sole. Alla fine del XIII secolo gli I. divennero potentissimi.
Yupanqui (1493-1525) conquistò l’Ecuador; Huyna Capac (1493-1525) arrivò a
controllare l’intera fascia costiera dell’Oceano Pacifico, fino a comprendere
parte del Cile e, all’interno, tutta la Bolivia e l’Argentina settentrionale.
Con la morte di Huayna cominciò il declino: nel 1531 il conq1uistatore spagnolo F.
Pizarro attirò in un tranello il successore Atahualpa e, dopo aver massacrato i suoi
uomini, lo fece strangolare (1532). Seguì una lunga serie di rivolte contro gli invasori
portoghesi, regolarmente stroncate nel sangue. L’ultima fu quella guidata da Tupac
Amaru (1671). L’arte degli I., nella quale confluirono apporti delle precedenti
culture di Chavin, di Tahuanaco e di Chimù, è tecnicamente perfetta. Caratteristiche, ed
in parte tuttora visibili, sono le grandi città fortezza di Machu Picchu (v.), di
Colquampata, di Sacsahuaman, di Kenco e di Oliantaytambo, modellate secondo una tipologia
costante, simile a quella della capitale Cuzco, alla quale erano collegate mediante una
rete stradale. Gli edifici, chiusi verso l’esterno ed in genere privi di elementi
decorativi, sono costruiti in mattoni ed argilla, specie lungo le regioni costiere, od in
conci di pietra sovrapposti a secco. Molto sviluppato l’artigianato, soprattutto per
quanto riguarda oreficeria, glittica, ceramica e tessitura.
Incarnazione: Termine
che in genere indica l’assunzione di sembianze umane da parte di una entità divina.
Sono molte le regioni che presentano la credenza nell’I. della divinità. La
religione egizia ammetteva che il dio avesse il potere di assumere forma ed immagine
terrena, sia per suo proprio volere che per effetto di riti speciali. Assume particolare
nell’induismo, con l’idea degli avatara (v.), ovvero delle apparizioni in
aspetto materiale di Visnù tra gli esseri umani. Nella teologia cattolica I. è
l’unione ipostatica, cioè personale, della natura umana e divina in Cristo; fondato
sulla Sacra Scrittura, in particolare sul passo di Giovanni "il Verbo si fece
carne" (Giovanni 1, 14), il dogma dell’I. venne elaborato lentamente nei primi
secoli cristiani, e progressivamente definito attraverso i primi quattro concili
ecumenici, particolarmente dal concilio di Calcedonia (451). Con la dottrina
dell’unione ipostatica, viene affermata l’unione delle due nature, umana e
divina. Il modo in cui essa si realizza fu oggetto di grandi controversie e di numerose
correnti teologiche.
Incesto filosofale: Termine facente parte della dottrina alchemica (V. Uroboros).
Inconscio Esoterico: L’Alchimia parla spesso di Serpente, Aquila, Mercurio filosofico e fasi
della Trasmutazione (Nigredo, Albedo, Rubedo), per cui nasce spontanea la domanda
sull’utilità pratica di queste cose. Gli antichi filosofi hanno lasciato tracce
eloquenti sull’argomento. Alcuni esempi possono essere rilevati dalla Turba
Philosophorum: "Sappiate, voi investigatori dell’Arte, che il suo fondamento
è una cosa sola" (Sizio); "Sappiate, figli della Dottrina, che la Pietra
nostra è fatta di due cose" (Turba); "L’Opera nostra fin dal
principio si ha da lavorare con due Nature, che sono di una medesima sostanza: l’una
è preziosa e l’altra è vile" (Pitagora). Le citazioni riportate sembrano
indicare che si tratta di una sola materia, distinta in due parti, di cui una più
preziosa ed una più vile. Questa materia misteriosa viene rappresentata come un Serpente
ed un’Aquila, che ne rispecchiano i due diversi aspetti. Jung ha intuìto che la
materia di cui parlano gli ermetisti non è che l’I., ovvero quella parte del nostro
spirito che non è direttamente accessibile alla coscienza. Il Serpente e l’Aquila
simboleggiano due tipi di I., definibili I. lunare ed I.. solare. · L’I. lunare (Serpente) è associato a simboli legati alle
acque profonde, ai laghi ed alla stessa Luna. Si tratta di un I. paragonabile al mare, in
cui finisce ogni esperienza e sensazione umana. In esso è memorizzato ogni dettaglio
dell’esistenza vissuta, tutti i ricordi, anche quelli che non si riesce più a
richiamare alla coscienza, ma che possono riaffiorare in particolari condizioni, come al
risveglio da una sensazione. Poiché la maggior parte dell’esistenza implica
sofferenza, il contenuto di questo I. è prevalentemente formato da ricordi dolorosi di
varia entità, e solo da alcuni ricordi piacevoli. Competono inoltre all’I. lunare i
cosiddetti istinti, che sono l’eredità della specie, la componente animale di
ciascun essere umano, che necessita di cibo, di riprodursi, di reagire o di fuggire
davanti al pericolo, ecc. · L’I. solare (Aquila) è la
parte più preziosa, ma anche la sacca più piccola. Questo I. contiene sintetici schemi
comportamentali, che vengono automaticamente attivati in ogni situazione. Sono schemi che
organizzano quasi del tutto il comportamento quotidiano, mentre solo una esigua parte dei
pensieri e delle azioni è affidato alla volontà individuale. Quindi la maggior parte del
pensare e dell’agire non è consapevole ma automatica. Si tratta di schemi formatisi
in età prescolare, quando l’esperienza infantile si avvia verso l’associazione
con la ragione (il bambino agisce per imitazione e per ricordo), e la loro formazione e
modifica prosegue nel corso dell’intera esistenza. Prevalgono gli schemi difensivi,
in quanto la vita è dedicata ad evitare il dolore, sia fisico che spirituale, mentre in
parte sono presenti chiavi comportamentali atti ad uscire vittoriosi. Tali schemi vengono
attivati dalla ragione, dalle situazioni e dall’I. lunare. Gli schemi possono
appartenere ad individui perdenti oppure vincenti, come evidenziato dal fatto che taluni
individui tendano a commettere ripetutamente lo stesso errore, e corrispondono sempre alle
finalità perseguite. Ad esempio, qualora nell’I. lunare vi siano elementi che
spingono alla solitudine, come ricordi, esperienze e parametri riferiti a legami
opprimenti che hanno portato alla sofferenza, allora l’individuo adotterà schemi che
portano all’isolamento, perché inconsciamente intende evitare la sofferenza
collegata ad un legame sentimentale troppo vincolante. Se quell’individuo dovesse
incontrare l’anima gemella, difficilmente saprà cogliere l’occasione per
realizzare la propria felicità, poiché il comportamento adottato, appena il legame tende
a stringersi, sarà tale da provocare la separazione ed il ritorno ad una vita di
solitudine. Vi sono perdenti cronici, il cui fine inconscio è la sconfitta, per evitare
le responsabilità legate all’eventuale vittoria. Occorre precisare che negli schemi
vi è solo l’esperienza personale e quella derivata da eventuali idoli., ovvero da
persone idealizzate ed adottate come modello, od anche esperienze viste nelle persone a
cui si è legati. Non v’è comunque alcunché di universale o di innato, per cui gli
schemi possono essere errati e perdenti. Nessun schema deriva da esperienze ancestrali,
cioè da vite precedenti, mentre il karma può sicuramente influenzare la capacità di
mutarli. In sintesi si può affermare che l’I. solare possa attingere da quello
lunare, secondo una razionalità non gestibile liberamente. Quindi si tratta di una
facoltà decisamente elevata, solare e normalmente incontrollabile. Essa organizza le
esperienze, proprie e dei propri idoli, ha grandi capacità di sintesi, ma si basa
unicamente sui contenuti dell’I. lunare, portando come s’è visto a
comportamenti perdenti o vincenti. Sono sempre schemi molto sintetici ma anche precisi,
ben definiti, che tengono in considerazione sia le limitazioni individuali fisiche e
psichiche, sia degli aggiornamenti acquisiti nel tempo per invecchiamento od a seguito di
traumi psicofisici, che fanno variare le singole capacità. Quindi contengono le
limitazioni fisiche, intellettive, di resistenza e di capacità di concentrazione, e sono
formati da successioni di azioni psicologiche, materiali e vegetative, che possono anche
protrarsi a lungo nel tempo. Non si esauriscono mai in tempi brevi, specie se sono stati
costituiti per perseguire un fine, per cui esercitano la loro influenza fino al termine
dell’esperienza, risultando variati dalla successione di vari sottoschemi non
necessariamente fissi. Oltre che per mutate condizioni psicofisiche, gli schemi si possono
modificare anche quando la volontà fa sperimentare nuove strade. Se l’esperienza è
stata complessivamente positiva od almeno neutra, si modifica lo schema precedente, mentre
se l’esperienza è stata negativa il vecchio schema resta immutato, rafforzandosi. Y (Interazioni) L’I. lunare contiene la memorizzazione
delle esperienze vissute e gli istinti della specie. Tale I. invia continuamente messaggi
all’I. solare, attivando i corrispondenti schemi comportamentali. L’analisi di
una giornata tipo, dal risveglio al sonno notturno, rivela come in ogni circostanza siano
stati adottati automatismi comportamentali prescelti, o preferiti, in quanto meno
dolorosi, o più piacevoli. All’impatto con una situazione nuova l’I. solare
scorre rapidamente tutti gli schemi immagazzinati per trovare quelli più simili da
applicare, mentre al contempo l’I. lunare ricerca un’esperienza analoga che
possa aver implicato sofferenza. Se lo rintraccia, invia immediatamente una serie di
impulsi all’I. solare, affinché adotti un certo schema difensivo che protegga dal
dolore. Nascono così le fobìe, le nevrosi e le ossessioni, scatenate anche da un
particolare apparentemente insignificante, ma che comunque risultano potenzialmente
dolorose per l’I. lunare, che può innescare eccessivi schemi di difesa attraverso
l’I. solare. Si tratta di schemi di difesa spesso anomali ed inutili, che
condizionano l’esistenza dell’individuo e di quanti sono in contatto con lui. In
conclusione, sono state definite le materie dell’Opera, ovvero l’I. lunare e
quello solare. Basilio Valentino (v.), nel suo Rosarium Philosophorum (1550), sosteneva
che "Ratio est quia ars primas dispositiones inducere non potest", ovvero
che l’arte non può creare le disposizioni primarie, cioè che la materia della
nostra opera è fornita dalla natura, e sta solo a noi perfezionarla. Facendo questo
però, continua il grande filosofo alchimista, scopriremo nel nostro Mercurio una grande
perfezione, e ciò sarà fonte di una grande gioia, prossima alla vera felicità.
Alchemicamente è lo stadio di Nigredo, della formazione della Sostanza mescolata, quello
che collega, che unisce e mette in comunicazione diretta l’I. lunare con quello
solare.
Inconscio Scientifico: Insieme dei contenuti e dei processi psichici che sono impliciti in molti
comportamenti dell’individuo motivandoli, rimanendo tuttavia estranei e non noti alla
sua coscienza. L’ipotesi dell’esistenza di una vita psichica profonda, di cui
per l’uomo protagonista non vi fosse un’effettiva consapevolezza, riemerse
periodicamente nell’evoluzione del pensiero fin dai tempi della filosofia platonica.
Occorre però arrivare ai primi dell’800, in piena atmosfera romantica, perché
nell’ambiente letterario e filosofico si trovi un interesse più persistente e
sistematico per un’impostazione dinamica della vita psichica, e per
l’esplorazione di attività psichiche inconsce. Nel 1846 il Carus giunse a
distinguere un I. assoluto, che identificava in una "regione
dell’anima in cui non penetra mai alcun raggio di coscienza", ed un I. relativo,
costituito da contenuti che un tempo sono stati coscienti. Verso la fine dell’800,
l’accentuarsi dell’interesse per i fenomeni medianici ed il primo fiorire di
ricerche scientifiche sull’argomento, portarono parallelamente a conclusioni circa il
supposto operare di una psichicità secondo modalità incoscienti. Se si aggiungono gli
studi sull’isteria di Charçot, i risultati delle applicazioni cliniche
dell’ipnotismo di Liébault e Bernheim, si completa il quadro della temperie
culturale in seno alla quale, indipendentemente l’uno dall’altro, Janet e Freud
sarebbero giunti a definire e ad utilizzare più ampiamente il concetto di I.:
pervenendovi l’uno agli studi sull’automatismo psicologico negli stati
sonnambolici, l’altro dalle osservazioni condotte con Breuer sugli effetti
dell’ipnosi sulla sintomatologia isterica. Successivamente questa intuizione,
ulteriormente approfondita e verificata da Freud e dai suoi allievi mediante particolari
tecniche di osservazione e di studio su pazienti nevrotici e su soggetti normali, divenne
uno dei cardini della teoria e della pratica psicoanalitiche , e contribuì al verificarsi
di svolte decisive nell’ambito di varie discipline, in particolare della psicologia e
della psichiatria, sia per quanto concerne le modalità di approccio allo studio della
personalità globale e delle singole funzioni psichiche, sia per i diversi orientamenti
applicativi che ne derivarono (psicodiagnostica, psicoterapia, ecc.). Nelle definitive
formulazioni freudiane di vita psichica, sia in condizioni normali, sia in condizioni
patologiche, appare comprendere contenuti e processi di cui v’è consapevolezza ed
altri inconsapevoli od inconsci. Contenuti e processi inconsci in senso stretto sono
considerati quelli che non hanno in genere possibilità di giungere per sé stessi alla
coscienza, senza che intervengano trasformazioni particolari nell’individuo. Può
trattarsi di materiale non suscettibile di diventare consapevole o per sua natura
(istinti), o perché soggetto a rimozione; inoltre certi meccanismi difensivi, tra i quali
la rimozione stessa, risultano essi stessi inconsci, e possono essere colti e descritti
essenzialmente da un osservatore esterno. Tutti questi elementi (immagini,
rappresentazioni, pensieri, ricordi, emozioni, ecc.), pure non consapevoli, ma
suscettibili di un facile accesso alla coscienza, come attraverso uno sforzo di
attenzione, vengono considerati preconsci. L’I. può dunque essere inteso come
un deposito di elementi (concezione topica); ma anche come un modo di essere di certi
contenuti mentali, che pure in queste condizioni non cessano peraltro di esercitare
un’azione sulla vita cosciente; ed addirittura come una particolare qualità del
funzionamento mentale (prospettiva dinamica). Quanto agli oggetti, secondo la teoria
psicoanalitica, rappresentazioni mentali, istinti o componenti parziali degli istinti,
sentimenti, meccanismi di difesa ed istanze morali, possono essere o diventare I. La vita
mentale inconscia appare governata da leggi in parte comuni, in parte specifiche, rispetto
a quelle che reggono lo psichismo cosciente. Tra i fatti evidenti, per primi ed in quanto
sottoposti alle tecniche di osservazione e di interpretazione proprie della psicanalisi,
hanno rivelato ruoli simbolici profondi, ed hanno consentito quindi di gettare uno sguardo
sulle modalità di funzionamento dello psichismo inconscio, sono i sintomi nevrotici, i
sogni e numerose altre manifestazioni pure tipiche della nevrosi o della normalità, e
proprie della vita di veglia: come il lapsus linguae, le dimenticanze, gli atti
mancati, e certe fantasticherie. Una prova, di natura sperimentale, del concorso di
processi mentali inconsci nel determinare pensieri e comportamenti, viene considerata il
perdurare degli effetti di suggestione, in soggetti sottoposti ad ipnosi (v.), anche
durante lo stato post-ipnotico e senza che ve ne sia l’autoconsapevolezza. Ulteriori
caratterizzazioni dell’I., in rapporto a contenuti tipici, sono state delineate da
Jung, che nel cosiddetto I. collettivo identifica la parte dell’I. comune alla
specie umana, e composta di elementi od immagini primordiali (archetipi, C.G. Jung,
1928, 1943). È da citare inoltre L. Szondi (1937), che per I. familiare intende il
complesso delle tende affettive, a carattere ereditario recessivo, che possono motivare i
rapporti interpersonali (simpatia, antipatia, scelta del partner, ecc.).
L’applicazione del concetto di I. ha portato un innegabile contributo contenutistico
e prospettico alla psicologia generale, che nelle sue forme tradizionali, poteva
considerarsi prevalentemente una psicologia della coscienza, in quanto studio del
funzionamento mentale cosciente. Si è assistito addirittura ad una reversione di
prospettiva, nel senso che da parte di molti si è finito con il considerare la coscienza
come una caratteristica importante, ma non necessaria, delle operazioni mentali, le quali
possono anche essere del tutto inconsce. In ambito percettivo, immaginario e pratico, una
buona parte dei processi ed una certa parte dei contenuti si collocano al di fuori del
livello di coscienza: basti ricordare i fenomeni della percezione subliminale; la dinamica
delle illusioni, degli atti produttivi e creativi (percezione, immaginazione, sogno),
della formazione di abitudini, della ritenzione mnestica, dell’elaborazione ed
attuazione di decisioni, dei fatti della vita emotiva ed in particolare dell’ansia; i
comportamenti espressivi; i comportamenti d’organo, o comportamenti molecolari,
ecc. In sostanza, l’esistenza dell’area dell’I. nella vita psichica sembra
rispondere funzionalmente a precise condizioni ed esigenze: ·
mancanza di capacità necessarie per la presa di coscienza, in seguito ad un differente
orientamento evolutivo o ad un insufficiente sviluppo, come negli animali, nel bambino,
nel debole mentale, od in seguito a mancato apprendimento, come nell’adulto delle
culture occidentali, in riferimento a numerosi fenomeni mentali, motori e neurovegetativi,
per affermare consapevolmente i quali occorrono specifici addestramenti, od in seguito a
fatti regressivi, come nell’invecchiamento ed in certe intossicazioni, allorché
l’area della coscienza si restringe; · rimozione
dell’area della coscienza, in senso freudiano, avente lo scopo di ridurre il
carattere doloroso o semplicemente fastidioso di eventi in forte conflitto con le regole
sociali apprese o con esigenze edonistiche della persona; ·
necessità di delimitare il campo dell’attenzione, concentrando questa più sopra i
risultati dei processi psichici che non sui loro preliminari e sul loro decorso, ed anche
focalizzando soprattutto quei contenuti che maggiormente rispondono al momento funzionale
attraversato dall’individuo. Tali esigenze di economia operativa, per le quali
l’individuo evita di avere contemporaneamente presenti alla coscienza tutti i suoi
contenuti e processi mentali, vengono soddisfatte anche sostituendo concetti e simboli ad
ampie moltitudini di dati elementari, mediante i processi di costantizzazione
dell’esperienza, e di apprendimento, abitudine, automatizzazione delle azioni.
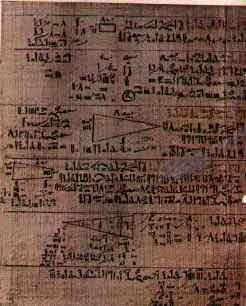 Ieratico: Scrittura
nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere
considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più
elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.
venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,
testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,
testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì
continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito
dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.
Ieratico: Scrittura
nata dalla semplificazione dei geroglifici egiziani. La scrittura I. può essere
considerata un corsivo schematizzante i geroglifici originali, di struttura più
elaborata, e rimase in uso fino alla fine del Nuovo Regno (XVIII-XX Dinastia). In I.
venivano redatti atti amministrativi, giuridici, transazioni commerciali, rapporti,
testamenti, inventari, censimenti, ed anche opere letterarie, scientifiche, religiose,
testi e rituali sacri o magici, nonché corrispondenza privata. La scrittura I. subì
continue modifiche e semplificazioni. Verso il IX secolo a.C. lo I. decadde, sostituito
dal demotico (v.), e venne poi usato solo per la trascrizione di testi sacri sul papiro.