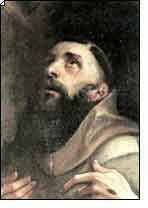Finalità: Fine, scopo. Principio filosofico classico in base al quale tutto ciò che si
verifica tende verso un fine ultimo, espresso mediante la formula "ogni agente
agisce secondo un fine". Aristotele lo considera parte di quei principi
dimostrativi detti assiomi, che si basano cioé su un'intuizione immediata. La
Scolastica distingue dal finalismo (v.) la F. essenziale, che riguarda il rapporto di ogni attività con il suo risultato prossimo. Per il Massone è importante considerare che ogni essere umano vive accompagnato dalla sensazione interiore di un significato e di una F. insiti nella vita. Arduo distinguere fra la F. della vita da quella globale della vita che ci circonda. Tale sensazione il più delle volte resta vaga ed inespressa, ma esiste, per quanto possa sembrare impercettibile. Essa rappresenta una delle maggiori forze che aiutano a vivere, anche e soprattutto nei momenti particolarmente difficili. Non si possono fornire prove concrete di tale sensazione. La spiegazione di una F. biologica della vita, nella quale non ci sia spazio per la nostra individualità, appare priva di significato. Ammettere una vita senza F. ripugna profondamente. Tutto questo è un dato di fatto, vero per ogni individuo. È l'insieme di tutti gli esseri viventi, ovvero dell'intera umanità, che costituisce quanto definiamo vita. L'Iniziato, proiettato verso la ricerca interiore, ritiene opportuno e corretto il percorrere tale via, essendo profondamente convinto che la perfetta auto conoscenza possa fornire una migliore comprensione delle F. cui si aspira. Attraverso queste si raggiunge la sintonia con le più ampie e diverse mete giudicate alla nostra portata, e quindi conseguibili nel corso dell'esistenza. Y (F. biologica) Il
comune concetto di F. biologica dovrebbe essere finalmente allargato alla sfera
dell'interiorità. Indipendentemente dagli scopi individuali di ogni essere umano, che si
manifestano nell'arco dell'esistenza, è possibile osservare che, nell'ambito del
meccanismo dell'evoluzione, la ricerca della propria individualità occupa
progressivamente sempre più spazio nella vita degli esseri umani. Nell'arco di una
normale vita umana risultano pressoché impercettibili le manifestazioni dei risultati
dell'evoluzione. Negli ultimi anni appare sempre più evidente una specie di accelerazione
dei "tempi". Ogni estrapolazione oltre i nostri attuali limiti appare,
per ora, ben difficile da realizzare. Importante sembra rimanere la percezione cosciente
dei cambiamenti che sono in atto, anche se la risposta a "dove andiamo"
rimane ancora velata dall'incertezza.
Fitoterapia: Terapia
effettuata con droghe o principi vegetali. Nella medicina antica era praticamente il
cardine fondamentale se non l’unica forma di terapia (v. Erboristeria). La medicina
moderna studia accuratamente le medicine tradizionali dei popoli primitivi, ed affronta in
laboratorio l’estrazione dei principi attivi delle piante, con cui confeziona
direttamente farmaci, o di cui utilizza la molecola come punto di partenza per nuove
formule. Il termine F. viene inoltre usato per definire quella particolare scienza che si
occupa della cura delle malattie delle piante.
Flagellanti: Gruppi
di fanatici religiosi, denominati anche Disciplinanti o Battuti, comparsi
verso la metà del XIII secolo, inizialmente nell’Italia centrale. Ne fu iniziatore
l’eremita Ranieri Fasani (1260) a Perugia. Nel corso di processioni, si flagellavano
pubblicamente, convinti che questa forma di penitenza potesse scongiurare guerre ed
epidemie. Conobbero grande diffusione in tutta l’Europa durante l’epidemia di
peste nera del 1348-1349, ed i loro eccessi indussero papa Clemente VI a condannarli
formalmente (1349), ordinandone la carcerazione. Il movimento venne così stroncato, ma
alcuni gruppi risorsero sporadicamente anche nel secolo successivo, senza peraltro alcun
seguito significativo.
Flagellazione: Parte
del rituale magico per stimolare la fecondità, oppure a carattere apotropaico (v.). Già
praticata presso i Babilonesi e gli antichi Ebrei, la F. era nota anche ai Greci ed ai
Romani. A Sparta venivano flagellati i giovanetti al cospetto della statua di Artemide
Ortia (Plutarco, Licurgo 38). A Roma le donne si fustigavano durante i Lupercali
(15 febbraio), e nelle feste della Bona Dea (1° maggio). Anche il culto di Cibele
comprendeva la F. I Vangeli (Matteo 28, 26; Marco 115, 15; Giovanni 19, 1) ricordano la F.
di Gesù. Ricordata in testi del IV secolo, la colonna della F. è tradizionalmente
additata sia nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, sia in quella di Santa
Prassede a Roma, dove sarebbe stata portata dal cardinale Giovanni Colonna (1223). La F.
venne praticata fin dall’XI secolo da taluni ordini monastici. Nota è la F. cui si
sottoponeva a scopo espiatorio San Luigi Gonzaga (1568-1591), religioso della Compagnia di
Gesù, delle quali restano tuttora evidenti tracce sulle pareti della stanza del convento
di Chieri (Torino) in cui egli la praticava.
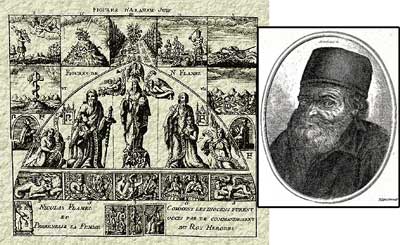 Flamel Nicolas: Soprannominato l'Alchimista benefattore. "Quattordici ospedali, tre
cappelle e sette chiese nella città di Parigi, tutte costruite dalle fondamenta ed
arricchite con grandi doni e lasciti; e Boulogne quasi del pari con Parigi, per non
parlare delle beneficienze nei confronti dei poveri, specialmente delle vedove e degli
orfani". Intorno al 1390 era così che Nicolas e Perenelle Flamel raccontavano
come avevano utilizzato parte della loro enorme ricchezza. Il parigino F., grazie
alla sua professione di scrivano e copista, aveva spesso occasione di imbattersi in libri
rari e antichi. Nel 1357 ne aveva acquistato uno fittamente miniato e dalle insolite
dimensioni: "La legatura era in solido ottone, e dentro vi erano figure e
caratteri che non erano né latini né francesi. Era stato scritto con una matita di
piombo, su fogli di corteccia, ed era stranamente colorato". Sulla prima pagina,
in lettere d'oro, compariva la dicitura "Abramo l'Ebreo, Prete, Principe, Levita,
Astrologo e Filosofo, alla nazione degli ebrei dispersa in Francia dall'Ira di Dio, augura
Salute". Dopo aver lanciato un anatema a chi avesse osato leggere il libro senza
essere un rabbino od uno scrivano, l'autore continuava spiegando che il volume forniva
agli Ebrei di Francia un mezzo per pagare le tasse all'Impero, perché insegnava come
trasformare in oro i metalli vili. Come scrivano F. si sentì autorizzato a proseguire la
lettura. In anni di paziente lavoro riuscì a tradurre il Libro di Abramo quasi
interamente, ma il punto focale era una pagina fitta di iscrizioni simboliche, che poteva
essere decodificata solo da un ebreo particolarmente versato nella Qabbalah (v.).
Per almeno un decennio F. cercò qualcuno in grado di intrerpretarla. Lo trovò in Spagna,
durante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Era un erudito di nome Canches,
che appena vide le copie delle iscrizioni, scoppiò a piangere commosso: riteneva infatti
che quell'antico libro fosse andato perduto per sempre. Prima di morire, Canches rivelò a
F. il significato della formula misteriosa. Fu così che il fortunato copista fu in grado
di fabbricare la Pietra Filosofale (v.) e di produrre oro su scala quasi
industriale, devolvendo in beneficienza parte della sua magica ricchezza. Per alcuni la
spiegazione della ricchezza di F. sarebbe molto più semplice: non avrebbe trovato un
testo di Alchimia (v.), bensì una mappa che indicava i nascondigli in cui gli Ebrei
avevano nascosto i loro tesori quando vennero cacciati dalla Francia per ordine di Filippo
IV il Bello. Subito dopo la morte di F. (1419) cominciò a circolare un’altra voce.
Lungi dal lasciare questa valle di lacrime, l’alchimista aveva raggiunto la moglie in
Svizzera (Perenelle era morta nel 1397) secondo un piano prestabilito. Nelle loro
tombe fu poi rinvenuto soltanto un pezzo di legno. Tra i segreti del Libro di Abramo si
trovava infatti, anche quello dell’Elisir di lunga vita, in grado di
conferirgli l’Immortalità. Nel corso dei secoli i coniugi F. furono visti
parecchie volte. Qualcuno identificò F. con il Conte di Saint-Germain; nel 1761
altri riconobbero lui e Perenelle all'Opera di Parigi; altri ancora lo incontrarono in
Boulevard du Temple verso la fine del secolo scorso. Per alcuni, infine, il misterioso
Fulcanelli, "il più celebre e senza dubbio il solo vero alchimista di questo
secolo", popolare in Francia durante gli anni ‘20 e ‘30, altri non era
che F. in una delle molte identità che ha adottato negli ultimi cinquecento anni.
Flamel Nicolas: Soprannominato l'Alchimista benefattore. "Quattordici ospedali, tre
cappelle e sette chiese nella città di Parigi, tutte costruite dalle fondamenta ed
arricchite con grandi doni e lasciti; e Boulogne quasi del pari con Parigi, per non
parlare delle beneficienze nei confronti dei poveri, specialmente delle vedove e degli
orfani". Intorno al 1390 era così che Nicolas e Perenelle Flamel raccontavano
come avevano utilizzato parte della loro enorme ricchezza. Il parigino F., grazie
alla sua professione di scrivano e copista, aveva spesso occasione di imbattersi in libri
rari e antichi. Nel 1357 ne aveva acquistato uno fittamente miniato e dalle insolite
dimensioni: "La legatura era in solido ottone, e dentro vi erano figure e
caratteri che non erano né latini né francesi. Era stato scritto con una matita di
piombo, su fogli di corteccia, ed era stranamente colorato". Sulla prima pagina,
in lettere d'oro, compariva la dicitura "Abramo l'Ebreo, Prete, Principe, Levita,
Astrologo e Filosofo, alla nazione degli ebrei dispersa in Francia dall'Ira di Dio, augura
Salute". Dopo aver lanciato un anatema a chi avesse osato leggere il libro senza
essere un rabbino od uno scrivano, l'autore continuava spiegando che il volume forniva
agli Ebrei di Francia un mezzo per pagare le tasse all'Impero, perché insegnava come
trasformare in oro i metalli vili. Come scrivano F. si sentì autorizzato a proseguire la
lettura. In anni di paziente lavoro riuscì a tradurre il Libro di Abramo quasi
interamente, ma il punto focale era una pagina fitta di iscrizioni simboliche, che poteva
essere decodificata solo da un ebreo particolarmente versato nella Qabbalah (v.).
Per almeno un decennio F. cercò qualcuno in grado di intrerpretarla. Lo trovò in Spagna,
durante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Era un erudito di nome Canches,
che appena vide le copie delle iscrizioni, scoppiò a piangere commosso: riteneva infatti
che quell'antico libro fosse andato perduto per sempre. Prima di morire, Canches rivelò a
F. il significato della formula misteriosa. Fu così che il fortunato copista fu in grado
di fabbricare la Pietra Filosofale (v.) e di produrre oro su scala quasi
industriale, devolvendo in beneficienza parte della sua magica ricchezza. Per alcuni la
spiegazione della ricchezza di F. sarebbe molto più semplice: non avrebbe trovato un
testo di Alchimia (v.), bensì una mappa che indicava i nascondigli in cui gli Ebrei
avevano nascosto i loro tesori quando vennero cacciati dalla Francia per ordine di Filippo
IV il Bello. Subito dopo la morte di F. (1419) cominciò a circolare un’altra voce.
Lungi dal lasciare questa valle di lacrime, l’alchimista aveva raggiunto la moglie in
Svizzera (Perenelle era morta nel 1397) secondo un piano prestabilito. Nelle loro
tombe fu poi rinvenuto soltanto un pezzo di legno. Tra i segreti del Libro di Abramo si
trovava infatti, anche quello dell’Elisir di lunga vita, in grado di
conferirgli l’Immortalità. Nel corso dei secoli i coniugi F. furono visti
parecchie volte. Qualcuno identificò F. con il Conte di Saint-Germain; nel 1761
altri riconobbero lui e Perenelle all'Opera di Parigi; altri ancora lo incontrarono in
Boulevard du Temple verso la fine del secolo scorso. Per alcuni, infine, il misterioso
Fulcanelli, "il più celebre e senza dubbio il solo vero alchimista di questo
secolo", popolare in Francia durante gli anni ‘20 e ‘30, altri non era
che F. in una delle molte identità che ha adottato negli ultimi cinquecento anni.
Flamini:
Secondo alcuni studiosi, il termine si richiama al sanscrito Brahman (v.), da cui deriva flameno.
Presso i Romani erano sacerdoti che, dapprima in numero di cinque ed in seguito
di quindici, erano dediti al culto di varie divinità. Istituiti da Numa
Pompilio nei primi anni di Roma, durante le pubbliche cerimonie indossavano un
mantello rosso ed un copricapo a punte. Nei cortei essi precedevano lo stesso Pontifex
Maximus. Il cosiddetto «Flamen dialis»godeva
di prerogative elevatissime, tanto che Plutarco lo definisce «quasi statua sacra vivente».
Flauto Magico: In
originale "die Zauberflöte", è l'ultima
opera teatrale di Wolfgang Amadeus Mozart (v.), e viene comunemente considerata il suo
capolavoro in questo genere. Scritta in due atti su libretto di Emanuele Schikaneder, al
cui teatro era destinata, fu rappresentata a Vienna per la prima volta il 30 settembre
1791, ovvero soltanto due mesi prima dell'improvvisa, prematura e misteriosa morte del
grande musicista massone. Il testo risulta ispirato dalla raccolta di fiabe orientali,
pubblicate dal Wieland nel 1786 sotto il titolo Dschinnistan. Gusto del
soprannaturale e misticismo vi trovano una singolare fusione, rivelando ed esaltando, tra
l'altro, la componente ideologica massonica di entrambi gli autori. La vicenda fiabesca
racconta l'amore del principe Tannino per la figlia della regina della notte, Pamina,
prigioniera del mago Sarastro, che tuttavia benedirà infine le nozze tra i due.
Nell'affascinante storia si inseriscono anche i personaggi di Papageno e Monostato,
delineando l'aspetto più propriamente comico. Ma al di là degli ammirevoli sottintesi
del testo, la musica si esprime con estrema delicatezza, humour e ricchezza di toni,
certamente al livello del miglior Mozart sinfonico.
Fondamentalismo: Movimento sorto nel corso del XIX secolo nell’ambiente religioso, che
sostiene la superiorità di alcuni principi o dogmi fondamentali della fede sugli altri.
Negli Stati Uniti ha caratterizzato i battisti del Sud (Southern Baptist Convention) che
nel 1844-45 si erano separati da quelli del Nord (Northern Baptist Convention) di
tendenze liberali, in seno alla comunità dei battisti (v.). Il F. si attiene ai
cosiddetti fondamentals (fondamentali): fede nei dogmi (v.), nei miracoli (v.) e
nell’inerranza (v.) della Bibbia, della quale veniva considerata l’ispirazione
verbale, al punto da bandire dall’insegnamento le teorie scientifiche non
conciliabili con la "lettera" biblica. Nel mondo islamico è stato
adottato dai fanatici gruppi più integralisti sul piano religioso e politico, che si sono
diffusi soprattutto dopo l’instaurazione della Repubblica islamica in Iran (1979), al
termine della rivoluzione scatenata e capeggiata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini
(1900-1989), vero ispiratore dei fondamentalisti islamici. Tali movimenti
estremisti risultano pressoché incontrollabili da parte delle varie autorità nazionali,
e restano tuttora operativi nel mondo arabo. Non esitano a rivendicare la loro diretta
responsabilità in occasione di clamorosi atti terroristici compiuti "nel nome di
Allah", spesso spinti fino all’eccidio, soprattutto nel continente africano,
talvolta coinvolgendo anche nazioni del mondo occidentale, specie gli Stati Uniti.
Fondamentalisti: Seguaci fanatici del Fondamentalismo (v.).
Fondazione
di una Loggia: La fondazione di una nuova Loggia viene realizzata per volontà di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro. Nell’Oriente ove abbiano sede più Logge, il numero dei Fratelli fondatori è elevato a quindici, di cui almeno sette con il Grado di Maestro (Art. 17 della Costituzione dell’Ordine). La procedura da seguire per la F. è dettagliata negli Artt. 28 e 29 del Regolamento dell’Ordine come segue: Art. 28) I Liberi Muratori, che abbiano i requisiti previsti dall’Art. 17 della Costituzione, e che ravvisino la necessità di fondare una nuova Loggia, debbono riunirsi in Assemblea sotto la presidenza del Fratello più anziano in Grado di Maestro, il quale designa un altro Fratello Maestro alle funzioni di Segretario. Nel verbale dell’Assemblea sono registrate, con l’indicazione delle generalità profane e massoniche di tutti i componenti, le ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia, il titolo distintivo che si intende dare ad essa, la sede ed il Tempio, l’indirizzo profano ed ogni altra eventuale notizia. Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene subito trasmesso a cura del presidente alla Gran Segreteria ed al Collegio Circoscrizionale con la richiesta di Nulla-O. La Gran Segreteria, verificata la regolarità della posizione anagrafica dei singoli Fratelli, richiede al Collegio Circoscrizionale il parere previsto dall’Art. 51 lettera b) della Costituzione. Il Collegio Circoscrizionale esprime parere motivato in merito; Art. 29) La richiesta di Nulla-osta, in tal modo ostruita, viene sottoposta alla delibera della Giunta del G.O.I. Il Presidente dell’Assemblea, ottenuto il Nulla-Osta, convoca tutti i proponenti, comunica loro l’esito della richiesta, e li invita a deliberare l’effettiva fondazione della Loggia. La riunione non è valida se non con la presenza di tutti i proponenti in possesso dei requisiti necessari. Il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti debbono essere rimessi a cura del Presidente alla Gran Segreteria, ove la delibera non intervenga nel termine di novanta giorni dal Nulla-Osta. Della mancata delibera il Presidente dell’Assemblea dà notizia al Collegio Circoscrizionale. Ove l’Assemblea deliberi la fondazione della Loggia, il Presidente chiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli fondatori il benestare preventivo al rilascio dell’exeat. Trasmette quindi alla Grande Segreteria il verbale sottoscritto da tutti i presenti con il benestare delle Logge di appartenenza, e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione (v.). con il numero ed il titolo distintivo, nonché l’autorizzazione ad eleggere il Maestro Venerabile ed i Dignitari. Il Presidente dell’Assemblea, ottenuta la Bolla, richiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli gli exeat prescritti ed i fascicoli personali. I Fratelli Maestri riuniti in Assemblea, sotto la direzione del presidente, procedono all’elezione delle cariche, ed il verbale viene trasmesso alla Gran segreteria. Ottenuto il Nulla-Osta dal Gran Maestro, l’insediamento delle cariche viene effettuato in Tornata rituale presieduta dal Presidente del Collegio Circoscrizionale o da un suo delegato che ricopra od abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile. Le Logge, una volta costituite, possono chiedere alla Giunta del G.O.I. la modifica del loro titolo distintivo ed il trasferimento della sede, allegando copia dell’avviso di convocazione e copia del verbale della seduta di Terzo Grado che ha adottato la delibera, firmato da tutti i Fratelli iscritti nel piè di lista. La Giunta provvede, sentito il parere del Collegio Circoscrizionale.
Fonte della Giovinezza: C'era qualcosa nel Regno di Prete Gianni che valeva più di tutte le sue
ricchezze messe insieme: la Fonte della Giovinezza, le cui acque ridonavano
gioventù e vigore. La fonte era a disposizione di tutti, e lo stesso Prete Gianni (v.) vi
si sarebbe immerso più volte, raggiungendo la rispettabile età di 562 anni. Sir John
Maundeville, autore nel XIV secolo di un popolare resoconto dei suoi incredibili
viaggi (in effetti mai compiuti), la scoprì in Asia, e vi si tuffò
entusiasticamente. La leggendaria sorgente è citata anche in numerose leggende cinesi.
Dovrebbe trovarsi in Cina, presso le montagne K'un Lun nella misteriosa isola di
Ying Chou, oppure da qualche parte in Corea. In una fiaba popolare di quel paese essa
venne scoperta casualmente da due poveri contadini, che bevvero un sorso della sua acqua e
ritornarono immediatamente giovani. Venuto a conoscenza dell'accaduto, un prepotente
signorotto costrinse i due a rivelare l'ubicazione della fonte; ma fu tale la sua avidità
che esagerò poi nel bere e ritornò bambino. Il finale è indicativo della filosofia di
molte religioni orientali, che non precludono una seconda opportunità: il piccolo
venne infatti adottato dai contadini, crebbe insieme a loro, e questa volta diventò un
uomo saggio e stimato. Il primo esploratore che si occupò della F. fu Don Juan Ponce
De Leon, il quale però non andò a cercarla in Asia, bensì nel Nuovo Mondo appena
scoperto. Ponce De Leon era stato accanto a Cristoforo Colombo nel 1493, e aveva raggiunto
con lui l'isola di Hispaniola, l'attuale Haiti. Qui era venuto a sapere dagli indiani che
in un'isola chiamata Bimini (nelle attuali Bahamas) si trovava una fontana
miracolosa in grado di ridonare la gioventù. La sua collocazione non era affatto sicura:
a seconda della tribù si trovava a Bimini, ad Haiti, a Cuba, sulla costa settentrionale
del Sud America, od in Florida; comunque Ponce De Leon partì fiducioso alla sua ricerca.
Tra il 1512 e 1513 si spostò da Portorico alla costa est della Florida, la circumnavigò
quasi completamente, si spinse a sud e raggiunse Cuba, quindi ad est verso le Bahamas, per
poi tornare, sconfitto ma non domo, a Portorico. Ci ritentò nel 1521, ma, sulla costa
della Florida, venne ferito da una tribù di indiani ostili. Quel colpo di freccia gli
costò la vita: Ponce De Leon morì d'infezione a Cuba poche settimane dopo. Molti
cronisti dell'epoca (tra cui Oviedo e Fontaneda) presentarono Ponce De Leon con il
sarcasmo riservato agli ingenui. In realtà questo coraggioso esploratore, anche se non
trovò la F., scoprì il Canale di Bahama (passaggio obbligato tra Cuba e la Spagna per
i futuri navigatori) e diede un notevole contributo alla conoscenza delle tribù
indigene. Sulla sua tomba a Portorico c'è scritto: "Qui giacciono le ossa di un
leone (Leon) le cui gesta furono più grandi del suo nome".
Forma: Apparenza. Modo
particolare di esprimersi con parole, scritti od attività artistica. Modo esteriore di
essere, vivere e di comportarsi. Figura od aspetto esteriore di qualcosa, determinato
dalle linee che ne segnano il contorno o dalla particolare disposizione degli elementi che
la compongono. Y (Massoneria) Secondo la
Tradizione, costituisce F. tutto quanto consente la percezione di un fenomeno osservabile,
esteriore oppure interiore che sia. Perciò la F. mette in contatto l'osservato con
l'osservatore, tramite l'evento dell'osservazione. Ne consegue che la F. può essere
intesa come contenitore di una manifestazione, che però non necessariamente deve essere
considerata solamente fisica. Essendo la percezione dipendente dalla F., si possono
prendere in considerazione i due aspetti, quello di chi osserva e quello del fenomeno
osservato. Mentre la F. del fenomeno è generata dal fenomeno stesso, l'osservatore che
percepisce ha la responsabilità di non deformare quanto percepisce. La Squadra e il
Compasso rappresentano i simboli di una retta e sensibile percezione. Si deve inoltre
tenere presente che, nell'atto dell'osservazione, generiamo comunque una nostra F., che
dipende in parte dalla percezione, ma della quale restiamo unici responsabili.
Forza: Potenza attiva,
capacità di agire indipendente dall'azione e dal fatto. Nel senso di potenza è usato in
filosofia nelle ipotesi metafisiche di un principio profondo della realtà. Si riferisce
anche all'impulso delle passioni e delle emozioni. Nel tempio massonico è rappresentata
da Ercole e, come il filo a piombo, è caratteristica del 2° Sorvegliante,. Ricorda
simbolicamente lo sforzo silenzioso che ogni Apprendista deve compiere per sgrossare la
propria pietra, ovvero per maturare, migliorandosi in ogni manifestazione o pensiero, onde
inserirsi nell'armonioso contesto della Loggia in cui è stato ricevuto ed iniziato.
L'antica Scolastica definiva il coraggio come dono della F. Una facoltà indirizzata a quei mali e pericoli inevitabili, anche per il Massone. È in quei frangenti che l'essere umano dovrà impiegare la virtù della F. verso le azioni che è libero di compiere oppure no. L'uso del coraggio, o F. d'animo, consente la sopportazione del dolore fisico e morale, senza scambi o compensi. Sostituisce però il dolore con la nozione di riposo, di liberazione o di fine combattimento, rappresentando anche un vittoria reale del Massone sulla morte e sul terrore che essa ispira. È l'XI Arcano dei Tarocchi (v.), ov'è palese il significativo riferimento all'irresistibile F. del pensiero, destinata a prevalere su ogni forma di brutalità..
Forze: (G.O.I.) Tutta
la nostra esistenza appare permeata da eventi, che implicano rapporti con forze esteriori
e forze interiori. Il termine Forze viene adoperato in analogia con le forze della
scienza, ma certamente non si possono avere misurazioni esatte di esse. Come tutti i
fenomeni esoterici, le forze sfuggono ad ogni definizione diretta. Tuttavia è evidente la
loro presenza nelle nostre vite e, di conseguenza, la loro influenza sui nostri modi di
essere. Il nostro rapporto con esse può essere passivo od attivo. Prendendo a prestito i
normali concetti della scienza, possiamo assumere che la passività o l'attività
dipendano da differenze di livelli di potenziale fra realtà esteriori e realtà
interiori. Ovviamente si tratta di realtà esistenziali non misurabili. Il rapporto con le
Forze implica una percezione dei nostri rapporti con il mondo che ci circonda. Come tutte
le percezioni si può parlare di chiarezza e di imparzialità nelle valutazioni di tali
percezioni. In un certo senso ogni essere vivente dovrebbe comportarsi, nelle percezioni,
come uno strumento di misura, cioè sensibile, esente da distorsioni e perfettamente
bilanciato. Questo implica un superamento delle passioni derivanti da un ego profano. Il
simbolo associato a tale modo di essere è rappresentato dalla bilancia della virtù,
chiamata "Giustizia".
Fotiniani:
Setta eretica fondata nel IV secolo da Fotino (300-376),
vescovo di Sirmio (l'attuale Mitrovica), in Pannonia. Tale eresia è anche
denominata Monarchismo o Sibellianismo (v.). Sostenevano che Gesù era stato
adottato da Dio per le sue eccezionali qualità; inoltre negavano ogni reale
distinzione delle Persone della SS. Trinità, in quanto il Verbo divino era
soltanto una parte della sostanza divina, e chiamavano Dio con l'appellativo
di «Verbopadre» (logopatora).
Furono condannati per eresia dai Concili di Antiochia (344), di Milano (345) e
di Sirmio (347 e 351), oltre che da papa Damaso (382), che riprese la condanna
definitiva emessa contro questa ed altre sette eretiche nel corso del Concilio
di Costantinopoli del
381.
F.R.A.: Denominazione
della fratellanza (Fraternitas Rosicruciana Antiqua) derivata dall’O.T.O.
(v.). Fu fondata nel 1927 da Arnoldo Krumm-Heller, che ricevette una Patente da Reuss nel
1908. La FRA fu soprattutto attiva in America Latina, ma possedeva anche diramazioni in
Spagna, Germania ed Austria. Quando Krumm-Heller incontrò Crowley e Germer in Germania
nel 1930, alcuni dei rituali ricevettero riferimenti thelemici (Materialien zum O.T.O.,
Ein Leben für die Rose). Nel 1939 Krumm-Heller divenne anche un autentico
vescovo gnostico, ma dopo la sua morte, avvenuta nel 1949, la FRA si frammentò in
innumerevoli gruppuscoli. Nel 1963 Metzger cercò invano, attraverso i suoi contatti in
Venezuela, di riunire tutti questi gruppi sotto la sua autorità. Oggi molti gruppi FRA
sono collegati sia a Metzger che all'O.T.O.
Framassone: Termine
probabilmente derivato da franchezza, che nel Medioevo indicava alcuni gruppi di
maestri di mestiere, oppure da Freestone (pietra tenera), oppure ancora dal
francese antico franchopere (ottima qualità). Secondo il Francovich (Storia
della Massoneria Italiana, Ediz. La Nuova Italia, Firenze, 1974) i termini di "freemasons"
(1376) e di "masonfree" (1381), che ricorrono in vari documenti inglesi
del tempo, originarono poi il termine francese di "francmaçons" nonché
quello italiano di F. o, più correttamente di "Libero Muratore". Tutti
termini derivati dallo spostarsi dei membri delle corporazioni medievali (v. Maestri
Comacini) da una parte all’altra dell’Europa. Tali trasferimenti erano favoriti
anche dal fatto che almeno fin dal XIV secolo le confraternite dell’arte muratoria
avevano ottenuto dalla Chiesa l’affrancamento dai tributi e dalla soggezione alle
autorità locali
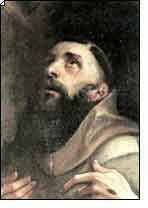 Francescani: Ordine
religioso comprendente i cosiddetti Frati minori, istituito nel 1209 da s. Francesco
d’Assisi (v.). Questi radunò intorno a sé undici compagni, laici come lui, i quali
si proponevano, al di fuori di ogni gerarchia e riconoscendo già alla loro guida
un’autorità puramente morale, di vivere secondo i dettami del vangelo in assoluta
povertà ed umiltà, dedicandosi ai più modesti lavori manuali. Questa prima regola,
molto semplice, venne esposta a papa Innocenzo III, e da questi riconosciuta con non poche
esitazioni e riserve (1210). Una seconda regola venne scritta da s. Francesco intorno al
1221, ma non venne mai applicata. La terza e definitiva regola redatta dal santo è nota
come Regula bullata, perché approvata da papa Onorio III con la bolla del 1223. La
vita dell’ordine fin dall’inizio fu molto contrastata, poiché la sua natura
laica, ponendolo almeno in parte fuori dal controllo della Chiesa, incontrava resistenza e
suscitava preoccupazioni nelle alte gerarchie ecclesiastiche. Tuttavia finché s.
Francesco fu in vita, i Frati minori si mantennero fedeli agli ideali che avevano ispirato
l’azione del fondatore, e che questi peraltro difendeva energicamente da ogni
contaminazione, nutrendola del proprio esempio. Dopo la morte di s. Francesco (1226),
nacquero i primi contrasti interni e, nonostante l’opposizione di alcuni dei più
fedeli discepoli del santo, il partito dei meno intransigenti ebbe temporaneamente
ragione: con la bolla Quo elongati del 1230, papa Gregorio IX venne ad attenuare
alquanto la severità della regola ed i legami al vincolo di povertà. I F., la cui
diffusione era stata nel frattempo assai rapida, cominciarono ad esercitare funzioni, come
la predicazione, l’insegnamento e la lotta contro le eresie, che mal si conciliavano
con la povertà assoluta e l’incertezza dei mezzi di sussistenza proprie di un ordine
mendicante. Nel 1245 una nuova disposizione papale, la bolla Ordinem Vestrum di
Innocenzo IV, provvide ad alleggerire ulteriormente la regola dei Frati minori, che nel
1239 era stato trasformato in ordine clericale. Si accesero perciò sempre più le
polemiche fra le due opposte correnti: quella degli spirituali, assertori della stretta
osservanza della regola francescana, e quella dei conventuali, duramente accusati dai
primi di lassismo morale e di attaccamento ai beni materiali. Le posizioni erano
evidentemente inconciliabili, ed a nulla valsero gli sforzi di s. Bonaventura, generale
dell’ordine nel 1257, per condurre le due parti ad un accordo. E poiché gli
spirituali erano enormemente più rigidi ed i meno disposti al compromesso. La loro
tenacia cominciava a preoccupare seriamente e ad infastidire la Chiesa ufficiale, poiché
li costringeva almeno in parte alla disobbedienza, e fu contro di loro che il papato
lanciò la propria condanna. Nel 1317 una serie di bolle pontificie di Giovanni XXII
invitò severamente gli spirituali a sottomettersi alle decisioni dei loro superiori. Ma
nemmeno questo bastò: spirituali e conventuali vissero da allora in poi come due ordini
distinti, sebbene tale separazione venisse riconosciuta soltanto nel 1517, con la bolla Omnipotens
Deus di Leone X. In tale occasione venne anche riconosciuta la superiorità degli
osservanti (spirituali), ai quali venne affidato il sigillo dell’ordine ed al cui
capo venne conferito il titolo di Ministro generale dei Frati minori. Da questo ramo dei
F. nacque nel 1527 un nuovo ordine, quello dei Frati Cappuccini, separatosi poi nel XVII
secolo. Inoltre esistono altri due ordini F.: il secondo ordine è quello femminile delle
Clarisse, fondato da s. Chiara nel 1212; il terzo è quello dei terziari F., ordine laico
fondato già da s. Francesco nel 1221. Soltanto verso la fine del XIX secolo i vari ordini
F. vennero riuniti da Leone XIII sotto un unico ministro generale. Diffusisi rapidamente
in tutto il mondo, i F. hanno svolto nel corso della loro storia una vasta opera in vari
campi, da quello più strettamente religioso a quello sociale e culturale. Essi
parteciparono sempre largamente all’attività missionaria, portando la predicazione
cristiana nell’area islamica, in Asia, nelle Americhe e, in tempi più recenti, nel
continente africano. Sostennero notevoli sforzi nel campo sociale, fondando ospedali e
brefotrofi, assistendo i malati, prodigandosi in occasione di epidemie e delle guerre.
Svolsero anche opera di insegnamento, aprendo numerose scuole e collegi, e contribuendo
alla diffusione della cultura con numerosi pensatori, filosofi e letterati.
All’ordine F. sono appartenuti i papi Niccolò IV, Sisto V e Clemente XIV, i filosofi
Duns Scoto e Ruggero Bacone, lo scrittore Giacomino da Verona, il già menzionato s.
Bonaventura, s. Antonio da Padova e s. Bernardino da Siena.
Francescani: Ordine
religioso comprendente i cosiddetti Frati minori, istituito nel 1209 da s. Francesco
d’Assisi (v.). Questi radunò intorno a sé undici compagni, laici come lui, i quali
si proponevano, al di fuori di ogni gerarchia e riconoscendo già alla loro guida
un’autorità puramente morale, di vivere secondo i dettami del vangelo in assoluta
povertà ed umiltà, dedicandosi ai più modesti lavori manuali. Questa prima regola,
molto semplice, venne esposta a papa Innocenzo III, e da questi riconosciuta con non poche
esitazioni e riserve (1210). Una seconda regola venne scritta da s. Francesco intorno al
1221, ma non venne mai applicata. La terza e definitiva regola redatta dal santo è nota
come Regula bullata, perché approvata da papa Onorio III con la bolla del 1223. La
vita dell’ordine fin dall’inizio fu molto contrastata, poiché la sua natura
laica, ponendolo almeno in parte fuori dal controllo della Chiesa, incontrava resistenza e
suscitava preoccupazioni nelle alte gerarchie ecclesiastiche. Tuttavia finché s.
Francesco fu in vita, i Frati minori si mantennero fedeli agli ideali che avevano ispirato
l’azione del fondatore, e che questi peraltro difendeva energicamente da ogni
contaminazione, nutrendola del proprio esempio. Dopo la morte di s. Francesco (1226),
nacquero i primi contrasti interni e, nonostante l’opposizione di alcuni dei più
fedeli discepoli del santo, il partito dei meno intransigenti ebbe temporaneamente
ragione: con la bolla Quo elongati del 1230, papa Gregorio IX venne ad attenuare
alquanto la severità della regola ed i legami al vincolo di povertà. I F., la cui
diffusione era stata nel frattempo assai rapida, cominciarono ad esercitare funzioni, come
la predicazione, l’insegnamento e la lotta contro le eresie, che mal si conciliavano
con la povertà assoluta e l’incertezza dei mezzi di sussistenza proprie di un ordine
mendicante. Nel 1245 una nuova disposizione papale, la bolla Ordinem Vestrum di
Innocenzo IV, provvide ad alleggerire ulteriormente la regola dei Frati minori, che nel
1239 era stato trasformato in ordine clericale. Si accesero perciò sempre più le
polemiche fra le due opposte correnti: quella degli spirituali, assertori della stretta
osservanza della regola francescana, e quella dei conventuali, duramente accusati dai
primi di lassismo morale e di attaccamento ai beni materiali. Le posizioni erano
evidentemente inconciliabili, ed a nulla valsero gli sforzi di s. Bonaventura, generale
dell’ordine nel 1257, per condurre le due parti ad un accordo. E poiché gli
spirituali erano enormemente più rigidi ed i meno disposti al compromesso. La loro
tenacia cominciava a preoccupare seriamente e ad infastidire la Chiesa ufficiale, poiché
li costringeva almeno in parte alla disobbedienza, e fu contro di loro che il papato
lanciò la propria condanna. Nel 1317 una serie di bolle pontificie di Giovanni XXII
invitò severamente gli spirituali a sottomettersi alle decisioni dei loro superiori. Ma
nemmeno questo bastò: spirituali e conventuali vissero da allora in poi come due ordini
distinti, sebbene tale separazione venisse riconosciuta soltanto nel 1517, con la bolla Omnipotens
Deus di Leone X. In tale occasione venne anche riconosciuta la superiorità degli
osservanti (spirituali), ai quali venne affidato il sigillo dell’ordine ed al cui
capo venne conferito il titolo di Ministro generale dei Frati minori. Da questo ramo dei
F. nacque nel 1527 un nuovo ordine, quello dei Frati Cappuccini, separatosi poi nel XVII
secolo. Inoltre esistono altri due ordini F.: il secondo ordine è quello femminile delle
Clarisse, fondato da s. Chiara nel 1212; il terzo è quello dei terziari F., ordine laico
fondato già da s. Francesco nel 1221. Soltanto verso la fine del XIX secolo i vari ordini
F. vennero riuniti da Leone XIII sotto un unico ministro generale. Diffusisi rapidamente
in tutto il mondo, i F. hanno svolto nel corso della loro storia una vasta opera in vari
campi, da quello più strettamente religioso a quello sociale e culturale. Essi
parteciparono sempre largamente all’attività missionaria, portando la predicazione
cristiana nell’area islamica, in Asia, nelle Americhe e, in tempi più recenti, nel
continente africano. Sostennero notevoli sforzi nel campo sociale, fondando ospedali e
brefotrofi, assistendo i malati, prodigandosi in occasione di epidemie e delle guerre.
Svolsero anche opera di insegnamento, aprendo numerose scuole e collegi, e contribuendo
alla diffusione della cultura con numerosi pensatori, filosofi e letterati.
All’ordine F. sono appartenuti i papi Niccolò IV, Sisto V e Clemente XIV, i filosofi
Duns Scoto e Ruggero Bacone, lo scrittore Giacomino da Verona, il già menzionato s.
Bonaventura, s. Antonio da Padova e s. Bernardino da Siena.
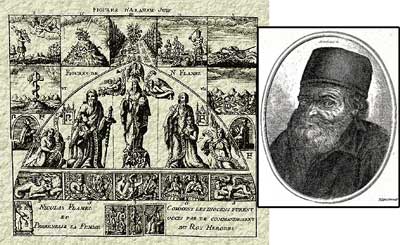 Flamel Nicolas: Soprannominato l'Alchimista benefattore. "Quattordici ospedali, tre
cappelle e sette chiese nella città di Parigi, tutte costruite dalle fondamenta ed
arricchite con grandi doni e lasciti; e Boulogne quasi del pari con Parigi, per non
parlare delle beneficienze nei confronti dei poveri, specialmente delle vedove e degli
orfani". Intorno al 1390 era così che Nicolas e Perenelle Flamel raccontavano
come avevano utilizzato parte della loro enorme ricchezza. Il parigino F., grazie
alla sua professione di scrivano e copista, aveva spesso occasione di imbattersi in libri
rari e antichi. Nel 1357 ne aveva acquistato uno fittamente miniato e dalle insolite
dimensioni: "La legatura era in solido ottone, e dentro vi erano figure e
caratteri che non erano né latini né francesi. Era stato scritto con una matita di
piombo, su fogli di corteccia, ed era stranamente colorato". Sulla prima pagina,
in lettere d'oro, compariva la dicitura "Abramo l'Ebreo, Prete, Principe, Levita,
Astrologo e Filosofo, alla nazione degli ebrei dispersa in Francia dall'Ira di Dio, augura
Salute". Dopo aver lanciato un anatema a chi avesse osato leggere il libro senza
essere un rabbino od uno scrivano, l'autore continuava spiegando che il volume forniva
agli Ebrei di Francia un mezzo per pagare le tasse all'Impero, perché insegnava come
trasformare in oro i metalli vili. Come scrivano F. si sentì autorizzato a proseguire la
lettura. In anni di paziente lavoro riuscì a tradurre il Libro di Abramo quasi
interamente, ma il punto focale era una pagina fitta di iscrizioni simboliche, che poteva
essere decodificata solo da un ebreo particolarmente versato nella Qabbalah (v.).
Per almeno un decennio F. cercò qualcuno in grado di intrerpretarla. Lo trovò in Spagna,
durante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Era un erudito di nome Canches,
che appena vide le copie delle iscrizioni, scoppiò a piangere commosso: riteneva infatti
che quell'antico libro fosse andato perduto per sempre. Prima di morire, Canches rivelò a
F. il significato della formula misteriosa. Fu così che il fortunato copista fu in grado
di fabbricare la Pietra Filosofale (v.) e di produrre oro su scala quasi
industriale, devolvendo in beneficienza parte della sua magica ricchezza. Per alcuni la
spiegazione della ricchezza di F. sarebbe molto più semplice: non avrebbe trovato un
testo di Alchimia (v.), bensì una mappa che indicava i nascondigli in cui gli Ebrei
avevano nascosto i loro tesori quando vennero cacciati dalla Francia per ordine di Filippo
IV il Bello. Subito dopo la morte di F. (1419) cominciò a circolare un’altra voce.
Lungi dal lasciare questa valle di lacrime, l’alchimista aveva raggiunto la moglie in
Svizzera (Perenelle era morta nel 1397) secondo un piano prestabilito. Nelle loro
tombe fu poi rinvenuto soltanto un pezzo di legno. Tra i segreti del Libro di Abramo si
trovava infatti, anche quello dell’Elisir di lunga vita, in grado di
conferirgli l’Immortalità. Nel corso dei secoli i coniugi F. furono visti
parecchie volte. Qualcuno identificò F. con il Conte di Saint-Germain; nel 1761
altri riconobbero lui e Perenelle all'Opera di Parigi; altri ancora lo incontrarono in
Boulevard du Temple verso la fine del secolo scorso. Per alcuni, infine, il misterioso
Fulcanelli, "il più celebre e senza dubbio il solo vero alchimista di questo
secolo", popolare in Francia durante gli anni ‘20 e ‘30, altri non era
che F. in una delle molte identità che ha adottato negli ultimi cinquecento anni.
Flamel Nicolas: Soprannominato l'Alchimista benefattore. "Quattordici ospedali, tre
cappelle e sette chiese nella città di Parigi, tutte costruite dalle fondamenta ed
arricchite con grandi doni e lasciti; e Boulogne quasi del pari con Parigi, per non
parlare delle beneficienze nei confronti dei poveri, specialmente delle vedove e degli
orfani". Intorno al 1390 era così che Nicolas e Perenelle Flamel raccontavano
come avevano utilizzato parte della loro enorme ricchezza. Il parigino F., grazie
alla sua professione di scrivano e copista, aveva spesso occasione di imbattersi in libri
rari e antichi. Nel 1357 ne aveva acquistato uno fittamente miniato e dalle insolite
dimensioni: "La legatura era in solido ottone, e dentro vi erano figure e
caratteri che non erano né latini né francesi. Era stato scritto con una matita di
piombo, su fogli di corteccia, ed era stranamente colorato". Sulla prima pagina,
in lettere d'oro, compariva la dicitura "Abramo l'Ebreo, Prete, Principe, Levita,
Astrologo e Filosofo, alla nazione degli ebrei dispersa in Francia dall'Ira di Dio, augura
Salute". Dopo aver lanciato un anatema a chi avesse osato leggere il libro senza
essere un rabbino od uno scrivano, l'autore continuava spiegando che il volume forniva
agli Ebrei di Francia un mezzo per pagare le tasse all'Impero, perché insegnava come
trasformare in oro i metalli vili. Come scrivano F. si sentì autorizzato a proseguire la
lettura. In anni di paziente lavoro riuscì a tradurre il Libro di Abramo quasi
interamente, ma il punto focale era una pagina fitta di iscrizioni simboliche, che poteva
essere decodificata solo da un ebreo particolarmente versato nella Qabbalah (v.).
Per almeno un decennio F. cercò qualcuno in grado di intrerpretarla. Lo trovò in Spagna,
durante un pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Era un erudito di nome Canches,
che appena vide le copie delle iscrizioni, scoppiò a piangere commosso: riteneva infatti
che quell'antico libro fosse andato perduto per sempre. Prima di morire, Canches rivelò a
F. il significato della formula misteriosa. Fu così che il fortunato copista fu in grado
di fabbricare la Pietra Filosofale (v.) e di produrre oro su scala quasi
industriale, devolvendo in beneficienza parte della sua magica ricchezza. Per alcuni la
spiegazione della ricchezza di F. sarebbe molto più semplice: non avrebbe trovato un
testo di Alchimia (v.), bensì una mappa che indicava i nascondigli in cui gli Ebrei
avevano nascosto i loro tesori quando vennero cacciati dalla Francia per ordine di Filippo
IV il Bello. Subito dopo la morte di F. (1419) cominciò a circolare un’altra voce.
Lungi dal lasciare questa valle di lacrime, l’alchimista aveva raggiunto la moglie in
Svizzera (Perenelle era morta nel 1397) secondo un piano prestabilito. Nelle loro
tombe fu poi rinvenuto soltanto un pezzo di legno. Tra i segreti del Libro di Abramo si
trovava infatti, anche quello dell’Elisir di lunga vita, in grado di
conferirgli l’Immortalità. Nel corso dei secoli i coniugi F. furono visti
parecchie volte. Qualcuno identificò F. con il Conte di Saint-Germain; nel 1761
altri riconobbero lui e Perenelle all'Opera di Parigi; altri ancora lo incontrarono in
Boulevard du Temple verso la fine del secolo scorso. Per alcuni, infine, il misterioso
Fulcanelli, "il più celebre e senza dubbio il solo vero alchimista di questo
secolo", popolare in Francia durante gli anni ‘20 e ‘30, altri non era
che F. in una delle molte identità che ha adottato negli ultimi cinquecento anni.