Demoniaci: Cristiani eretici, i quali ritenevano oche con il Giudizio Universale si
sarebbero salvati tutti gli esseri, anche gli stessi demoni.
Demonismo:
Tipico aspetto delle religioni primitive, per le quali tutti i
fenomeni naturali non sarebbero che la conseguenza di una lotta tra esseri
superiori, divinità demoniache del bene e del male tra loro opposte.
Demonologia: Dottrina
che si interessa delle credenze diffuse in molte religioni verso esseri soprannaturali e
malefici, denominati demoni (v.). È coinvolta anche nella liberazione di individui
posseduti dal demonio, che vengono sottoposti alla pratica dell’esorcismo (v.).
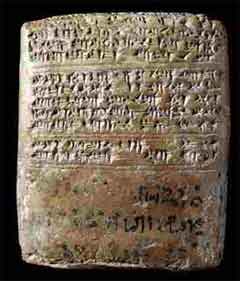 Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in
Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,
documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico
e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali
analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.
Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto
(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette
segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si
conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani
saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.
Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in
Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,
documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico
e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali
analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.
Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto
(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette
segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si
conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani
saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.
Dendrologia: Termine
derivato dal greco dendroz, pianta, e
logoz, studio, quindi studio delle piante. Viene pure usato per
identificare varie manifestazioni religiose e rituali praticate dalle popolazioni
primitive. Nell’antichità erano infatti considerate sacre alcune piante, tra le
quali il sicomoro, il loto, la palma, l’alloro e la quercia. Significativa al
riguardo un’invocazione contenuta nell’Atharva Veda, che recita: "Al
principio dominavano solo le Acque e le Piante del cielo; esse hanno sconfitto il male, ed
hanno dato vita agli uomini. Piante, con i vostri poteri occulti, liberate quest’uomo
dal male e dal peccato. Possano le Piante, con le loro foglie e con i loro fiori,
sottrarmi alla tormentosa inquietudine ed alla morte".
Depennamento:
Provvedimento disciplinare, definito anche decadenza, adottato
nei confronti di un Fratello inadempiente ai suoi doveri nei confronti della Loggia, per
quanto riguarda la frequenza ai Lavori e la puntualità nel pagamento delle capitazioni
(v. Assenza e Morosità – Art, 12 della Costituzione dell’Ordine). Il Consiglio
di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il
fratello a porsi in regola con il Tesoro, ed a riprendere la frequentazione dei lavori.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il Fratello abbia
giustificato il proprio comportamento e sanata l’eventuale morosità, il Consiglio di
Disciplina riferisce alla Loggia in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria di
decadenza da parte della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal
piè di lista di Loggia. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione
all’interessato, al Collegio circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Avverso il
provvedimento, per le sole violazioni procedurali, l’interessato può proporre
reclamo al Tribunale Circoscrizionale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da
inviarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il reclamo
deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni
lamentate. Il reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento (Art. 17 del
Regolamento dell’Ordine). Il Libero Muratore in sonno o depennato non può
frequentare né i lavori della sua Loggia di appartenenza né di alcuna altra Loggia della
Comunione. Egli deve restituire alla Loggia la tessera personale, nonché tutti i
documenti, libri, insegne, fregi di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso
o custodia (Artt. 18 e 24 del Regolamento dell’Ordine). V. Riammissione.
 Desaguliers John Theophilus: Nato in Francia, a La Rochelle, nel 1683, era figlio di un pastore protestante
che due anni dopo dovette lasciare la propria patria in conseguenza della revoca
dell’Editto di Nantes, che aveva garantito una libertà relativa alle comunità
protestanti francesi, a partire dalla fine del XV secolo. Educato nel celebre Christ
Church College di Oxford, il giovane D. ricevette gli ordini sacri della Chiesa
Anglicana nel 1710. Docente di filosofia sperimentale in Hart Hall (Oxford) nello
stesso anno, si distinse negli studi e nelle ricerche maggiormente in voga negli ambienti
scientifici dell’epoca, lasciando numerose pubblicazioni su temi quali la filosofia,
il moto perpetuo, la rifrazione della luce, la resistenza dei fluidi, il vuoto, i
barometri ecc. Nel 1714 fu ammessi alla prestigiosa Royal Society. Nella storia del
pensiero scientifico D. è considerato un rappresentante ed un divulgatore delle posizioni
di Isaac Newton, di cui fu personalmente amico. In campo massonico D. sale vistosamente
alla ribalta nel 1719, quando diventa Gran Maestro della Massoneria inglese, succedendo
alle meno significative figure di Anthony Sayer e George Payne. Egli s’impegna
energicamente nel rafforzamento dell’Ordine, orienta il reclutamento dei nuovi adepti
verso gli ambienti scientifici della Royal Society e verso l’aristocrazia. Sarà lui
stesso ad iniziare, dopo il mandato della Gran Maestranza, il principe Federico del
Galles, di cui fu cappellano nel 1737 e, nel corso di un periplo olandese, il duca Carlo
di Lorena. Nella codificazione dei brindisi conviviali delle logge, rinvigorisce il
lealismo hannoveriano, ed incentiva la solidarietà (il sistema da lui sostenuto costituì
la premessa delle successive charities della Gran Loggia) e la filologia massonica.
Su quest’ultima, è certo che D., Gran Maestro fino al 1721, e poi per tre mandati
successivi Gran Maestro Aggiunto, fu il cervello dell’operazione che condusse
all’innesto nelle Costituzioni del 1723 dell’elemento newtoniano presente nel
linguaggio rituale massonico inglese. Passato all’Oriente Eterno nel 1744, da oltre
250 anni D. campeggia nel pantheon massonico insieme a James Anderson come uno
degli artefici primi, forse il più importante, della Massoneria nella sua forma moderna.
D. è stato oggetto di lodi incondizionate, tanto da parte degli studiosi massoni
ortodossi di scuola inglese, che vedono in lui il prototipo della sobrietà muratoria,
quanto da parte dei massoni liberali od irregolari del Grande Oriente di Francia (v.).
Questi ultimi definiscono D. "le père de la Franc-Maçonnerie liberale",
interpretando a propria legittimazione la tolleranza emanante dai primi documenti
costituzionali della Libera Muratori d’oltremanica.
Desaguliers John Theophilus: Nato in Francia, a La Rochelle, nel 1683, era figlio di un pastore protestante
che due anni dopo dovette lasciare la propria patria in conseguenza della revoca
dell’Editto di Nantes, che aveva garantito una libertà relativa alle comunità
protestanti francesi, a partire dalla fine del XV secolo. Educato nel celebre Christ
Church College di Oxford, il giovane D. ricevette gli ordini sacri della Chiesa
Anglicana nel 1710. Docente di filosofia sperimentale in Hart Hall (Oxford) nello
stesso anno, si distinse negli studi e nelle ricerche maggiormente in voga negli ambienti
scientifici dell’epoca, lasciando numerose pubblicazioni su temi quali la filosofia,
il moto perpetuo, la rifrazione della luce, la resistenza dei fluidi, il vuoto, i
barometri ecc. Nel 1714 fu ammessi alla prestigiosa Royal Society. Nella storia del
pensiero scientifico D. è considerato un rappresentante ed un divulgatore delle posizioni
di Isaac Newton, di cui fu personalmente amico. In campo massonico D. sale vistosamente
alla ribalta nel 1719, quando diventa Gran Maestro della Massoneria inglese, succedendo
alle meno significative figure di Anthony Sayer e George Payne. Egli s’impegna
energicamente nel rafforzamento dell’Ordine, orienta il reclutamento dei nuovi adepti
verso gli ambienti scientifici della Royal Society e verso l’aristocrazia. Sarà lui
stesso ad iniziare, dopo il mandato della Gran Maestranza, il principe Federico del
Galles, di cui fu cappellano nel 1737 e, nel corso di un periplo olandese, il duca Carlo
di Lorena. Nella codificazione dei brindisi conviviali delle logge, rinvigorisce il
lealismo hannoveriano, ed incentiva la solidarietà (il sistema da lui sostenuto costituì
la premessa delle successive charities della Gran Loggia) e la filologia massonica.
Su quest’ultima, è certo che D., Gran Maestro fino al 1721, e poi per tre mandati
successivi Gran Maestro Aggiunto, fu il cervello dell’operazione che condusse
all’innesto nelle Costituzioni del 1723 dell’elemento newtoniano presente nel
linguaggio rituale massonico inglese. Passato all’Oriente Eterno nel 1744, da oltre
250 anni D. campeggia nel pantheon massonico insieme a James Anderson come uno
degli artefici primi, forse il più importante, della Massoneria nella sua forma moderna.
D. è stato oggetto di lodi incondizionate, tanto da parte degli studiosi massoni
ortodossi di scuola inglese, che vedono in lui il prototipo della sobrietà muratoria,
quanto da parte dei massoni liberali od irregolari del Grande Oriente di Francia (v.).
Questi ultimi definiscono D. "le père de la Franc-Maçonnerie liberale",
interpretando a propria legittimazione la tolleranza emanante dai primi documenti
costituzionali della Libera Muratori d’oltremanica.
Descartes René: (lat. Cartesius; it. Cartesio), filosofo, matematico e fisico
francese (La Haye, Turenna 31.3.1596 - Stoccolma 11.2.1650). Fu il fondatore del
razionalismo filosofico moderno, e dell’interpretazione meccanicistica dei fenomeni
naturali: anzi in D. il meccanicismo matematico baconiano e galileiano si trasforma da
presupposto della fisica a principio di interpretazione della realtà naturale. Oltre che
uno dei creatori della fisica matematica, fu l’inventore della geometria analitica,
ed ebbe una parte notevole nella storia dell’ottica, della fisiologia e di altre
discipline scientifiche. Ma fu soprattutto il primo sistematore di una filosofia come
strumento di fondazione necessario della scienza, che con la sua opera egli contribuì a
sottrarre dall’ideale contemplativo tradizionale considerandola, come Galileo e
Huygens, un mezzo per acquistare dominio sulla natura a beneficio dell’umanità.
Questi caratteri fanno di D. uno dei protagonisti, se non il principale protagonista,
della rivoluzione scientifica operatasi nella cultura europea della prima metà del
‘600. Compì gli studi giovanili al collegio di La Flèche, una delle migliori scuole
fondate in Francia dai Gesuiti, dove ricevette una solida istruzione classica orientata
secondo i principi della filosofia scolastica. Dopo aver proseguito gli studi presso
l’università di Poitiers, si arruolò dapprima nelle truppe di Maurizio di Nassau,
poi in quelle dell’elettore di Baviera, che stava allestendo una spedizione contro i
boemi insorti. Durante la sua permanenza militare in Olanda con Maurizio di Nassau, ebbe
una feconda relazione con il fisico Isaac Beeckmann, che fece rinascere in D.
l’interesse per lo studio e per la fisica in particolare. Durante il successivo
soggiorno in Germania, intensificò la vivacità intellettuale ispiratagli da Beeckmann,
conseguendo tra l’altro importanti successi in matematica. Fra il 1619 ed il 1627, D.
visse per lunghi periodi a Parigi, e passò il resto del tempo viaggiando: fu anche in
Italia tra il 1623 ed il 1624. Furono questi anni molto fecondi, durante i quali fu in
contatto con i maggiori scienziati del tempo. Nel 1629 si stabilì in Olanda, ove rimase
fino al 1649. Nel 1633 aveva completato il libro Le Monde ou Traitè de la lumière,
in cui presentava parti del suo sistema di fisica, ed i risultati delle sue ricerche di
fisiologia e di embriologia, in una sorta di appendice al trattato precedente, intitolato De
l’homme. Poco dopo la pubblicazione del libro, D. seppe che la Chiesa cattolica
aveva duramente condannato Galileo per aver sostenuto l’ipotesi autonomica
copernicana. Poiché la teoria astronomica sviluppata in Le Monde era solo quella
copernicana, D. soppresse il libro, che riapparve solo nel 1644. Tuttavia la prima opera
importante risaliva al 1628-29, dal titolo Regulae ad directionem ingenii, mai
condotta a termine, e pubblicata postuma solo nel 1701. Dunque D. ritiuta lo scontro con
l’inquisizione cattolica, e cerca di dare alla propria ricerca della verità una
forma più accettabile ai teologi: questo tuttavia non impedì che l’università di
Utrecht, per bocca dei suoi teologi, lo attaccasse aspramente. Nel 1637, non rinunciando a
divulgare l’esito delle proprie ricerche, D. pubblicò anonimamente tre Essais dedicati
ai risultati dei suoi studi di ottica, di meteorologia e di geometria: Dioptrique,
Métàores e Geometrie, che furono preceduti dal Discours de la méthode, non
solo uno dei classici della letteratura filosofica, ma un classico della letteratura
francese. Il Discours contiene una autobiografia intellettuale, brani di
metodologia e di metafisica, considerazioni su alcune scoperte scientifiche (tra cui
quella di Harvey sulla circolazione del sangue), ed una discussione sulle condizioni e le
prospettive dei futuri progressi delle scienze. Malgrado il titolo, il libro non dà una
relazione dettagliata del metodo cartesiano quale si trova invece nelle Regulae, il
solo sostanziale lavoro di metodologia. Nel 1641 vengono pubblicate le Meditationes de
prima philosophia, composte nel 1629-30, ripubblicate in francese con il titolo Méditationes
métaphysiques nel 1647, in un’edizione comprendente le obiezioni dei lettori e
le risposte dell’autore: D. dedicò le Méditationes alle autorità teologiche
francesi. Nel 1644 pubblicò in latino una relazione completa in quattro libri delle sue
idee filosofiche e scientifiche, con il titolo Principia philosophiae, che fu usato
come testo scolastico. Anche la Chiesa romana poneva all’indice la maggior parte
delle opere di D. L’ultima grande sua opera fu il Traité des passions de
l’ame (1649). In questo periodo D. accetta l’invito della regina Cristina di
Svezia di recarsi a Stoccolma per insegnarle personalmente la propria filosofia: il rigido
clima svedese accelerò la fine del già sofferente pensatore. Il Discorso sul metodo è
il programma del razionalismo moderno. Per D. il procedimento matematico è la forma
tipica della conoscenza; due sono le operazioni fondamentali del pensiero matematico:
intuizione e deduzione, che sono per D. le operazioni della scienza universale; si
tratterà quindi di trovare nella ragione un principio assolutamente primo, che dia alla
conoscenza umana nella sua totalità l’intrinseca unità organica ed il rigore
luminoso della deduzione matematica: un principio che possa al tempo stesso giustificare
la validità dell’interpretazione meccanica della natura, resa possibile dalla
matematica, ed insieme limitarne la portata e l’estensione, escludendone la realtà
spirituale. Per stabilire il fondamento della certezza dei principi della conoscenza D.,
nel Discorso sul metodo come nelle Méditationes, muove dal dubbio
universale, dalla supposizione, cioè, che non soltanto i sensi, ma la stessa ragione ci
ingannino costantemente, e che persino l’evidenza matematica sia fallace. È proprio
in questo stesso dubbio che si riafferma la certezza del mio io: se mi inganno e dubito,
penso; se penso, sono, poiché nel mio pensare intuisco immediatamente la natura del mio
essere. Discende da qui un criterio generale di certezza: è vero ciò che ci si presenta
così chiaro e distinto come la coscienza dell’io. Per uscire dal cerchio della
propria coscienza, che esprime la coincidenza di pensiero ed essere, si deve scoprire
qualcosa che sia diverso dall’io. D. trova che l’io scopre a questo punto in sé
stesso l’idea di Dio, cui è legata l’esistenza di Dio, perché l’essere
assolutamente perfetto non può mancare di quella perfezione che è l’esistenza; e
poiché Dio non può non essere verace, io acquisto la massima certezza che la legge del
mio pensiero è la legge generale dell’universo, e che tutto ciò che mi si presenta
chiaro e distinto è vero, di verità eterna ed universale. In tal senso d. pone la
veracità divina a garanzia della validità del criterio della chiarezza e distinzione,
che ispira la nostra conoscenza basata sulle idee innate, come quella dell’io.
L’universo cartesiano comprende Dio, come sostanza pensante, e gli io finiti, essi
pure sostanze pensanti. La sostanza spirituale dunque è una res cogitans, accanto
alla quale D. ammette il mondo delle sostanze corporee, il cui attributo è
l’estensione (res extensa): la materia si riduce a spazialità. Solo le
modalità dell’estensione, figura e movimento, danno luogo ad idee chiare e distinte,
alle idee cioè delle qualità primarie dei corpi, mentre le qualità sensibili o
secondarie sono esclusivamente soggettive: ecco perché solo la matematica dà una
conoscenza obiettiva della natura, che va letta nelle sue proprietà geometriche. La
geometria analitica è quindi una delle prime applicazioni essenzialmente scientifiche del
metodo cartesiano. D. introduce l’uso sistematico degli assi coordinati (cartesiani),
che permettono di rappresentare i punti con coppie o terne di numeri, e le relazioni
geometriche fra punti con relazioni algebriche. In tal modo i problemi geometrici possono
essere risolti con le regole automatiche dell’algebra. Fra i risultati più
importanti ottenuti da D. con il procedimento della geometria analitica ricordiamo la
determinazione generale della normale a qualsiasi curva algebrica piana, in un suo punto
qualunque, e la determinazione della tangente. Il fondamento ultimo della fisica e della
biologia di D. risiede nella tesi filosofica generale che il mondo della natura è
assolutamente distinto da quello dello spirito, ed è costituito unicamente di materia
estesa. Tutti i fenomeni naturali dovranno perciò essere spiegabili facendo riferimento
alla materia ed ai suoi movimenti. La spiegazione cartesiana discende quindi
dall’elaborazione di modelli teorici sulla base di elementi meccanici e geometrici,
capaci di riprodurre i fenomeni del mondo reale (v. Meccanicismo). In particolare, la
fisica cartesiana si fondava essenzialmente su due principi: il primo, della negazione
dell’esistenza del vuoto, era una conseguenza della concezione dell’estensione
come attributo della sostanza corporea; il secondo è invece quello della conservazione
della quantità di moto di due corpi che si urtano, cioè la quantità di moto risultante
del loro sistema. D. giunge ad affermare che in tutte le trasformazioni
dell’universo, la quantità di moto complessiva rimane costante: ritiene anzi che
questo rientrerebbe nella concezione cristiana del mondo come creatura di Dio: come se
Egli, nel creare il mondo, vi avesse impresso una quantità di moto destinata a rimanere,
in valore globale, immutata nel tempo. Sulla base di questi due principi, D. formulò la
sua celebre teoria dei vortici, per la quale i pianeti ruotano come in un vortice attorno
ad un vortice più grande, che è il sole: gli stessi corpi terrestri sono da essa
attratti da un vortice. La teoria dei vortici, di cui Newton dimostrerà
l’infondatezza, fu una fondamentale ipotesi scientifica, capace di unificare in un
solo meccanismo noto tutti i fenomeni universali. Tra le ricerche particolari del grande
scienziato e filosofo francese, ricordiamo la scoperta delle leggi di rifrazione della
luce, con le quali e con le leggi della riflessione poté dare un’esatta spiegazione
scientifica del fenomeno dell’arcobaleno. La biologia cartesiana fa parte della
fisica: è infatti nota la teoria degli animali macchina. D. si occupò soprattutto di
fisiologia, alla quale diede un contributo sistematico molto importante. Si oppose infatti
decisamente ad ogni forma di finalismo aristotelico ed alla fisiologia galenica, che era
stata molto in auge nel ‘500. Dall’indirizzo iatro-chimico D. mediò il
principio fisiologico generale della fermentazione. Per quanto riguarda il corpo umano,
esso funziona in base a principi meccanici che regolano i movimenti e le funzioni degli
organi, su cui l’anima può agire in base ai legami che essi hanno con la ghiandola
pineale (ipofisi), dove si verifica il contatto tra l’anima ed il corpo.
Desheret: Nome egizio con il quale si identificava la corona rossa del Basso Egitto,
rappresentata nelle raffigurazioni della dea Neith. Presentava una appendice verticale
nella parte posteriore, alla cui base si dipartiva una lista metallica terminante a
spirale nella parte anteriore (v. Corona Egizia).
Destino: Nel linguaggio
comune il termine definisce l’insieme imponderabile delle cause che si pensa abbiano
determinato, o stiano per determinare, eventi decisivi ed immutabili. Leibniz nella Teodicea
contrappone al concetto maomettano di Fato (v.) quello di D.: mentre il Fato considera gli
eventi futuri come indipendenti dalla volontà umana, il D. è legato alla provvidenza, ed
ammette l’iniziativa o l’intervento dell’essere umano. Il Fato è
casualità impersonale, diversamente dal D. che è nozione che si applica al singolo
individuo. In tal senso la dottrina della predestinazione teologica rientra nel fatalismo,
in quanto esclude l’iniziativa umana. Nell’esistenzialismo il D. è
l’autoprogettazione che si basa sulla temporalità: l’essere storico nel
fondamento della sua esistenza equivale all’esistere nel mondo del D., come afferma
Heidegger in Essere e tempo. Il D. va anche distinto dal caso, definito come
assenza totale di leggi, per cui esso può essere causalità (v. karma) ma non casualità.
Determinismo: Teoria
della necessità causale che si applica tanto in senso scientifico che filosofico. Il D.
scientifico o fisico od anche sperimentale, parte dal presupposto che i fenomeni naturali
siano legati tra loro da nessi necessari di causa ed effetto, e stabilisce di conseguenza
delle leggi di natura in grado anche di guidare l’azione futura dell’uomo. In
senso filosofico, cioè come modello di spiegazione della realtà nel suo complesso, il D.
si è rifatto per un verso al principio di razionalità interna del mondo, e per
l’altro verso ad un modello meccanico. A parte il D. teologico, che fa dipendere
l’assoluta necessità degli eventi mondani dalla prescienza divina (in particolare la
teologia protestante di Lutero e Barth), il D. razionalistico è in generale
immanentistico: esso può partire dalla contingenza del mondo, ma attraverso la ragion
sufficiente stabilire che il nostro è il migliore dei possibili mondi (Leibniz); oppure
scartare la contingenza e considerare il mondo come determinato dalla necessità della
natura divina, che lo fa essere e muovere in un certo modo (Spinoza); oppure ancora, come
nell’idealismo hegeliano, ritenere i singoli fatti accidentali rispetto ad un piano
razionale immanente, e necessariamente sviluppantesi in direzione dell’autocoscienza
assoluta. Secondo questa ultima caratterizzazione la storia, mediante l’astuzia della
ragione, persegue autonomamente il cammino della libertà. Il marxismo rovescia
l’astuzia della ragione nella concreta lotta di classe, rinviando quindi
all’iniziativa rivoluzionaria la possibile realizzazione della libertà: tuttavia,
nelle forme più dogmatiche, anche il marxismo assume un carattere deterministico, facendo
dipendere dal piano economico gli altri piani, e considerando il piano economico come
autonomo dall’intervento umano. L’altra linea secondo cui si sviluppa il D. è
quella meccanicistica, che si basa sulla semplice causalità meccanica rifiutando ogni
teologia; esso coincide quasi completamente con lo svolgimento del materialismo, dalla
teoria atomistica di Leucippo e Democrito fino al meccanicismo (v.) vero e proprio del
Seicento annunciato da Cartesio (v.). Hobbes fa dipendere l’ordine psichico
dall’ordine fisico, nella prospettiva del monismo (v.) corporeo. Nel Settecento il
meccanicismo ha le sue affermazioni più drastiche nei pensatori materialisti francesi,
come Lamettrie e Holbach. Kant (v.) accetta la necessaria connessione dei fenomeni, ma vi
contrappone la libertà della ragione pratica. La ripresa del D. di natura meccanicistica
si ha con il positivismo francese ed inglese (cui reagisce il contingentismo): per Comte
il carattere principale della filosofia positiva consiste nel fatto che tutte le cose
siano soggette a leggi di natura invariabile, mentre Spencer sviluppa un modello monistico
basato sul concetto di evoluzione. Influenze positivistiche sono presenti anche nel
marxismo, ed in particolare bella dialettica della natura di Engels. Il D. è stato
oggetto di netto rifiuto da parte dello scienziato e filosofo Ilya Prigogine (v.), premio
Nobel per la chimica del 1977, che attraverso le sue recenti ricerche, tuttora in corso,
tende a dimostrare la validità di un nuovo concetto romantico della natura, quello
dell’Ordine galleggiante nel Disordine.
Deucalione: Personaggio
della mitologia greca, figlio di Prometeo, sopravvissuto insieme con la moglie Pirra al
diluvio provocato da Zeus per punire le scelleratezze degli uomini. Approdati con
l’arca in vetta al Parnaso, seguendo i suggerimenti di un oracolo, D. e Pirra
ripopolarono la terra gettandosi dietro le spalle delle pietre che si trasformavano in
esseri umani. Il mito di D. possiede impressionanti analogie con i più antichi miti
assiro babilonesi ed ebraici riferiti al diluvio universale (v.).
Deuteronomio: Dal
greco deuteroz, secondo, e nomoz,
legge. Nome dell’ultimo libro del Pentateuco (v.), attribuito a Mosé; ritrovato
forse nel tempio di Gerusalemme durante il regno di Giosia (622 a.C. – 2 Re 22-23).
Comprende quattro discorsi di Mosè, di cui il secondo (4, 26-44) include: decalogo,
professione di fede monoteistica, guerra all’idolatria, leggi religiose e di diritto
pubblico e privato. Seguono: cantico di Mosé, benedizione delle dodici tribù e morte di
Mosé. Per quanto riguarda la dottrina, vi si tratta la relazione tra Yahweh ed Israele
(elezione divina ed amore reciproco) e la centralizzazione del culto. Per quanto riguarda
la sua redazione, la critica moderna la colloca alla fine del VII secolo a.C.,
riconoscendo un nucleo più antico, forse proprio mosaico, ed un materiale posteriore
proveniente dal regno del Nord verso la fine dell’VIII secolo a.C., in cui si
noterebbe l’influenza del profeta Osea.
Dharana:
Pratica dello Yoga (v.), consistente nel concentrare la mente
su un unico punto, in modo da liberarla da qualsiasi distrazione, da ogni
pensiero, predisponendola così alla meditazione (v.).
Dharma: Dal sanscrito dhr,
fissare, e dal pali dhamma, definisce il complesso delle prescrizioni morali,
religiose e legali che costituiscono il codice della disciplina cui doveva attenersi il
fedele del brahmanesimo (indù). Nella metafisica buddhista il D. comprende le forze
ultime (facoltà sensoriali, vizi, virtù, forza vitale, ecc.), e non ulteriormente
riducibili, in cui tutta la realtà si risolve, e che nascono e muoiono in funzionale
dipendenza reciproca: forme fenomeniche della legge universale.
Dhyana: Termine
sanscrito indicante i diversi atteggiamenti di concentrazione mentale che, attraverso un
continuo processo di meditazione e di arsione di quanto tende ad ostacolare l’ascesi
spirituale, rendono possibile la liberazione definitiva. L’ultimo stadio di tale
processo, che prelude al Nirvana (v.), assume il nome di "Dhyana arupico".
In esso avviene il superamento del conscio e dell’inconscio. Corrisponde al termine
giapponese Zen (v.).
Diacono: Termine
derivato dal greco diaconoz, inserviente, attribuito al
ministro che nel rito cattolico esercita funzioni di assistenza al sacerdote nelle
funzioni del culto. Nel senso attuale è affermato per la prima volta in s. Paolo (Filippesi
1, 1; I Timoteo 3, 8-12). Nella chiesa cattolica attuale il diaconato è il secondo
degli Ordini maggiori. L’ordinazione viene fatta dal vescovo attraverso
l’imposizione delle mani. Il D. è autorizzato ad amministrare il battesimo solenne
ed alla predicazione, previa licenza del superiore competente. Le insegne liturgiche del
D. sono la stola (a tracolla) e la dalmatica. Y (Massoneria)
Il Primo ed il Secondo D. assistono rispettivamente il Maestro Venerabile ed il Primo
Sorvegliante durante i Lavori di Loggia (Art. 41 del Regolamento dell’Ordine). Sono
detti D. i due ufficiali di Loggia che, nel rituale Simbolico, prendono posto alla destra
del Maestro Venerabile (Primo D.) ed alla destra del Primo Sorvegliante (Secondo D.).
Entrambi i D. sono muniti di una Verga (v.) o Misura, ovvero di un’asta lunga 24
pollici, che ricorda il caduceo, attributo di Hermes, il messaggero degli dei. Come
gioiello distintivo della carica, indossano il simbolo della colomba di Noé che tiene nel
becco un ramoscello d’ulivo (v. Olivo). IL Powell, nella sua "La Magia della
Framassoneria", sostiene che "i doveri del Primo e del Secondo D., quali
vengono rivelati dalle loro incisive risposte, rivestono enorme valore psicologico. Il
Primo D. rappresenta l’attivo, razionale intelletto, la normale coscienza di veglia,
e trasmette messaggi ed ordini dalla Saggezza al Volere. Quest’ultimo, rappresentato
dal Primo Sorvegliante (v.), provvede affinché la forza messa in movimento, esegua
il Lavoro e stimoli il suo messaggero, il Secondo D., o desiderio, che a sua volta
riferisce l’ordine al Secondo Sorvegliante (v.), la mente creativa, che riceve
così i piani per eseguire il compito. Il dovere che il Secondo D. ha di osservare che gli
ordini siano puntualmente rispettati, si riferisce al fatto che il desiderio sia
insistente e resti inattivo, fino a quando la mente non ne afferri le redini, e formuli
dei piani precisi da realizzare. Così pure la Mente inferiore, la ragione rappresentata
dal Primo D., aspetta il ritorno del Secondo D., ovvero la normale coscienza di veglia
resta in uno stadio passivo finché il desiderio non abbia eseguito quanto si propone, nel
modo più pieno". Nel rituale Emulation, pur restando invariata la posizione dei
due D. (che però non portano la misura), cambiano invece i compiti loro affidati.
All’apertura dei Lavori, il primo D. provvede all’accensione della luce del
Maestro Venerabile, passa poi il testimone al Secondo D. che, seguito dal primo D.,
provvede all’accensione delle luci del Secondo e del Primo Sorvegliante. Mentre il
primo D. riprende il suo posto, il secondo D. spegne il testimone e, prima di riprendere
il proprio posto, si ferma davanti all’Ara, saluta il Maestro Venerabile, e scopre il
Quadro di Loggia. Infine, risalutato il M.V., riprende il proprio posto. Nel corso della
cerimonia di chiusura dei Lavori, il Secondo D. provvede infine alla copertura del Quadro
di Loggia.
Diameter
Spherae Thau Circuli Crux orbis non orbis prosunt: Espressione
alchemica dal significato "il diametro della sfera, il tau del circolo (v.
cerchio) e la croce (v.) dell’orbita non giovano ai ciechi". Pone
in evidenza il fatto che le discipline esoteriche non possono essere accessibili ai
profani.
Dianetics: Termine
derivato dal greco dia, attraverso, e nous, anima. Fino all’anno 1950, il pensiero scientifico predominante aveva stabilito che la mente dell'Uomo fosse il suo cervello, cioè nient'altro che un insieme di cellule e di neuroni. Inoltre considerava che il quoziente d'intelligenza non fosse migliorabile, e che la personalità di un individuo fosse determinata dalla conformazione della sua corteccia cerebrale. Queste teorie erano comunque inesatte e di conseguenza la scienza non ha mai sviluppato un sistema teorico che realmente consentisse di risolvere i problemi della mente. 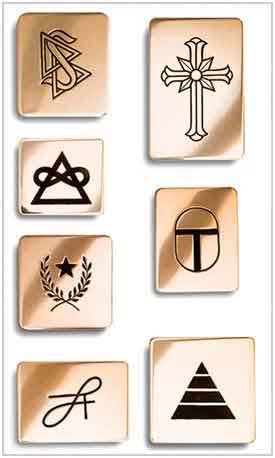 Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa
situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo
per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad
alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e
le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).
Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo
attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali
facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi
oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è
stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico
dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi
prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza
infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,
del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe
infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro
azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:
sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui
proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato
il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività
di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.
Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come
parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni
manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra
vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in
grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,
maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che
non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,
insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben
distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui
siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva
i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che
contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere
decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo
apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la
sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene
sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un
individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece
l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva
s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata
dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione
chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.
Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le
percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla
persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri
depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e
fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di
un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che
succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un
uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.
Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono
registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento
di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno
schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è
una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,
c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una
registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente
reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.
L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito
dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello
schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale
al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una
buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce
dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde
uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui
il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere
volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra
percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna
conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei
subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei
udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito
(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,
lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le
parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna
potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea
continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se
restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,
in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.
Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.
La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:
benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è
peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in
pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona
paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di
cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel
portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di
ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:
lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che
si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti
negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,
possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e
falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una
volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste
caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con
la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni
dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza
personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la
mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno
successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente
desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le
persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle
scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno
stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle
caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non
hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità
umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali
malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad
un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente
stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno
soggetto agli incidenti; · più sano; ·
capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire
rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la
vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze
altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i
problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale
troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere
pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a
brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le
testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano
tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai
cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un
incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il
recupero del piacere della vita individuale e sociale.
Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa
situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo
per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad
alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e
le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).
Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo
attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali
facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi
oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è
stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico
dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi
prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza
infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,
del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe
infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro
azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:
sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui
proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato
il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività
di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.
Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come
parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni
manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra
vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in
grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,
maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che
non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,
insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben
distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui
siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva
i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che
contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere
decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo
apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la
sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene
sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un
individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece
l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva
s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata
dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione
chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.
Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le
percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla
persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri
depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e
fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di
un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che
succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un
uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.
Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono
registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento
di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno
schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è
una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,
c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una
registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente
reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.
L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito
dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello
schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale
al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una
buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce
dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde
uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui
il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere
volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra
percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna
conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei
subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei
udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito
(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,
lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le
parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna
potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea
continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se
restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,
in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.
Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.
La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:
benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è
peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in
pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona
paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di
cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel
portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di
ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:
lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che
si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti
negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,
possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e
falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una
volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste
caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con
la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni
dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza
personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la
mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno
successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente
desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le
persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle
scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno
stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle
caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non
hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità
umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali
malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad
un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente
stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno
soggetto agli incidenti; · più sano; ·
capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire
rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la
vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze
altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i
problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale
troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere
pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a
brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le
testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano
tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai
cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un
incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il
recupero del piacere della vita individuale e sociale.
Diaspora: Termine
derivato dal greco diaspora, dispersione, non corrispondente
quindi all’ebraico gälut, esilio a carattere temporaneo. Indica la
dispersione iniziata tra gli Ebrei con le deportazioni in Assiria (722 a.C.), riprese dopo
la distruzione di Gerusalemme e del Tempio (586 a.C.), formando fiorenti colonie in
Babilonia, Egitto (Elefantina, Alessandria), Siria (Antiochia) e poi (I secolo a.C.) a
Roma e nell’impero romano. Con la seconda distruzione del Tempio (Tito, 70 d.C.) e
quella di Gerusalemme (Adriano, 135 d.C.), la D. ebraica assume necessariamente maggiori
dimensioni, diffondendosi ovunque e proseguendo nei secoli fino ai nostri giorni. La sua
storia coincide con quella del popolo ebraico.
Diavolo: Termine
derivato dal greco diaboloz, calunniatore, che nella volgata
traduce l’ebraico has-satan (v. Satana), cioè il capo degli angeli decaduti
che fomenta il male e la perdizione. Il demonologo rinascimentale Johann Weyer li ha
minuziosamente classificati nel suo De praestigiis daemonum (1568), sostenendo che
sono 44.435.556, mentre Gregorio da Nizza sostiene che siano molti di più, poiché si
moltiplicano tra loro come gli uomini. Per Esiodo essi vivono 686.400 anni, per Plutarco solo
9.720, mentre altri ancora li ritengono immortali. La figura del D. è stata rilanciata da
papa Giovanni Paolo II il 5 maggio 1979, quando ha messo in guardia i fedeli contro il
"suggeritore di ogni insidia, il maligno, da sempre impegnato nello
spegnere nel cuore di ogni uomo la luce della speranza nella vittoriosa affermazione di
Cristo", tornando poi altre volte sull’argomento. Fenomeno particolare è
rappresentato dal satanismo, che vede sette attive dedite anche all’omicidio rituale
ed a vari reati, mentre ben tre ditte sono specializzate nella fornitura contrassegno di
oggetti per celebrare le messe nere. Il D. è presente in due momenti cruciali della
Bibbia: la tentazione di Eva nel Paradiso Terrestre, e la tentazione di Gesù sul monte
degli Ulivi, poco prima dell’avvio della Passione. Nell’iconografia, le prime
raffigurazioni del D. risalgono al VI secolo, ma fu nel XII che ne fu messa in rilievo la
mostruosità fisica. In genere viene rappresentato nell’ambito del giudizio
universale, attraverso l’esaltazione della sua sconfitta ad opera delle forze del
bene. Soprattutto al Nord venne sottolineato il carattere grottesco e laido del D,
specialmente nel tema delle tentazioni di Sant’Antonio abate.
Diciannove:
Nell'esoterismo il numero rappresenta la Luce. Secondo
Eliphas Levi, è l'esistenza di Dio provata dalla stessa idea di Dio. Occorre
dire che l'Essere supremo ed immenso è una tomba universale dove si muove ed
opera, con moto automatico, una forza comunque morta e cadaverica, oppure
bisogna ammettere il principio assoluto dell'intelligenza e della vita.
Diciassette:
Nell'esoterismo
il numero rappresenta le stelle, l'intelligenza e l'amore (E. Levi). Ha un
notevole valore simbolico, come il 72 con cui è in stretto rapporto. Per gli
antichi Romani si trattava di un numero iellato, apportatore di sventure, specie
perché anagrammato (da XVII a VIXI) produce la parola «vixi»,
ovvero vissi, quindi sono già morto.
Diciotto
Benedizioni:
Nella
religione ebraica l'espressione identifica la più importante preghiera
quotidiana. Essa viene recitata in piedi, e risale all'epoca precristiana.
Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani (70 d.C.), fu
integrata da numerose aggiunte.
Diciotto:
Nell'esoterismo
il numero rappresenta il dogma religioso, interamente poesia e mistero (E.
Levi).
Dictatus
Papae:
Particolare
documento redatto ed emesso da papa Gregorio VII nel 1075. Si compone di 27
clausole, nelle quali viene solennemente affermata la supremazia assoluta papale
su tutte le gerarchie ecclesiastiche, nonché il diritto del pontefice a
riconoscere od a deporre gli stessi imperatori. Secondo il Morghen (Medioevo
cristiano, Ediz. Laterza, 1960), «Il D. è senza dubbio la Magna
Charta del Cattolicesimo romano e, nel contempo, del Papato politico e della
concezione teocratica (v.). All'ideale della fuga dal mondo, che era stato l'assillo e l'aspirazione suprema
dell'intero ascetismo medievale, il pontefice aveva sostituito l'altro, del dominio
del mondo, mentre l'impalpabile realtà spirituale della Chiesa, che tutto
il medioevo aveva identificata con l'agostiniana Città
di Dio, doveva tramutarsi nella coscienza della nuova potenza conseguita
dalla Chiesa stessa, con le sue collezioni canoniche ed i suoi tribunali
supremi, con l'esclusività del suo magistero e con il temporalismo ed i suoi
prevalenti interessi politici».
Dieci: Numero
simboleggiante la perfezione, come anche l’annullamento di tutte le cose. Corrisponde
alla Tetraktys (v.) pitagorica, che insieme al sette lo considerava il numero più
importante, in quanto è formato dalla somma delle prime quattro cifre (1+2+3+4=10). Al
riguardo occorre annotare che la Tetraktys è oggetto di attenzione rituale nella Camera
dei Maestri Architetti del Rito Simbolico Italiano (v.). Secondo il Troisi (Vocabolario
Massonico) esso è divino poiché perfetto, in quanto riunisce in una nuova unità
tutti i principi espressi nei numeri dall’uno al nove. In Massoneria è considerato
il segno dell’Unione, e si estrinseca nella presa da Maestro, attraverso la
congiunzione delle due mani, ovvero di dieci dita. Il numero dieci è anche denominato
Cielo, ad indicare sia la perfezione che il dissolvimento di tutte le cose, per il fatto
che contiene tutte le possibili relazioni numeriche. Secondo il Moramarco, la comparazione
delle simbologie numerica e geometrica fa scoprire un’analogia tra il D. ed il Punto
entro il Cerchio del grado di Maestro nella tradizione anglosassone: Lo si deduce dal
fatto che nella Tradizione il valore numerico di un Centro o Punto è uno, mentre quello
di una circonferenza è nove, numero che moltiplicato per qualsiasi altro dà, per
addizione delle cifre costituenti il risultato, sempre e soltanto sé stesso, esattamente
come una circonferenza perpetuamente ritornante sul proprio tracciato. Tale simbologia
suggerisce l’ipotesi che la Decade rappresenti la perfezione relativa allo
spazio-tempo circolare, ovvero la divina immanenza.
Dignitari del
Grande Oriente d’Italia: (G.O.I.) Sono D. e
membri della Giunta (v.) del Grande Oriente d’Italia il Gran Maestro (v.), il Primo
Gran Sorvegliante, il Secondo Gran Sorvegliante, il Grande Oratore, il Gran Tesoriere ed
il Gran Segretario. Possono essere eletti membri effettivi di Giunta i fratelli che
abbiano non meno di sette anni di anzianità nel grado di Maestro, e che abbiano rivestito
la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. L’elezione avviene con le stesse
modalità previste per l’elezione del Gran Maestro (Art. 35 della Costituzione
dell’Ordine). Il Gran Maestro può, su parere conforme della Giunta, sostituire il
Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della sostituzione, abbia rivestito la
carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. In caso di impedimento permanente,
dimissioni o passaggio all’Oriente Eterno di un membro effettivo di Giunta, il Gran
Maestro, con parere favorevole della Giunta, provvede alla sostituzione nominando un altro
Fratello che abbia i requisiti prescritti, scegliendolo in una terna di nominativi
proposta dal Consiglio dell’Ordine. Tale nomina è soggetta alla ratifica da parte
della Gran Loggia, in occasione della prima tornata ordinaria successiva (Art. 36 della
Costituzione dell’Ordine). Le elezioni dei Dignitari del Grande Oriente d’Italia
sono regolamentate dal disposto degli Art. 108 e seguenti del Regolamento
dell’Ordine.
Dignitari di Loggia: (G.O.I.) I Dignitari e gli Ufficiali Loggia coadiuvano il Maestro
Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un’anzianità nel Grado di
Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver maturato la stessa anzianità. Sono
Dignitari di Loggia: il Primo Sorvegliante; il Secondo Sorvegliante, l’Oratore; il
Tesoriere ed il Segretario. Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati dalle
tradizioni e, come il Segretario, sono nominati dal Maestro Venerabile. Il Regolamento
dell’Ordine determina le funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia,
specificandone i compiti egli attributi (Art. 21 del Regolamento dell’Ordine). Sono
eleggibili alle cariche di Loggia i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti
dalla Costituzione, iscritti nel piè di lista ed in regola con il tesoro (Art. 30 del
Regolamento dell’Ordine).
Diluvio: Cataclisma
voluto dalla divinità per la punizione degli uomini. L’idea del D., detto
impropriamente universale, si ricollega ad avvenimenti storici risalenti al IV millennio
a.C. Riferimenti al D. si ritrovano anche nella mitologia egiziana, ma i principali
racconti si trovano nel mondo assiro babilonese ed in quello ebraico. L’XI tavoletta
del Poema di Gilgamesh narra di re Ut-napishtim che, avvertito dal dio Ea
dell’intenzione degli dei, istigati da Enlil, di allagare il mondo, si salva
racchiudendosi in un’arca; al termine del D. questa si posa sul monte Nisir. Evidenti
le analogie del racconto babilonese con quello biblico, forse perché entrambi provenivano
da un racconto anteriore. Secondo la Bibbia, Dio decise di sterminare l’umanità,
poiché sdegnato dalla sua perversione (Genesi 6, 7). Solo Noè trovò grazia
presso Dio, che gli ordinò di costruire un’arca (v.), in cui porre in salvo sé
stesso, la propria famiglia di otto persone ed una coppia di tutti gli animali. Il D.
durò 40 giorni e 40 notti. L’arca galleggiò sulle acque finché, ritiratesi queste,
si adagiò sul monte Ararat. Tracce del D. si ritrovano in India, in Malesia, fra gli
Indiani d’America ed altrove. Nel mondo classico celebre è il mito di Deucalione
(v.) e Pirra. La cosmologia stoica ipotizza tutta una serie di D. storici. Anche per
alcune mitologie nordiche la terra finirà inghiottita dall’acqua.
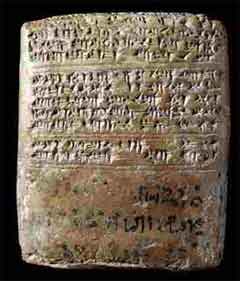 Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in
Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,
documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico
e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali
analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.
Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto
(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette
segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si
conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani
saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.
Demotico: Dal greco demoticoz, popolare, è il nome di una scrittura corsiva usata in
Egitto dal VII-VI secolo a.C. fino alla caduta dell’impero romano, in atti pubblici,
documenti privati, testi sacri ed in epopee nazionali, come semplificazione dello ieratico
e del geroglifico. È caratterizzata dalla riduzione dei segni, da forme verbali
analitiche, dalla scomparsa della congiunzione per suffissi e da sostantivi composti.
Sviluppo del neo-egiziano del Nuovo Impero (1400-700 a.C.), il D. fu sostituito dal copto
(v.), ultima fase della lingua parlata che, accanto ai caratteri greci, conservò sette
segni del D. I documenti più antichi in D. non ci sono pervenuti, ed i primi che si
conoscono sono quelli relativi alla conquista dell’Alto Egitto da parte dei sovrani
saititi (da Sais), mentre la più recente iscrizione in D. risale al 474-491 d.C.
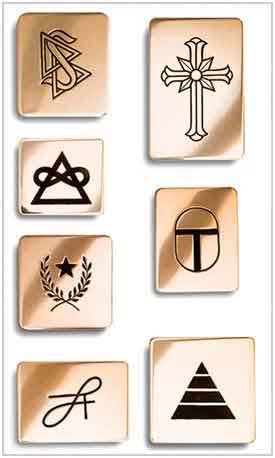 Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa
situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo
per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad
alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e
le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).
Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo
attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali
facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi
oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è
stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico
dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi
prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza
infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,
del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe
infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro
azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:
sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui
proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato
il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività
di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.
Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come
parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni
manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra
vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in
grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,
maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che
non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,
insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben
distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui
siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva
i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che
contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere
decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo
apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la
sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene
sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un
individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece
l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva
s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata
dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione
chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.
Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le
percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla
persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri
depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e
fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di
un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che
succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un
uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.
Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono
registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento
di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno
schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è
una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,
c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una
registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente
reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.
L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito
dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello
schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale
al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una
buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce
dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde
uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui
il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere
volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra
percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna
conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei
subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei
udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito
(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,
lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le
parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna
potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea
continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se
restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,
in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.
Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.
La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:
benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è
peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in
pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona
paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di
cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel
portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di
ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:
lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che
si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti
negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,
possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e
falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una
volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste
caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con
la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni
dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza
personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la
mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno
successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente
desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le
persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle
scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno
stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle
caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non
hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità
umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali
malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad
un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente
stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno
soggetto agli incidenti; · più sano; ·
capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire
rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la
vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze
altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i
problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale
troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere
pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a
brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le
testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano
tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai
cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un
incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il
recupero del piacere della vita individuale e sociale.
Nel 1950, con la pubblicazione di D.: la forza del pensiero sul corpo, L. Ron Hubbard cambiò completamente questa
situazione. Questo libro segnò una svolta nella storia della ricerca condotta dall'Uomo
per comprendere realmente se stesso. D. sarebbe una metodologia che può aiutare ad
alleviare disturbi come le sensazioni e le emozioni indesiderate, le paure irrazionali e
le malattie psicosomatiche (cioè quei mali causati o aggravati dallo stress mentale).
Sinteticamente si potrebbe asserire che D. si occupa di ciò che l'anima fa al corpo
attraverso la mente. Come Scientology, D. si fonda su dei principi fondamentali
facilmente assimilabili, che si sono dimostrati esatti e che, soprattutto, sono validi
oggi così come lo erano nel 1950. L'aver definito concisamente lo scopo della vita, è
stata una delle conquiste più importanti di D.. La scoperta del principio dinamico
dell'esistenza umana fatta da Ron Hubbard, ha consentito la soluzione di tanti enigmi
prima d'ora irrisolti. Egli afferma che lo scopo della vita sia il raggiungimento di una sopravvivenza
infinita. Sebbene si sappia da molto tempo che l'Uomo cerca sempre di sopravvivere,
del tutto nuova è la considerazione che questa sia la sua motivazione primaria. Sarebbe
infatti possibile dimostrare che gli uomini, in quanto forme di vita, in tutte le loro
azioni e nella totalità degli obiettivi che si prefiggono, rispondono ad un solo comando:
sopravvivere. Questo sarebbe il comune denominatore dell'intera vita, da cui
proviene la risoluzione cruciale dei mali e delle aberrazioni dell'Uomo. Una volta isolato
il comando sopravvivere, in quanto spinta primaria che spiega la totalità delle attività
di una forma di vita, fu necessario approfondire lo studio dell'azione del sopravvivere.
Questa ricerca permise di scoprire che, se si considerano il dolore e il piacere come
parte dell'equazione, si hanno in mano gli ingredienti necessari per comprendere ogni
manifestazione della vita. Per sopravvivenza non s'intende soltanto la differenza tra
vivere e morire. Esistono infatti vari livelli di sopravvivenza. Tanto più uno è in
grado di gestire la propria vita e di accrescere il proprio livello di sopravvivenza,
maggiori sono il piacere, la ricchezza e la soddisfazione che ne ricaverà. Le azioni che
non promuovono la sopravvivenza avranno al contrario come risultato dolore,
insoddisfazione e fallimento. Ron Hubbard ha scoperto che la mente ha due parti ben
distinte. Una di queste, cioè quella componente che usiamo in modo consapevole e di cui
siamo coscienti, è la mente analitica. È la parte della mente che pensa, osserva
i dati e li ricorda e risolve i problemi. Ha i depositi standard della memoria che
contengono immagini mentali ed usa i dati contenuti in questi depositi per prendere
decisioni che favoriscano la sopravvivenza. Tuttavia esistono due elementi che solo
apparentemente vengono registrati nei depositi standard: l'emozione dolorosa e la
sofferenza fisica. Nei momenti di dolore intenso, l'azione della mente analitica viene
sospesa ed entra in gioco l'altra parte della mente: la mente reattiva. In un
individuo del tutto cosciente, la sua mente analitica ha il pieno controllo. Quando invece
l'individuo è del tutto o solo in parte inconscio allora la mente reattiva
s'inserisce, interamente o soltanto parzialmente. L'incoscienza potrebbe essere derivata
dallo shock di un incidente, dalla somministrazione di anestetici per un'operazione
chirurgica, dal dolore provocato da una ferita o dal delirio generato da una malattia.
Quando l'individuo è inconscio, la mente reattiva registra con esattezza tutte le
percezioni di quell'incidente, includendo ciò che accade o viene detto intorno alla
persona. Inoltre essa registra tutto il dolore e conserva quell'immagine mentale nei propri
depositi, rendendola così inaccessibile ad un richiamo intenzionale dell'individuo e
fuori dal suo controllo. Può sembrare che una persona che ha perso conoscenza a causa di
un incidente non sia consapevole di ciò che le sta accadendo intorno. In realtà quel che
succede è che la sua mente reattiva continua a registrare attivamente ogni cosa per un
uso futuro. La mente reattiva non immagazzina ricordi così come noi li conosciamo.
Immagazzina particolari tipi di immagini mentali, denominati engram. Queste sono
registrazioni accurate fin nel minimo dettaglio di ogni percezione presente in un momento
di parziale o totale incoscienza. Un esempio di engram: una donna riceve uno
schiaffo e cade a terra inconscia. Viene presa a calci su un fianco, le viene detto che è
una bugiarda, che è una buona a nulla, che è volubile. Nel frattempo cade una sedia,
c'è un rubinetto che perde in cucina e un'auto passa in strada. L'engram contiene una
registrazione senza interruzioni di tutte queste percezioni. Il problema, con la mente
reattiva, è che pensa solo in termini d'identità, ogni cosa è identica all'altra.
L'equazione risulta essere A=A=A=A=A. Un calcolo della mente reattiva, a proposito
dell'engram citato, potrebbe essere: il dolore del calcio uguale al dolore dello
schiaffo uguale alla sedia rovesciata uguale alla macchina che passa uguale
al rubinetto uguale al fatto che lei è bugiarda uguale al fatto che è una
buona a nulla uguale al fatto che è volubile uguale ai toni di voce
dell'uomo che l'ha colpita uguale all'emozione uguale al rubinetto che perde
uguale al dolore del calcio uguale alla sensazione fisica nel punto in cui
il calcio è stato ricevuto uguale alla sedia rovesciata uguale all'essere
volubile uguale. Ciascuna percezione di questo engram è uguale a ogni altra
percezione che vi è contenuta. In futuro, quando l'ambiente in cui vive questa donna
conterrà un numero sufficiente di elementi simili a quelli contenuti nell'engram, lei
subirà una riattivazione dell'engram. Per esempio se una sera il rubinetto perdesse e lei
udisse il rumore di un'auto che passa in strada e, nello stesso momento, suo marito
(l'uomo dell'engram) la rimproverasse con il medesimo tono di voce dell'engram originale,
lei tornerebbe a provare il dolore al fianco dov’era stata presa a calci. Inoltre le
parole pronunciate nell'engram potrebbero trasformarsi in comandi: la donna
potrebbe sentirsi una buona a nulla o avere l'impressione di essere una che cambia idea
continuamente. La mente reattiva le sta dicendo che si trova in un ambiente pericoloso. Se
restasse, il dolore fisico nei punti del corpo dove venne colpita potrebbe trasformarsi,
in quegli stessi punti, in una predisposizione ad ammalarsi o in una malattia cronica.
Questo fenomeno, il risveglio del vecchio engram, è detto restimolazione.
La mente reattiva non è d'aiuto alla sopravvivenza di una persona e per un valido motivo:
benché sia abbastanza forte da resistere nel corso del dolore e dell'incoscienza, non è
peraltro molto intelligente. I suoi tentativi di impedire a una persona di mettersi in
pericolo, imponendole il contenuto dell'engram, possono causare a quella persona
paure, emozioni, dolori e malattie psicosomatiche che non ha né valutato, né voluto e di
cui è ignara, ma senza le quali starebbe decisamente meglio. Lo scopo di D. consiste nel
portare l'individuo al conseguimento di un nuovo stato, che l'Uomo ha cercato a lungo di
ottenere nel corso della sua storia senza che, prima di D., riuscisse mai a raggiungerlo:
lo stato detto di "Clear" (libero, sgombro). Un Clear è una persona che
si è liberata della propria mente reattiva e che di conseguenza non soffre degli effetti
negativi che questa poteva causarle. Il Clear non ha engram che, una volta restimolati,
possano alterare la correttezza dei suoi calcoli con l'inserimento di dati nascosti e
falsi. La personalità innata di un individuo e la sua creatività si rafforzerebbero una
volta che è diventato Clear, senza che questo diminuisca in alcun modo queste
caratteristiche. Un Clear può esprimere liberamente le proprie emozioni, può pensare con
la propria testa e assaporare la vita senza lasciarsi intralciare dalle inibizioni
dettategli reattivamente dai vecchi engram. Le qualità artistiche, l'indole e la forza
personale continuano a far parte della personalità di base dell'individuo, ma non la
mente reattiva. I Clear hanno fiducia in se stessi, sono felici e generalmente hanno
successo nel lavoro così come nelle relazioni personali. Si tratta di uno stato altamente
desiderabile che potenzialmente tutti potrebbero ottenere: si conterebbero a migliaia le
persone che hanno conquistato lo stato di Clear, un tributo vivente all'efficacia delle
scoperte di Ron Hubbard e alla tecnologia da lui sviluppata. Quello di un Clear è uno
stato mai raggiunto prima d'ora nella storia dell'Uomo. Un Clear possiede delle
caratteristiche fondamentali ed innate che nemmeno si sospettava l'Uomo avesse e che non
hanno riscontro nelle dissertazioni fatte in passato sul comportamento e sulle abilità
umane. Il Clear sarebbe: · esente da effettive o potenziali
malattie psicosomatiche o da aberrazioni; · autodeterminato; · energico e tenace; · non represso; · capace di percepire, ricordare, immaginare, creare e calcolare ad
un livello molto al di sopra della norma; · mentalmente
stabile; · libero di manifestare le proprie emozioni; · capace di godere la vita; · meno
soggetto agli incidenti; · più sano; ·
capace di ragionare con prontezza; · capace di reagire
rapidamente. La felicità è importante, così come lo è la capacità di organizzare la
vita e l'ambiente in modo da vivere con maggior serenità, di tollerare le debolezze
altrui, d'individuare in una situazione gli esatti fattori e risolvere con precisione i
problemi del vivere, di accettare le responsabilità e di portarle a compimento. Non vale
troppo la pena di vivere se non si è in grado di godere la vita. Il Clear sa godere
pienamente dell'esistenza e può far fronte a situazioni che prima lo avrebbero ridotto a
brandelli. Il dono del Clear è la capacità di vivere bene, con pienezza e con gioia. Le
testimonianze fornite da innumerevoli seguaci della tecnologia di Ron Hubbard confermano
tra l’altro la liberazione dalla schiavitù della droga e da altri vizi ormai
cronici, il recupero totale della vista o dell’uso di un arto paralizzato da un
incidente, la guarigione da patologie psico-fisiche giudicate incurabili e soprattutto il
recupero del piacere della vita individuale e sociale.