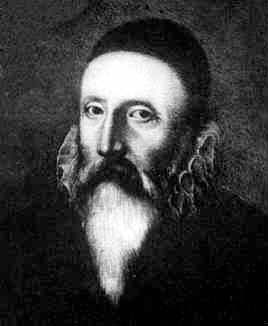 Dee John: Figura dell’Alchimia inglese del XVI secolo (1527-1608). Nacque a Londra il
13.7.1527. Suo padre Roland proveniva da una famiglia piuttosto distinta, e amava
profondamente suo figlio. Rendendosi conto delle sue grandi capacità, lo indirizzò
principalmente allo studio della Letteratura Greca e Latina. Studiò poi a Chelmsford,
nell’Essex, ma poi, avendo completato felicemente il suo curriculum di studi, verso
la fine del 1542 fu iscritto dal padre a Cambridge, nel collegio dedicato alla memoria di
San Giovanni Evangelista, al Corso di Scienze Superiori. A Cambridge D. acquisì una
grande cultura ad un incredibile ritmo, lavorando sui suoi libri e nelle ore di istruzione
individuale fino a diciotto ore al giorno. Nel 1548 ottenne la laurea di Professore
d'Arte, e si recò a Louvain, dove insegnò diritto civile, mentre segretamente si dava
allo studio delle scienze occulte. Nel 1550 lasciò Louvain per completare la sua
istruzione nel continente. La sua fama si diffuse in Europa, ed a 23 anni tenne una
lezione su Euclide all'Università di Parigi, di fronte a un pubblico entusiasta. Grazie
alla sua reputazione di grande filosofo, rimase per due regni al servizio della Corte
Inglese. Nel 1555, sotto il regno di Mary, venne però accusato di aver attentato con arti
magiche alla vita della regina. Venne imprigionato e giudicato prima dalla Camera stellata
di Westminster, che lo prosciolse, e poi da un tribunale ecclesiastico che lo condannò.
Il 29 agosto 1553 la regina Mary lo fece scarcerare. D. lasciò l’insegnamento
pubblico per dedicarsi allo studio delle antichità inglesi, raccogliendo preziosissimi
cimeli. Nel 1558, in occasione dell’ascensione al trono di Elisabetta, secondogenita
di Enrico VIII, D. fu chiamato a corte e fu incaricato di redigere un oroscopo per
accertare la data più favorevole alla sua incoronazione. Annoiato dalla vita di corte,
nel 1563 lasciò di nuovo l’Inghilterra, e viaggiò in Belgio, Germania, Austria ed
Ungheria. Durante il viaggio di ritorno si formò ad Aversa, per terminare la "Monade
geroglifica", che dedicò all’imperatore Massimiliano II (1527-1576). Pochi
suoi lavori sono stati ristampati in tempi moderni, con l'eccezione proprio della Monade
Geroglifica che, fin dalla sua prima apparizione nel 1564 (Monas Hyerogliphica,
Antwerp, 1564), è passato attraverso sei edizioni e si trova ancor oggi nelle librerie.
In quest'opera D. tenta di simbolizzare l'omogeneità dell'Universo e del Creatore, ogni
elemento individuale essendo descritto come componente rapportato alla Monade,
rappresentato come emblema Mercuriale combinato con il punto e il Crescente Binario.
Tornato in Inghilterra, si stabilì a Greenwich, residenza estiva della regina, e si
intrattenne con lei sulla pietra filosofale. Preso nuovamente dal desiderio di viaggiare,
nel 1571 si recò nella Lorena. Ammalatasi la regina Elisabetta, dovette tornare in
Inghilterra. Si stabilì allora Mortlake, sulla riva destra del Tamigi, a otto miglia da
Londra, dove la regina si recava d'estate a respirare aria pura. A Mortlake si sposò, e
per alcuni anni visse tranquillo. Essendogli morta la moglie nel 1575, entrò sempre di
più nelle grazie della regina, che spesso si recava a visitare la sua famosa biblioteca e
le celebri collezioni raccolte. D. nel frattempo si dedicava alla ricerca degli Arcani
della filosofia occulta, e soprattutto allo studio del problema dell'Elisir Filosofico. Al
principio del 1580 si mise in società con un giovane venticinquenne, detto Kelley, per
studiare l'occulto; costui l'accompagnò sempre in tutti i viaggi, e fu cagione delle sue
sventure. Credendo d'essere perseguitato, il 21 settembre 1583, D. fuggì da Mortlake con
la sua seconda moglie Jane Fromond, (sposata il 5 febbraio 1578), con suo figlio Arturo,
allora di quattro anni, con gli altri suoi bambini, con Kelley e sua moglie (sposata in
quello stesso anno) e coi servi, insieme con un tale Alberto di Lasky, nobile Polacco.
Costoro, dopo molte peripezie, sbarcarono a Briel (Olanda), donde si diressero al castello
del Lasky (presso Cracovia), che raggiunsero felicemente il 3 febbraio 1584. D. rimase
soltanto cinque settimane al castello di Lasky. Il 9 marzo del 1584 si recò a Cracovia,
dove continuò le sue operazioni magiche. Dopo un soggiorno di alcuni mesi in quella
città, si rimise in viaggio, e giunse l’8 agosto a Praga, dove Rodolfo II,
imperatore di Germania, teneva una brillantissima corte. D. e Kelley si recarono alla
corte dell’imperatore, ma Rodolfo II dubitò subito della scienza di D. Fu così
costretto a lasciare Praga e, dopo molte peripezie, il 2 aprile 1585 tornò a Cracovia.
Anche a Cracovia le cose non andarono bene: il re Stefano accolse D. alla sua corte, e il
27 maggio del 1585 accettò di partecipare a una seduta magica. Ma quando si trovò
all’atto pratico, si spaventò moltissimo, lasciando da solo D., del quale poi
respinse ogni ulteriore proposta. Verso la fine di luglio del 1585, D. tornò a Praga in
pessime condizioni finanziarie. Là lo attendevano altre traversie. Fu pedinato da un
certo Francesco Pucci, un fiorentino spia del Sant’Uffizio, che su richiesta del
vescovo di Piacenza, nunzio del papa, aveva istruzioni di condurlo a Roma e di bruciarlo
come mago e negromante. D. si salvò grazie all’imperatore, che lo sottrasse al rogo
ma lo bandì dai suoi stati. Un suo allievo, il nobile Guglielmo Ursino, signore di
Rosenberg, burgravio di Boemia, dopo averlo difeso di fronte a Rodolfo II, l’ospitò
nel suo castello di Tresbona. In esso lo sfortunato D. dimorò dal 1586 al 1589. Nel 1589
la regina Elisabetta lo richiamò in patria. Essendo sempre considerato un mago e un
negromante, il D. fu nuovamente veduto di mal occhio dalla corte e dal clero. Il 20 maggio
1595 la regina lo nominò rettore del Christ's College di Manchester, che egli abbandonò
volontariamente nel 1604 per tornare a Mortlake. Dopo la morte di Elisabetta nel 1603, la
vita e la salute di D. si deteriorarono rapidamente. La sua reputazione come mago
continuò ad intralciarlo, e persino al College di Manchester incontrò ostilità. Il
successore della regina, Giacomo I, autore di "Demonologia", in seguito
divenuto il testo dei cacciatori di streghe, lo trattò sfavorevolmente, ma gli permise di
vivere in relativa pace per il resto della sua vita. Morì nel 1608, e fu sepolto nella
Chiesa di Mortlake. Fu uno scrittore prolifico, produsse numerosi libri e manoscritti
lungo l'arco della sua vita. Queste opere coprirono svariati argomenti: le arti, le
scienze e la filosofia furono tutti rappresentanti in ammirevoli ed eruditi dettagli,
alcuni così lunghi e complessi che i tipografi rifiutavano di accettarli. Nel 1570 egli
pubblicò il suo ampiamente acclamato "Introduzione alla matematica" per
l'edizione inglese di "Geometria di Euclide", traduzione di Sir Henry
Billingsley, Londra, 1570, un lavoro di grande originalità ed erudizione, che esercitò
grande influenza sul pensiero scientifico del sedicesimo secolo. A parte i suoi scopi
letterari, fu un prodigioso collezionista di libri. La sua biblioteca contenne circa
tremila volumi e parecchie centinaia di manoscritti, superiore a qualsiasi altra raccolta
nel mondo Elisabettiano. Questi, insieme con un vasto apparato di documenti celtici,
antichi sigilli e genealogie, furono conservati nella sua casa di Mortlake. La casa di
Mortlake ospitò anche la sua collezione di strumenti scientifici: astrolabi, quadranti,
globi, ogni sorta di strumenti ottici e di navigazione stipati nei suoi laboratori. Nella
sua "Vita Joannis Dee" (1707), Thomas Smith descrive il contenuto della
biblioteca di Dee nel seguente modo: "Al nobile contenuto della Biblioteca appartenne
una non moderata accumulazione di strumenti matematici ed apparecchiature, anche quelli
che, a quel tempo, non erano entrati nell'uso comune e quelli che, emendati e riformati
con la propria ingegnosità, aveva riportato ad una migliore condizione, tra cui erano un
quadrante ed un'asta, il cui semidiametro misurava cinque piedi. Di questi, dieci
accuratamente segnati da divisioni, il globo di Mercator, furono corretti e migliorati con
nuove osservazioni. Egli aveva inserito i luoghi e i moti delle comete, che apparivano al
tempo giusto, l'ottavo, il nono e il decimo delle loro sfere, secondo le ipotesi della
teoria di Purbachius, ornati con un orizzonte e una meridiana di ottone. Aveva compassi da
marinaio di vari tipi, fabbricati per trovare la variazione e, infine, una sveglia che, a
quell'epoca, fu considerata quasi un miracolo, adatta a misurare i minuti secondi delle
ore". Dee inventò vari strumenti di navigazione su suo disegno: tra questi un
dispositivo che chiamò Compasso Paradossale, che potrebbe venire adottato per evitare
errori nel tracciare le carte. I marinai, comunque, non si fidarono di questa innovazione
(o, forse, non compresero il complesso principio della sua operazione), ed esso venne
usato raramente. Stranamente, furono i talenti inventivi che per primi risollevarono la
sua reputazione di mago. Nei suoi primi giorni a Cambridge fu il responsabile di una messa
in scena della "Pax" di Aristofane, per la quale egli inventò una blatta
meccanica o Scarabeus, che volò per aria fino al Palazzo di Jupiter, trasportando un uomo
ed un cestello di cibo. Ciò lasciò così meravigliato il pubblico, che era per lo più
ignorante di arti meccaniche, che si sparsero voci ad effetto secondo le quali aveva
compiuto tale meraviglia con l'aiuto dei demoni. Simili credenze superstiziose in seguito
(1583) fecero sì che la casa e la biblioteca di Dee fossero frugate da una moltitudine di
gente mentre lui e la sua famiglia viaggiavano nel Continente. Tra le sue opere alchemiche
ricordiamo: La Monade Geroglifica (1564) (La Monade Geroglifica, Arktos,
Carmagnola, 1981); Liber Mysteriorum I - V; Trattato Magico; De Heptarchia
Mystica (1582) (De Heptarchia Mystica, Atanor 1986) e molti pregevoli manoscritti.
Dee John: Figura dell’Alchimia inglese del XVI secolo (1527-1608). Nacque a Londra il
13.7.1527. Suo padre Roland proveniva da una famiglia piuttosto distinta, e amava
profondamente suo figlio. Rendendosi conto delle sue grandi capacità, lo indirizzò
principalmente allo studio della Letteratura Greca e Latina. Studiò poi a Chelmsford,
nell’Essex, ma poi, avendo completato felicemente il suo curriculum di studi, verso
la fine del 1542 fu iscritto dal padre a Cambridge, nel collegio dedicato alla memoria di
San Giovanni Evangelista, al Corso di Scienze Superiori. A Cambridge D. acquisì una
grande cultura ad un incredibile ritmo, lavorando sui suoi libri e nelle ore di istruzione
individuale fino a diciotto ore al giorno. Nel 1548 ottenne la laurea di Professore
d'Arte, e si recò a Louvain, dove insegnò diritto civile, mentre segretamente si dava
allo studio delle scienze occulte. Nel 1550 lasciò Louvain per completare la sua
istruzione nel continente. La sua fama si diffuse in Europa, ed a 23 anni tenne una
lezione su Euclide all'Università di Parigi, di fronte a un pubblico entusiasta. Grazie
alla sua reputazione di grande filosofo, rimase per due regni al servizio della Corte
Inglese. Nel 1555, sotto il regno di Mary, venne però accusato di aver attentato con arti
magiche alla vita della regina. Venne imprigionato e giudicato prima dalla Camera stellata
di Westminster, che lo prosciolse, e poi da un tribunale ecclesiastico che lo condannò.
Il 29 agosto 1553 la regina Mary lo fece scarcerare. D. lasciò l’insegnamento
pubblico per dedicarsi allo studio delle antichità inglesi, raccogliendo preziosissimi
cimeli. Nel 1558, in occasione dell’ascensione al trono di Elisabetta, secondogenita
di Enrico VIII, D. fu chiamato a corte e fu incaricato di redigere un oroscopo per
accertare la data più favorevole alla sua incoronazione. Annoiato dalla vita di corte,
nel 1563 lasciò di nuovo l’Inghilterra, e viaggiò in Belgio, Germania, Austria ed
Ungheria. Durante il viaggio di ritorno si formò ad Aversa, per terminare la "Monade
geroglifica", che dedicò all’imperatore Massimiliano II (1527-1576). Pochi
suoi lavori sono stati ristampati in tempi moderni, con l'eccezione proprio della Monade
Geroglifica che, fin dalla sua prima apparizione nel 1564 (Monas Hyerogliphica,
Antwerp, 1564), è passato attraverso sei edizioni e si trova ancor oggi nelle librerie.
In quest'opera D. tenta di simbolizzare l'omogeneità dell'Universo e del Creatore, ogni
elemento individuale essendo descritto come componente rapportato alla Monade,
rappresentato come emblema Mercuriale combinato con il punto e il Crescente Binario.
Tornato in Inghilterra, si stabilì a Greenwich, residenza estiva della regina, e si
intrattenne con lei sulla pietra filosofale. Preso nuovamente dal desiderio di viaggiare,
nel 1571 si recò nella Lorena. Ammalatasi la regina Elisabetta, dovette tornare in
Inghilterra. Si stabilì allora Mortlake, sulla riva destra del Tamigi, a otto miglia da
Londra, dove la regina si recava d'estate a respirare aria pura. A Mortlake si sposò, e
per alcuni anni visse tranquillo. Essendogli morta la moglie nel 1575, entrò sempre di
più nelle grazie della regina, che spesso si recava a visitare la sua famosa biblioteca e
le celebri collezioni raccolte. D. nel frattempo si dedicava alla ricerca degli Arcani
della filosofia occulta, e soprattutto allo studio del problema dell'Elisir Filosofico. Al
principio del 1580 si mise in società con un giovane venticinquenne, detto Kelley, per
studiare l'occulto; costui l'accompagnò sempre in tutti i viaggi, e fu cagione delle sue
sventure. Credendo d'essere perseguitato, il 21 settembre 1583, D. fuggì da Mortlake con
la sua seconda moglie Jane Fromond, (sposata il 5 febbraio 1578), con suo figlio Arturo,
allora di quattro anni, con gli altri suoi bambini, con Kelley e sua moglie (sposata in
quello stesso anno) e coi servi, insieme con un tale Alberto di Lasky, nobile Polacco.
Costoro, dopo molte peripezie, sbarcarono a Briel (Olanda), donde si diressero al castello
del Lasky (presso Cracovia), che raggiunsero felicemente il 3 febbraio 1584. D. rimase
soltanto cinque settimane al castello di Lasky. Il 9 marzo del 1584 si recò a Cracovia,
dove continuò le sue operazioni magiche. Dopo un soggiorno di alcuni mesi in quella
città, si rimise in viaggio, e giunse l’8 agosto a Praga, dove Rodolfo II,
imperatore di Germania, teneva una brillantissima corte. D. e Kelley si recarono alla
corte dell’imperatore, ma Rodolfo II dubitò subito della scienza di D. Fu così
costretto a lasciare Praga e, dopo molte peripezie, il 2 aprile 1585 tornò a Cracovia.
Anche a Cracovia le cose non andarono bene: il re Stefano accolse D. alla sua corte, e il
27 maggio del 1585 accettò di partecipare a una seduta magica. Ma quando si trovò
all’atto pratico, si spaventò moltissimo, lasciando da solo D., del quale poi
respinse ogni ulteriore proposta. Verso la fine di luglio del 1585, D. tornò a Praga in
pessime condizioni finanziarie. Là lo attendevano altre traversie. Fu pedinato da un
certo Francesco Pucci, un fiorentino spia del Sant’Uffizio, che su richiesta del
vescovo di Piacenza, nunzio del papa, aveva istruzioni di condurlo a Roma e di bruciarlo
come mago e negromante. D. si salvò grazie all’imperatore, che lo sottrasse al rogo
ma lo bandì dai suoi stati. Un suo allievo, il nobile Guglielmo Ursino, signore di
Rosenberg, burgravio di Boemia, dopo averlo difeso di fronte a Rodolfo II, l’ospitò
nel suo castello di Tresbona. In esso lo sfortunato D. dimorò dal 1586 al 1589. Nel 1589
la regina Elisabetta lo richiamò in patria. Essendo sempre considerato un mago e un
negromante, il D. fu nuovamente veduto di mal occhio dalla corte e dal clero. Il 20 maggio
1595 la regina lo nominò rettore del Christ's College di Manchester, che egli abbandonò
volontariamente nel 1604 per tornare a Mortlake. Dopo la morte di Elisabetta nel 1603, la
vita e la salute di D. si deteriorarono rapidamente. La sua reputazione come mago
continuò ad intralciarlo, e persino al College di Manchester incontrò ostilità. Il
successore della regina, Giacomo I, autore di "Demonologia", in seguito
divenuto il testo dei cacciatori di streghe, lo trattò sfavorevolmente, ma gli permise di
vivere in relativa pace per il resto della sua vita. Morì nel 1608, e fu sepolto nella
Chiesa di Mortlake. Fu uno scrittore prolifico, produsse numerosi libri e manoscritti
lungo l'arco della sua vita. Queste opere coprirono svariati argomenti: le arti, le
scienze e la filosofia furono tutti rappresentanti in ammirevoli ed eruditi dettagli,
alcuni così lunghi e complessi che i tipografi rifiutavano di accettarli. Nel 1570 egli
pubblicò il suo ampiamente acclamato "Introduzione alla matematica" per
l'edizione inglese di "Geometria di Euclide", traduzione di Sir Henry
Billingsley, Londra, 1570, un lavoro di grande originalità ed erudizione, che esercitò
grande influenza sul pensiero scientifico del sedicesimo secolo. A parte i suoi scopi
letterari, fu un prodigioso collezionista di libri. La sua biblioteca contenne circa
tremila volumi e parecchie centinaia di manoscritti, superiore a qualsiasi altra raccolta
nel mondo Elisabettiano. Questi, insieme con un vasto apparato di documenti celtici,
antichi sigilli e genealogie, furono conservati nella sua casa di Mortlake. La casa di
Mortlake ospitò anche la sua collezione di strumenti scientifici: astrolabi, quadranti,
globi, ogni sorta di strumenti ottici e di navigazione stipati nei suoi laboratori. Nella
sua "Vita Joannis Dee" (1707), Thomas Smith descrive il contenuto della
biblioteca di Dee nel seguente modo: "Al nobile contenuto della Biblioteca appartenne
una non moderata accumulazione di strumenti matematici ed apparecchiature, anche quelli
che, a quel tempo, non erano entrati nell'uso comune e quelli che, emendati e riformati
con la propria ingegnosità, aveva riportato ad una migliore condizione, tra cui erano un
quadrante ed un'asta, il cui semidiametro misurava cinque piedi. Di questi, dieci
accuratamente segnati da divisioni, il globo di Mercator, furono corretti e migliorati con
nuove osservazioni. Egli aveva inserito i luoghi e i moti delle comete, che apparivano al
tempo giusto, l'ottavo, il nono e il decimo delle loro sfere, secondo le ipotesi della
teoria di Purbachius, ornati con un orizzonte e una meridiana di ottone. Aveva compassi da
marinaio di vari tipi, fabbricati per trovare la variazione e, infine, una sveglia che, a
quell'epoca, fu considerata quasi un miracolo, adatta a misurare i minuti secondi delle
ore". Dee inventò vari strumenti di navigazione su suo disegno: tra questi un
dispositivo che chiamò Compasso Paradossale, che potrebbe venire adottato per evitare
errori nel tracciare le carte. I marinai, comunque, non si fidarono di questa innovazione
(o, forse, non compresero il complesso principio della sua operazione), ed esso venne
usato raramente. Stranamente, furono i talenti inventivi che per primi risollevarono la
sua reputazione di mago. Nei suoi primi giorni a Cambridge fu il responsabile di una messa
in scena della "Pax" di Aristofane, per la quale egli inventò una blatta
meccanica o Scarabeus, che volò per aria fino al Palazzo di Jupiter, trasportando un uomo
ed un cestello di cibo. Ciò lasciò così meravigliato il pubblico, che era per lo più
ignorante di arti meccaniche, che si sparsero voci ad effetto secondo le quali aveva
compiuto tale meraviglia con l'aiuto dei demoni. Simili credenze superstiziose in seguito
(1583) fecero sì che la casa e la biblioteca di Dee fossero frugate da una moltitudine di
gente mentre lui e la sua famiglia viaggiavano nel Continente. Tra le sue opere alchemiche
ricordiamo: La Monade Geroglifica (1564) (La Monade Geroglifica, Arktos,
Carmagnola, 1981); Liber Mysteriorum I - V; Trattato Magico; De Heptarchia
Mystica (1582) (De Heptarchia Mystica, Atanor 1986) e molti pregevoli manoscritti.
Deismo: Concezione
religiosa nata nel XVII secolo e sviluppatasi soprattutto in Inghilterra. Essa nega il
principio di autorità religiosa e la rivelazione, ed in generale tutti i dogmi positivi:
al contrario, esso ammette soltanto quelle verità morali o religiose cui l’uomo può
pervenire attraverso il solo esercizio delle sue facoltà razionali, e perciò è stato
anche chiamato religione naturale o razionale. Il D. inglese inizia con Herbert, che
sottopose la religione soprannaturale all’istinto naturale: fu poi nettamente
sostenuto da Toland, Collins, Tindal e Wollaston, sotto l’influenza di Shaftesbury ed
anche di Locke. Hume si ricollega al D. nella sua critica della superstizione e del
fanatismo, ma ne mette duramente in crisi il fondamento razionale, definendo la religione
come manifestazione del sentimento. Il D. si diffuse in Francia con Voltaire, gli
enciclopedisti e Rousseau, ed anche nell’Illuminismo tedesco espresso da Lessing e
con minore incidenza in quello italiano.
Delfi: Località della
Grecia (Focide), sulle pendici meridionali del monte Parnaso, di notevole importanza
nell’antichità come centro religioso e sede dell’oracolo di Apollo. In età
classica questo fu il più famoso tra gli oracoli apollinei. Il centro cultuale risale al
periodo pre-greco, ed era probabilmente dedicato ad un demone ctonio. La tradizione greca
ricorda in varie forme il passaggio al culto di Apollo, ed il motivo ritorna nelle Eumenidi
di Eschilo. Le profezie erano rese da una sacerdotessa (Pizia), in uno stato di trance
estatica indotto con procedimenti misteriosi, forse attraverso droghe vegetali.
L’oracolo di D. era riconosciuto da tutti i Greci, ed anche dai popoli vicini
ruotanti nell’orbita ellenica, tant’è che Romani e Lidii, in epoche diverse,
furono rappresentati nel collegio sacerdotale che amministrava il complesso dei templi.
Dal punto di vista religioso, i suoi responsi erano in genere orientati in senso
tradizionalista e conservatore. Politicamente l’oracolo era il centro di
un’amfizionia riconosciuta da tutte le polis, e quasi l’unica autorità
superstatale accettata nell’Ellade. Giocò un ruolo importante nella grande
colonizzazione; ed appoggiò poi l’istituzione delle tirannidi e della relativa opera
legislativa. Durante le guerre persiane l’oracolo sconsigliò dapprima la resistenza,
per aderire poi alla politica spartana; appoggiò infine la politica di Filippo di
Macedonia. Il centro di D. ebbe grande importanza religiosa fino alla caduta
dell’impero romano. Y (Archeologia) Pausania parla
a lungo della topografia di D. nella sua Periegesis. I resti furono messi in luce e
restaurati a partire dal 1880, per merito della Società archeologica francese di Atene.
L’antico centro si articola in tre zone: Marmarià, la gola di Castalia ed il
santuario. Il terrazzo di Marmarià reca il tempio di Atena Pronaia, dorico, periptero,
esastilo, in tufo, costruito nel 480 a.C.; alla fine del V secolo fu costruita la thòlos,
di pianta circolare, dall’architetto Teodoro di Focea; in basso è la palestra con
cortile, circondato da peristilio. La fonte Castalia, tagliata nella roccia, ha un bacino
a sette bocche, da cui l’acqua scendeva fino al santuario. Esso è chiuso da un tèmenos
di pianta rettangolare, con delle porte; da quella orientale parte la via sacra, che
attraversa l’area dei tesori e dei donarri. Famoso è il tesori di Sicione (500
a.C.), dorico in antis, ornato di metope scolpite da artisti peloponnesiaci. Segue
il tesoro dei Sifni, in stile ionico, con il fregio del 530 a.C., che a Nord reca la
Gigantomachia, il consesso degli dei ad est, il giudizio di Paride ad Ovest ed un corteo a
Sud. All’angolo della via sacra è il tesoro degli Ateniesi, dorico in antis,
costruito con il bottino della battaglia di Maratona: le merope con le imprese di Eracle
mostrano il sorgere del nuovo stile severo nella scultura greca. I Nassi alzarono una
colonna, nel 550, che reggeva una sfinge dal volto di donna ed il corpo di cagna alata,
oggi conservata nel museo. Altre statue, tripodi, basi e colonne votive furono innalzate
via via come offerte, specialmente dalle città greche dell’Occidente. Il tempio di
Apollo è dorico, periptero, esastilo, con quindici colonne si lati lunghi. Il frontone
marmoreo, opera di di Antenor, fu donato dagli Alcmeonidi, e raffigura la quadriga sacra,
con koùroi e kòrai laterali, e leoni che divorano cervi negli angoli.
Sulla terrazza sovrastante fu ritrovato l’auriga bronzeo, ex-voto di Polizalo di
Gela, ed il tèmenos di Neottolemo, restaurato dai principi tessali; con le statue
di Daochos e di Agias, opera celebre di Lisippo. Il teatro fu costruito nel IV secolo a.C.
nell’angolo Nord Ovest del recinto, e fu restaurato da Eumene II. Accanto era la Lesche
degli Cnidi del 450 a.C., famosa per le pitture di Taso, raffiguranti l’Ilioupèrsis
e la Nèkya.
Delta: Denominazione
della parte settentrionale dell’Egitto, che definisce l’ampio triangolo
costituito dalle ramificazioni del fiume Nilo che si divide a valle della zona di Menfi.
Nel periodo più antico i territori del D. costituivano il To-mehu, il paese
inondato, posto sotto la corona rossa del re del Basso Egitto. Questi territori
furono divisi in epoca dinastica, come quelli dell’Alto Egitto, in nomi o
circoscrizioni amministrative. Il D. ne contava sedici già sotto la XII dinastia
(1991-1778 a.C.), ma giunse ad averne ventidue in epoca tarda. Simbolo emblematico del D.
era il papiro. Il flagello, che faceva parte delle insegne reali, era derivato da Andjti,
antico dio del D., poi soppiantato da Osiride. Nella leggenda osiriaca la dea Cobra
protettrice del Basso Egitto (da Menfi al mare) e Uadjet avrebbe aiutato la dea
Iside a nascondere il figlioletto Horus nei papireti del D., per sottrarlo alla
furia del malvagio Seth, in attesa che crescesse per poter vendicare il padre
Osiride. Originario del D. era anche il dio Thoth (v.), inventore del calendario e
della scrittura. Sembra che gli elementi più remoti della scrittura geroglifica debbano
ritenersi originari della parte orientale della regione del D.
Delta
Luminoso: Nella simbologia massonica è il sacro simbolo dell’Assoluto, nella sua completezza, l’emblema del principio costruttivo di tutti gli organismi. Rappresenta lo schema dell’Essere nella molteplicità infinita delle sue manifestazioni. È costituito da un triangolo equilatero, posizionato con il vertice in alto, con al suo centro un occhio oppure il nome del G.A.D.U. (v.) in lettere ebraiche. Il D. viene posto al centro della parete orientale del Tempio massonico, tra il Sole e la Luna, al di sotto della scritta A.G.D.G.A.D.U., ed è di norma illuminato. Il triangolo è il principale, il maestro dei simboli massonici, ed il suo significato è profondo (Angelo Sebastiani). Le interpretazioni date a questa figura geometrica sembrano musiche verbali piuttosto che sintesi di logiche scaturite dalla ragione. Il triangolo, come il cerchio, non ha inizio né fine. È infinito, ed è universalmente considerato il simbolo della Divinità. Esso simboleggia la divina Trinità, comune a molte religioni, particolarmente in quella cristiana. Il triangolo, secondo il Ragon, rappresenta il principio trino in tutte le sue possibili forme: passato-presente-futuro, Sapienza-Bellezza-Forza, Sale-Zolfo-Mercurio, nascita-vita-morte e luce-tenebre-tempo. I tre angoli rappresentano i tre regni della natura, impero del Creatore, e le tre fasi della rivoluzione perpetua. Il sacro triangolo si è adornato di lettere ebraiche o dell’occhio soltanto nel corso del XVI secolo. Fin dall’origine del suo impiego esso rappresenta l’occhio di Dio. Rappresenta pertanto il Sole, il Ra egizio, lo Zeus greco, il Mitra ed il Varuna indiano, l’Odino nordico e l’Allah islamico. Con la sua immagine sazia, e con la sua luce e con il suo calore soddisfa l’essere, precisando il suo valore capitale. L’occhio viene rappresentato circondato da raggi d’oro. Pertanto l’occhio divino simboleggia: sul piano fisico o materiale il Sole visibile, da cui prendono corpo Vita e Luce: sul piano intermedio od astrale il Verbo, il Logos, il principio creatore; sul piano spirituale od etereo il Grande Architetto dell’Universo. L’elevazione dell’umanità esige tre determinazioni; ciascuna di esse è necessaria quanto le altre. L’intima unione delle tre assicura la loro efficacia, da cui la simbolizzazione con un triangolo equilatero. La sommità, i vertici, si uniscono, in linguaggio mistico: Padre-Figlio-Spirito; in linguaggio volgare: Carne-Cervello-Cuore, oppure Bestialità-Intelligenza-Sentimento; in linguaggio razionale: energia Fondamentale di Vita-Scienza che governa la Natura-Carità (od Amore Sociale) che governa a sua volta la Condordia. Poiché dona la Luce, il triangolo splende e porta l’emblema del Sole.
Demiurgo: Termine
derivato dal greco dhmiourgoz, artefice, ordinatore, nella
società greca arcaica, da Omero in poi, designava chiunque si fosse guadagnata la vita al
di fuori dell’agricoltura. Identificava non solo gli artigiani, ma anche i medici,
gli aedi e gli araldi. Nella civiltà greca classica la classe demiurgica, limitata agli
artigiani indipendenti o salariati, godette di grande importanza in alcune situazioni
particolari, come dell’Atene Periclea, tanta che nelle costituzioni di varie poliz esistevano magistrature in genere collegiali di D., che avevano
evidentemente il compito di difendere i suoi interessi. Secondo Platone (come nel suo
Timeo) il D. è l’artefice del mondo che ha plasmato tutte le cose, sia
rivolgendosi al modello eterno delle idee, sia guardando alla materia informe e
disordinata (v. il Caos). Esso si distingue dunque dal concetto tradizionale di Dio, in
quanto non è una divinità creatrice, ma svolge una funzione di attività mediatrice tra
idee e materia; inoltre ha la realtà di un mito verosimile. Nel neoplatonismo e nelle
correnti gnostiche, il D. diviene una divinità subordinata al Dio Supremo, e mediatrice
tra quest’ultimo ed il mondo. Per Plotino il D. è l’anima del mondo.
Democrazia: Dal
greco dhmoz, popolo, e cratev,
dominare. Forma di governo basata sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di
rappresentanza elettiva, e che garantisce l’uguaglianza e la libertà di tutti i
cittadini. Nella Grecia antica, essa si contrappose alla monarchia ed all’oligarchia
(cioè al potere di gruppi ristretti): essa rimase comunque un metodo di governo, che non
coinvolse l’abolizione del regime schiavistico esistente. Più esattamente, al suo
interno stabiliva la partecipazione al potere di tutti gli uomini liberi di una data
città, che godessero di pieni diritti civili: era la D. della pòlis greca (la città
stato). La civiltà romana vide un maggior equilibrio fra i vari strati sociali, che
trovò la propria sanzione nella legge e nei vari istituti che essa sancì, dal senato ai
tribuni della plebe, trovando così possibilità di modifiche in forme relativamente
pacifiche. La crisi della D. romana inizia con l’estendersi dell’impero, con il
dissolversi della stratificazione sociale originaria, l’espandersi della classe
mercantile a scapito della piccole proprietà terriera, l’accresciuta importanza
dell’esercito. Se l’epoca romana è del potere unitario e della sua crisi, il
Medioevo è un periodo di frammentazione, con diversi centro di potere assoluto, ma anche
con l’emergere di una nuova forma di D., sia pure in forma embrionale. Infatti con i
Comuni italiani si afferma una D. regolata dal nuovo concetto di rappresentatività,
espressa in questa fase tramite le Corporazioni di Arti e Mestieri. Se la crisi dei Comuni
porta al dominio di un solo Signore (il Principe di Machiavelli), si allarga con il
Rinascimento la riflessione teorica sul concetto di D. Nel XVII secolo si affermano
tendenze di difesa del pluralismo medievale contro il potere centrale, ma si pongono anche
le basi per un diverso concetto della libertà, che avrà il punto decisivo di sviluppo
nella rivoluzione americana ed in quella francese. La rivoluzione francese esalta una D.
politica contro i privilegi aristocratici e l’assolutismo monarchico, ma
all’interno ed a tutela delle esigenze della nuova classe emergente, la borghesia. I
diritti del cittadino riconoscono la libertà di stampa, di parola e di coscienza, senza
toccare la radice profonda della diseguaglianza sociale, rafforzando invece la difesa
della proprietà privata e dei rapporti borghesi di produzione. Negli uomini della
rivoluzione sono presenti le suggestioni di Rousseau, le sue aspirazioni ad una forma di
d. diretta e più precise istanze sociali. In Marat e Robespierre la base della
diseguaglianza politica è vista nella diseguaglianza sociale, e vi echeggia quel
radicalismo che sarà portato alle estreme conseguenze da uomini come Babeuf. Sono tutti
elementi in una realtà in cui le classi subalterne non sono ancora in grado di esprimere
la propria volontà come le possibilità di emancipazione e di egemonia politica. Ne
consegue che quanti vagheggiano una D. più completa sul piano sociale, sono costretti ad
affidarne l’attuazione a despoti che agiscano nell’interesse delle masse (come a
tratti appare in Marat) oppure all’azione di sette elitarie e segrete (come in Babeuf
e Buonarroti). Anche dopo la caduta di Napoleone e la Restaurazione, le insurrezioni
francesi del 1830 e del 1848 vedono la subordinazione del nascente proletariato alle
tendenze egemoniche degli strati borghesi più avanzati. Nel XIX secolo è lo stato
nazione che si afferma in tutte le rivoluzioni nazionali, per cui all’interno di
queste nuove forme democratiche permane l’esigenza statale di espansione sul piano
internazionale e di conflitto con altri strati che da ciò deriva. Dopo la sconfitta di
Napoleone III contro la Prussia, con la Comune di Parigi del 1871 si afferma un nuovo
concetto storico di D., ed una nuova classe che se ne fa interamente portatrice: il
proletariato urbano. Nonostante i limiti della Comune, con l’isolamento dei parigini
dai contadini e da ampie zone della nazione, e la sua breve durata, l’affermarsi
della D. popolare, il rifiuto di alcune forme fondamentali dello Stato borghese e
dell’egemonia delle forze borghesi, fanno sì che la Comune sia un punto di
riferimento storico concreto per tutti i dirigenti comunisti. Marx traccia discriminanti
precise all’interno del movimento operaio, proprio in base al giudizio che esso dà
sulla Comune. Lenin chiama la D. comunista lo stato della Comune. Già alla fine
dell’800 ed agli inizi del 900 la D. parlamentare borghese allarga le sue basi,
introducendo il suffragio universale, ma mostra anche limiti e possibilità di
involuzione. In Europa, in seguito alla crisi provocata dalla prima guerra mondiale, le D.
esistenti non riescono a soddisfare le esigenze sociali sempre più diffuse, né queste
riescono a tradursi in precise alternative. Ciò porta ad un’involuzione autoritaria
in tutta l’Europa, ed all’affermarsi di alcune forme autoritarie fasciste e
nazional-socialiste. La fine della seconda guerra mondiale, la sconfitta del nazismo e del
fascismo portano al consolidamento del regime democratico rappresentativo in tutta
l’Europa occidentale, anche se col ritardo registrato sia in Grecia che in Spagna. La
prospettiva della D. comunista, dello stato della Comune vagheggiato da Lenin sembra
imporsi in Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917. La storia della Russia,
come quella di altri paesi dell’Est europeo, evidenzia come anche questa forma di D.
incontri problemi non indifferenti, legati al permanere di diseguaglianze sociali, alla
non conseguita emancipazione democratica delle masse ed al permanere della logica di
stato. La destalinizzazione del 1956 ha denunciato l’esistenza di tali problemi,
senza tuttavia riuscire a risolverli. La caduta del muro di Berlino e lo scioglimento del
blocco sovietico, hanno mantenuto evidenziato il problema centrale di una D. reale e delle
difficoltà incontrate da tutte le nazioni già comuniste per la sua effettiva
realizzazione.
Demolizione della Loggia: (G.O.I.) Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel pagamento
delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata legittimamente dagli Organi
competenti, o che, quantunque convocate ai sensi dell’art.51 lettera g), non svolgano
Lavori rituali o non provvedano nel periodo fissato al rinnovamento delle cariche, sono
cancellate dall’elenco delle Logge del grande Oriente d’Italia. Il Regolamento
dell’Ordine fissa le procedure per l’adozione del provvedimento e per il reclamo
(Art. 23 della Costituzione dell’Ordine). Le Logge riconosciute responsabili di colpa
massonica sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del
fatto: a) con l’ammonizione; b) con la censura semplice; c) con la censura solenne;
d) con la demolizione. Per quanto riguarda le implicazioni previste dalle censure
consultare la voce Sanzioni contro le Logge(v.), mentre per la sentenza che disponga la
demolizione questa commina l’espulsione dall’Ordine dei Fratelli che abbiano
partecipato all’azione che ha dato causa al giudizio massonico (Art. 78 del
Regolamento dell’Ordine). Ove il numero dei Fratelli di una Loggia si riduca, per un
qualsiasi motivo, a meno di sette, di cui almeno cinque con il grado di Maestro, la Giunta
del Grande Oriente d’Italia, sentiti l’Ispettore di Loggia ed il presidente del
Collegio Circoscrizionale, dichiara l’estinzione della Loggia (Art. 80 del
Regolamento dell’Ordine). Il Maestro Venerabile ed i Dignitari della Loggia disciolta
od estinta, sono personalmente obbligati a consegnare alla Giunta del Grande Oriente
d’Italia la Bolla di Fondazione, il Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e
quant’altro appartenga alla Loggia (Art. 81 del Regolamento dell’Ordine).
Demone: Essere
spirituale intermedio tra la divinità e gli uomini, su cui esercita influenza buona o
cattiva. Nelle credenze più antiche il D. è qualunque essere divino che appare
d’improvviso all’uomo, o nel sogno o nella solitudine desertica, ed è in tal
senso la personificazione fantastica dell’imprevedibile. Le religioni mesopotamiche
conoscevano già un grande numero di D., oltre ai sette esseri malefici (utukk o udug),
spesso ricordati nei testi magici , e raffigurati come animali; aspetto di D. posseggono
anche le divinità femminili Lamastu e Lilith (febbre e lussuria). In Grecia il D. assume
un’accezione più intellettuale che fisica, specie nei dialoghi di Platone (v.), dove
rappresenta un particolare moto della coscienza , da cui Socrate si diceva guidato come da
un ammonimento divino. Tuttavia nella mitologia greca esistono anche D. mostruosi, come la
Gorgone e l’Idra di Lerna. Presso gli Etruschi il D. è collegato, nelle sue forme
più orride che animalesche (serpente, artigli, becchi d’uccello), con
l’aldilà, rivelandone l’inquietante incertezza che esso ispira al moribondo. D.
malefici (Yast) sono presenti già nei più antichi testi iranici (v. Mazdeismo)
dove due spiriti gemelli si contrappongono (spenta manyu, D. benefico, ed abra
manyu, D. malefico). Da quest’ultimo il manicheismo (v.) trae Ahriman, il male,
eterno nemico di Ahura mazda, il bene. Ahriman venne poi identificato con il diavolo (v.)
nel cristianesimo. La tradizione islamica è ricca di d.; sottomessi ad al-Sailon (od
Iblis), con una numerosa coorte di D. minori (ginn), rappresentati sotto orride forme
(serpente, cane, scorpione). Una complessa magia permetteva di avere ai propri ordini
alcuni di questi ginn. Nell’ebraismo i D. (se’irim, pelosi, cui si
associano anche ‘Aza’zel, il vampiro ‘Aluqah ed altri
serpenti e dragoni), provengono dagli angeli ribelli; il loro capo è Satana (v.), la cui
personalità è illuminata soprattutto dal prologo del libro di Giobbe, dove il D. è
rappresentato nella sua sfida a Dio, e nella sua irritazione di fronte al bene. I D.,
della fede cristiana, illimitati per numero ed abitanti sulla terra e nell’inferno,
sono agi ordini del diavolo o Satana (tentatore), detto anche Lucifero
(luminoso), Belzebù (Signore delle mosche), Belial (grande male) ecc. Per
la loro ribellione a Dio, hanno perduto la Grazia (v.) divina in maniera irreparabile, ma
hanno pur sempre conservato capacità superiori all’umana. Invidiosi degli uomini,
esercitano il loro influsso sul mondo cercando di portare gli uomini al peccato, con le
loro seduzioni e tentazioni. Il Nuovo Testamento è saturo della presenza di Satana. Il
cristianesimo colloca, accanto al regno di dio, un regno del maligno, che tenta di
vanificare l’opera di Gesù Cristo. Y (Iconografia) Particolarmente
ricca l’iconografia demoniaca nella sfera d’ispirazione cristiana. Nel XII
secolo si tende ad accentuare le caratteristiche orride e mostruose del D., unitamente ad
altre caratteristiche umane od animalesche che rivelano la sua perversione. Spesso i D.
furono rappresentati nell’arte paleocristiana e soprattutto medievale, sotto forma di
mostri rivoltanti: esseri ibridi, simili a rospi, come nell’Apocalisse di
Bamberga, cani rabbiosi nel Trionfo della Morte nel cimitero di Pisa, arpie nei
capitelli del duomo di Modena, esseri umani con corpo anguiforme nella chiesa di
Ancy-le-Duc, ecc. In epoca tardo gotica, i D. assunsero aspetto simbolico, magico o
macabro. Nel XIII secolo Duccio di Boninsegna dipinse una tavola, Cristo tentato dal
diavolo (ora nella cappella Frick di New York). Nella chiesa di s. Angelo (Arezzo)
Spinello Aretino (1350-1410) rappresentò le Lotte fra angeli e diavoli. Lo stesso
Michelangelo (1475-1564) ritrasse il diavolo nel Giudizio Universale della Cappella
Sistina. La pittura nord-europea del XV-XVII secolo rivelò il lato grottesco e fantastico
del D. (Bosch e Brueghel); fra i temi più sfruttati è la tentazione di s. Antonio.
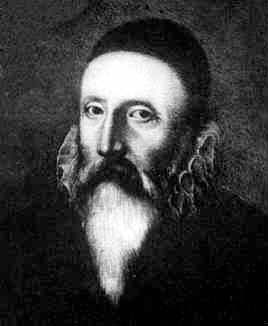 Dee John: Figura dell’Alchimia inglese del XVI secolo (1527-1608). Nacque a Londra il
13.7.1527. Suo padre Roland proveniva da una famiglia piuttosto distinta, e amava
profondamente suo figlio. Rendendosi conto delle sue grandi capacità, lo indirizzò
principalmente allo studio della Letteratura Greca e Latina. Studiò poi a Chelmsford,
nell’Essex, ma poi, avendo completato felicemente il suo curriculum di studi, verso
la fine del 1542 fu iscritto dal padre a Cambridge, nel collegio dedicato alla memoria di
San Giovanni Evangelista, al Corso di Scienze Superiori. A Cambridge D. acquisì una
grande cultura ad un incredibile ritmo, lavorando sui suoi libri e nelle ore di istruzione
individuale fino a diciotto ore al giorno. Nel 1548 ottenne la laurea di Professore
d'Arte, e si recò a Louvain, dove insegnò diritto civile, mentre segretamente si dava
allo studio delle scienze occulte. Nel 1550 lasciò Louvain per completare la sua
istruzione nel continente. La sua fama si diffuse in Europa, ed a 23 anni tenne una
lezione su Euclide all'Università di Parigi, di fronte a un pubblico entusiasta. Grazie
alla sua reputazione di grande filosofo, rimase per due regni al servizio della Corte
Inglese. Nel 1555, sotto il regno di Mary, venne però accusato di aver attentato con arti
magiche alla vita della regina. Venne imprigionato e giudicato prima dalla Camera stellata
di Westminster, che lo prosciolse, e poi da un tribunale ecclesiastico che lo condannò.
Il 29 agosto 1553 la regina Mary lo fece scarcerare. D. lasciò l’insegnamento
pubblico per dedicarsi allo studio delle antichità inglesi, raccogliendo preziosissimi
cimeli. Nel 1558, in occasione dell’ascensione al trono di Elisabetta, secondogenita
di Enrico VIII, D. fu chiamato a corte e fu incaricato di redigere un oroscopo per
accertare la data più favorevole alla sua incoronazione. Annoiato dalla vita di corte,
nel 1563 lasciò di nuovo l’Inghilterra, e viaggiò in Belgio, Germania, Austria ed
Ungheria. Durante il viaggio di ritorno si formò ad Aversa, per terminare la "Monade
geroglifica", che dedicò all’imperatore Massimiliano II (1527-1576). Pochi
suoi lavori sono stati ristampati in tempi moderni, con l'eccezione proprio della Monade
Geroglifica che, fin dalla sua prima apparizione nel 1564 (Monas Hyerogliphica,
Antwerp, 1564), è passato attraverso sei edizioni e si trova ancor oggi nelle librerie.
In quest'opera D. tenta di simbolizzare l'omogeneità dell'Universo e del Creatore, ogni
elemento individuale essendo descritto come componente rapportato alla Monade,
rappresentato come emblema Mercuriale combinato con il punto e il Crescente Binario.
Tornato in Inghilterra, si stabilì a Greenwich, residenza estiva della regina, e si
intrattenne con lei sulla pietra filosofale. Preso nuovamente dal desiderio di viaggiare,
nel 1571 si recò nella Lorena. Ammalatasi la regina Elisabetta, dovette tornare in
Inghilterra. Si stabilì allora Mortlake, sulla riva destra del Tamigi, a otto miglia da
Londra, dove la regina si recava d'estate a respirare aria pura. A Mortlake si sposò, e
per alcuni anni visse tranquillo. Essendogli morta la moglie nel 1575, entrò sempre di
più nelle grazie della regina, che spesso si recava a visitare la sua famosa biblioteca e
le celebri collezioni raccolte. D. nel frattempo si dedicava alla ricerca degli Arcani
della filosofia occulta, e soprattutto allo studio del problema dell'Elisir Filosofico. Al
principio del 1580 si mise in società con un giovane venticinquenne, detto Kelley, per
studiare l'occulto; costui l'accompagnò sempre in tutti i viaggi, e fu cagione delle sue
sventure. Credendo d'essere perseguitato, il 21 settembre 1583, D. fuggì da Mortlake con
la sua seconda moglie Jane Fromond, (sposata il 5 febbraio 1578), con suo figlio Arturo,
allora di quattro anni, con gli altri suoi bambini, con Kelley e sua moglie (sposata in
quello stesso anno) e coi servi, insieme con un tale Alberto di Lasky, nobile Polacco.
Costoro, dopo molte peripezie, sbarcarono a Briel (Olanda), donde si diressero al castello
del Lasky (presso Cracovia), che raggiunsero felicemente il 3 febbraio 1584. D. rimase
soltanto cinque settimane al castello di Lasky. Il 9 marzo del 1584 si recò a Cracovia,
dove continuò le sue operazioni magiche. Dopo un soggiorno di alcuni mesi in quella
città, si rimise in viaggio, e giunse l’8 agosto a Praga, dove Rodolfo II,
imperatore di Germania, teneva una brillantissima corte. D. e Kelley si recarono alla
corte dell’imperatore, ma Rodolfo II dubitò subito della scienza di D. Fu così
costretto a lasciare Praga e, dopo molte peripezie, il 2 aprile 1585 tornò a Cracovia.
Anche a Cracovia le cose non andarono bene: il re Stefano accolse D. alla sua corte, e il
27 maggio del 1585 accettò di partecipare a una seduta magica. Ma quando si trovò
all’atto pratico, si spaventò moltissimo, lasciando da solo D., del quale poi
respinse ogni ulteriore proposta. Verso la fine di luglio del 1585, D. tornò a Praga in
pessime condizioni finanziarie. Là lo attendevano altre traversie. Fu pedinato da un
certo Francesco Pucci, un fiorentino spia del Sant’Uffizio, che su richiesta del
vescovo di Piacenza, nunzio del papa, aveva istruzioni di condurlo a Roma e di bruciarlo
come mago e negromante. D. si salvò grazie all’imperatore, che lo sottrasse al rogo
ma lo bandì dai suoi stati. Un suo allievo, il nobile Guglielmo Ursino, signore di
Rosenberg, burgravio di Boemia, dopo averlo difeso di fronte a Rodolfo II, l’ospitò
nel suo castello di Tresbona. In esso lo sfortunato D. dimorò dal 1586 al 1589. Nel 1589
la regina Elisabetta lo richiamò in patria. Essendo sempre considerato un mago e un
negromante, il D. fu nuovamente veduto di mal occhio dalla corte e dal clero. Il 20 maggio
1595 la regina lo nominò rettore del Christ's College di Manchester, che egli abbandonò
volontariamente nel 1604 per tornare a Mortlake. Dopo la morte di Elisabetta nel 1603, la
vita e la salute di D. si deteriorarono rapidamente. La sua reputazione come mago
continuò ad intralciarlo, e persino al College di Manchester incontrò ostilità. Il
successore della regina, Giacomo I, autore di "Demonologia", in seguito
divenuto il testo dei cacciatori di streghe, lo trattò sfavorevolmente, ma gli permise di
vivere in relativa pace per il resto della sua vita. Morì nel 1608, e fu sepolto nella
Chiesa di Mortlake. Fu uno scrittore prolifico, produsse numerosi libri e manoscritti
lungo l'arco della sua vita. Queste opere coprirono svariati argomenti: le arti, le
scienze e la filosofia furono tutti rappresentanti in ammirevoli ed eruditi dettagli,
alcuni così lunghi e complessi che i tipografi rifiutavano di accettarli. Nel 1570 egli
pubblicò il suo ampiamente acclamato "Introduzione alla matematica" per
l'edizione inglese di "Geometria di Euclide", traduzione di Sir Henry
Billingsley, Londra, 1570, un lavoro di grande originalità ed erudizione, che esercitò
grande influenza sul pensiero scientifico del sedicesimo secolo. A parte i suoi scopi
letterari, fu un prodigioso collezionista di libri. La sua biblioteca contenne circa
tremila volumi e parecchie centinaia di manoscritti, superiore a qualsiasi altra raccolta
nel mondo Elisabettiano. Questi, insieme con un vasto apparato di documenti celtici,
antichi sigilli e genealogie, furono conservati nella sua casa di Mortlake. La casa di
Mortlake ospitò anche la sua collezione di strumenti scientifici: astrolabi, quadranti,
globi, ogni sorta di strumenti ottici e di navigazione stipati nei suoi laboratori. Nella
sua "Vita Joannis Dee" (1707), Thomas Smith descrive il contenuto della
biblioteca di Dee nel seguente modo: "Al nobile contenuto della Biblioteca appartenne
una non moderata accumulazione di strumenti matematici ed apparecchiature, anche quelli
che, a quel tempo, non erano entrati nell'uso comune e quelli che, emendati e riformati
con la propria ingegnosità, aveva riportato ad una migliore condizione, tra cui erano un
quadrante ed un'asta, il cui semidiametro misurava cinque piedi. Di questi, dieci
accuratamente segnati da divisioni, il globo di Mercator, furono corretti e migliorati con
nuove osservazioni. Egli aveva inserito i luoghi e i moti delle comete, che apparivano al
tempo giusto, l'ottavo, il nono e il decimo delle loro sfere, secondo le ipotesi della
teoria di Purbachius, ornati con un orizzonte e una meridiana di ottone. Aveva compassi da
marinaio di vari tipi, fabbricati per trovare la variazione e, infine, una sveglia che, a
quell'epoca, fu considerata quasi un miracolo, adatta a misurare i minuti secondi delle
ore". Dee inventò vari strumenti di navigazione su suo disegno: tra questi un
dispositivo che chiamò Compasso Paradossale, che potrebbe venire adottato per evitare
errori nel tracciare le carte. I marinai, comunque, non si fidarono di questa innovazione
(o, forse, non compresero il complesso principio della sua operazione), ed esso venne
usato raramente. Stranamente, furono i talenti inventivi che per primi risollevarono la
sua reputazione di mago. Nei suoi primi giorni a Cambridge fu il responsabile di una messa
in scena della "Pax" di Aristofane, per la quale egli inventò una blatta
meccanica o Scarabeus, che volò per aria fino al Palazzo di Jupiter, trasportando un uomo
ed un cestello di cibo. Ciò lasciò così meravigliato il pubblico, che era per lo più
ignorante di arti meccaniche, che si sparsero voci ad effetto secondo le quali aveva
compiuto tale meraviglia con l'aiuto dei demoni. Simili credenze superstiziose in seguito
(1583) fecero sì che la casa e la biblioteca di Dee fossero frugate da una moltitudine di
gente mentre lui e la sua famiglia viaggiavano nel Continente. Tra le sue opere alchemiche
ricordiamo: La Monade Geroglifica (1564) (La Monade Geroglifica, Arktos,
Carmagnola, 1981); Liber Mysteriorum I - V; Trattato Magico; De Heptarchia
Mystica (1582) (De Heptarchia Mystica, Atanor 1986) e molti pregevoli manoscritti.
Dee John: Figura dell’Alchimia inglese del XVI secolo (1527-1608). Nacque a Londra il
13.7.1527. Suo padre Roland proveniva da una famiglia piuttosto distinta, e amava
profondamente suo figlio. Rendendosi conto delle sue grandi capacità, lo indirizzò
principalmente allo studio della Letteratura Greca e Latina. Studiò poi a Chelmsford,
nell’Essex, ma poi, avendo completato felicemente il suo curriculum di studi, verso
la fine del 1542 fu iscritto dal padre a Cambridge, nel collegio dedicato alla memoria di
San Giovanni Evangelista, al Corso di Scienze Superiori. A Cambridge D. acquisì una
grande cultura ad un incredibile ritmo, lavorando sui suoi libri e nelle ore di istruzione
individuale fino a diciotto ore al giorno. Nel 1548 ottenne la laurea di Professore
d'Arte, e si recò a Louvain, dove insegnò diritto civile, mentre segretamente si dava
allo studio delle scienze occulte. Nel 1550 lasciò Louvain per completare la sua
istruzione nel continente. La sua fama si diffuse in Europa, ed a 23 anni tenne una
lezione su Euclide all'Università di Parigi, di fronte a un pubblico entusiasta. Grazie
alla sua reputazione di grande filosofo, rimase per due regni al servizio della Corte
Inglese. Nel 1555, sotto il regno di Mary, venne però accusato di aver attentato con arti
magiche alla vita della regina. Venne imprigionato e giudicato prima dalla Camera stellata
di Westminster, che lo prosciolse, e poi da un tribunale ecclesiastico che lo condannò.
Il 29 agosto 1553 la regina Mary lo fece scarcerare. D. lasciò l’insegnamento
pubblico per dedicarsi allo studio delle antichità inglesi, raccogliendo preziosissimi
cimeli. Nel 1558, in occasione dell’ascensione al trono di Elisabetta, secondogenita
di Enrico VIII, D. fu chiamato a corte e fu incaricato di redigere un oroscopo per
accertare la data più favorevole alla sua incoronazione. Annoiato dalla vita di corte,
nel 1563 lasciò di nuovo l’Inghilterra, e viaggiò in Belgio, Germania, Austria ed
Ungheria. Durante il viaggio di ritorno si formò ad Aversa, per terminare la "Monade
geroglifica", che dedicò all’imperatore Massimiliano II (1527-1576). Pochi
suoi lavori sono stati ristampati in tempi moderni, con l'eccezione proprio della Monade
Geroglifica che, fin dalla sua prima apparizione nel 1564 (Monas Hyerogliphica,
Antwerp, 1564), è passato attraverso sei edizioni e si trova ancor oggi nelle librerie.
In quest'opera D. tenta di simbolizzare l'omogeneità dell'Universo e del Creatore, ogni
elemento individuale essendo descritto come componente rapportato alla Monade,
rappresentato come emblema Mercuriale combinato con il punto e il Crescente Binario.
Tornato in Inghilterra, si stabilì a Greenwich, residenza estiva della regina, e si
intrattenne con lei sulla pietra filosofale. Preso nuovamente dal desiderio di viaggiare,
nel 1571 si recò nella Lorena. Ammalatasi la regina Elisabetta, dovette tornare in
Inghilterra. Si stabilì allora Mortlake, sulla riva destra del Tamigi, a otto miglia da
Londra, dove la regina si recava d'estate a respirare aria pura. A Mortlake si sposò, e
per alcuni anni visse tranquillo. Essendogli morta la moglie nel 1575, entrò sempre di
più nelle grazie della regina, che spesso si recava a visitare la sua famosa biblioteca e
le celebri collezioni raccolte. D. nel frattempo si dedicava alla ricerca degli Arcani
della filosofia occulta, e soprattutto allo studio del problema dell'Elisir Filosofico. Al
principio del 1580 si mise in società con un giovane venticinquenne, detto Kelley, per
studiare l'occulto; costui l'accompagnò sempre in tutti i viaggi, e fu cagione delle sue
sventure. Credendo d'essere perseguitato, il 21 settembre 1583, D. fuggì da Mortlake con
la sua seconda moglie Jane Fromond, (sposata il 5 febbraio 1578), con suo figlio Arturo,
allora di quattro anni, con gli altri suoi bambini, con Kelley e sua moglie (sposata in
quello stesso anno) e coi servi, insieme con un tale Alberto di Lasky, nobile Polacco.
Costoro, dopo molte peripezie, sbarcarono a Briel (Olanda), donde si diressero al castello
del Lasky (presso Cracovia), che raggiunsero felicemente il 3 febbraio 1584. D. rimase
soltanto cinque settimane al castello di Lasky. Il 9 marzo del 1584 si recò a Cracovia,
dove continuò le sue operazioni magiche. Dopo un soggiorno di alcuni mesi in quella
città, si rimise in viaggio, e giunse l’8 agosto a Praga, dove Rodolfo II,
imperatore di Germania, teneva una brillantissima corte. D. e Kelley si recarono alla
corte dell’imperatore, ma Rodolfo II dubitò subito della scienza di D. Fu così
costretto a lasciare Praga e, dopo molte peripezie, il 2 aprile 1585 tornò a Cracovia.
Anche a Cracovia le cose non andarono bene: il re Stefano accolse D. alla sua corte, e il
27 maggio del 1585 accettò di partecipare a una seduta magica. Ma quando si trovò
all’atto pratico, si spaventò moltissimo, lasciando da solo D., del quale poi
respinse ogni ulteriore proposta. Verso la fine di luglio del 1585, D. tornò a Praga in
pessime condizioni finanziarie. Là lo attendevano altre traversie. Fu pedinato da un
certo Francesco Pucci, un fiorentino spia del Sant’Uffizio, che su richiesta del
vescovo di Piacenza, nunzio del papa, aveva istruzioni di condurlo a Roma e di bruciarlo
come mago e negromante. D. si salvò grazie all’imperatore, che lo sottrasse al rogo
ma lo bandì dai suoi stati. Un suo allievo, il nobile Guglielmo Ursino, signore di
Rosenberg, burgravio di Boemia, dopo averlo difeso di fronte a Rodolfo II, l’ospitò
nel suo castello di Tresbona. In esso lo sfortunato D. dimorò dal 1586 al 1589. Nel 1589
la regina Elisabetta lo richiamò in patria. Essendo sempre considerato un mago e un
negromante, il D. fu nuovamente veduto di mal occhio dalla corte e dal clero. Il 20 maggio
1595 la regina lo nominò rettore del Christ's College di Manchester, che egli abbandonò
volontariamente nel 1604 per tornare a Mortlake. Dopo la morte di Elisabetta nel 1603, la
vita e la salute di D. si deteriorarono rapidamente. La sua reputazione come mago
continuò ad intralciarlo, e persino al College di Manchester incontrò ostilità. Il
successore della regina, Giacomo I, autore di "Demonologia", in seguito
divenuto il testo dei cacciatori di streghe, lo trattò sfavorevolmente, ma gli permise di
vivere in relativa pace per il resto della sua vita. Morì nel 1608, e fu sepolto nella
Chiesa di Mortlake. Fu uno scrittore prolifico, produsse numerosi libri e manoscritti
lungo l'arco della sua vita. Queste opere coprirono svariati argomenti: le arti, le
scienze e la filosofia furono tutti rappresentanti in ammirevoli ed eruditi dettagli,
alcuni così lunghi e complessi che i tipografi rifiutavano di accettarli. Nel 1570 egli
pubblicò il suo ampiamente acclamato "Introduzione alla matematica" per
l'edizione inglese di "Geometria di Euclide", traduzione di Sir Henry
Billingsley, Londra, 1570, un lavoro di grande originalità ed erudizione, che esercitò
grande influenza sul pensiero scientifico del sedicesimo secolo. A parte i suoi scopi
letterari, fu un prodigioso collezionista di libri. La sua biblioteca contenne circa
tremila volumi e parecchie centinaia di manoscritti, superiore a qualsiasi altra raccolta
nel mondo Elisabettiano. Questi, insieme con un vasto apparato di documenti celtici,
antichi sigilli e genealogie, furono conservati nella sua casa di Mortlake. La casa di
Mortlake ospitò anche la sua collezione di strumenti scientifici: astrolabi, quadranti,
globi, ogni sorta di strumenti ottici e di navigazione stipati nei suoi laboratori. Nella
sua "Vita Joannis Dee" (1707), Thomas Smith descrive il contenuto della
biblioteca di Dee nel seguente modo: "Al nobile contenuto della Biblioteca appartenne
una non moderata accumulazione di strumenti matematici ed apparecchiature, anche quelli
che, a quel tempo, non erano entrati nell'uso comune e quelli che, emendati e riformati
con la propria ingegnosità, aveva riportato ad una migliore condizione, tra cui erano un
quadrante ed un'asta, il cui semidiametro misurava cinque piedi. Di questi, dieci
accuratamente segnati da divisioni, il globo di Mercator, furono corretti e migliorati con
nuove osservazioni. Egli aveva inserito i luoghi e i moti delle comete, che apparivano al
tempo giusto, l'ottavo, il nono e il decimo delle loro sfere, secondo le ipotesi della
teoria di Purbachius, ornati con un orizzonte e una meridiana di ottone. Aveva compassi da
marinaio di vari tipi, fabbricati per trovare la variazione e, infine, una sveglia che, a
quell'epoca, fu considerata quasi un miracolo, adatta a misurare i minuti secondi delle
ore". Dee inventò vari strumenti di navigazione su suo disegno: tra questi un
dispositivo che chiamò Compasso Paradossale, che potrebbe venire adottato per evitare
errori nel tracciare le carte. I marinai, comunque, non si fidarono di questa innovazione
(o, forse, non compresero il complesso principio della sua operazione), ed esso venne
usato raramente. Stranamente, furono i talenti inventivi che per primi risollevarono la
sua reputazione di mago. Nei suoi primi giorni a Cambridge fu il responsabile di una messa
in scena della "Pax" di Aristofane, per la quale egli inventò una blatta
meccanica o Scarabeus, che volò per aria fino al Palazzo di Jupiter, trasportando un uomo
ed un cestello di cibo. Ciò lasciò così meravigliato il pubblico, che era per lo più
ignorante di arti meccaniche, che si sparsero voci ad effetto secondo le quali aveva
compiuto tale meraviglia con l'aiuto dei demoni. Simili credenze superstiziose in seguito
(1583) fecero sì che la casa e la biblioteca di Dee fossero frugate da una moltitudine di
gente mentre lui e la sua famiglia viaggiavano nel Continente. Tra le sue opere alchemiche
ricordiamo: La Monade Geroglifica (1564) (La Monade Geroglifica, Arktos,
Carmagnola, 1981); Liber Mysteriorum I - V; Trattato Magico; De Heptarchia
Mystica (1582) (De Heptarchia Mystica, Atanor 1986) e molti pregevoli manoscritti.