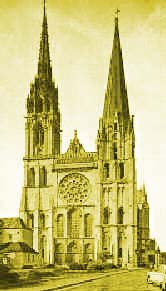Carpocraziani:
Settari gnostici del II secolo d.C.. la cui origine viene fatta risalire
a Carpocrate, vissuto in Alessandria
ai tempi di Adriano, e che avrebbe fondato la chiesa C. insieme al figlio Epifane.
Secondo i C. il mondo non sarebbe opera del padre increato, ma di demoni
inferiori a lui. La liberazione, o salvezza gnostica, si opera allorché
l'anima, prigioniera nella materia, si riscatta con la sua evoluzione,
risalendo così al Padre. Tale riscatto si realizza secondo il modello di Gesù,
che è Salvatore, ma uomo eguale ad ogni altro uomo. Le anime sono in condizione
di risalire al Padre solo quando siano passate attraverso tutte le esperienze
morali ed immorali del mondo, il che può avvenire in una sola vita od in più
vite successive, attraverso la metempsicosi (v.). I C. ripudiano la legge
naturale e quella giudaica, in quanto legate alla materia.
Cartesio: Nome italianizzato di Descartes (v.) René, derivato dal latino Cartesius,
filosofo, matematico e fisico francese (1596-1650).
 Cartiglio:
Fregio decorativo, per lo più rappresentante una carta svolta,
per apporvi iscrizioni esplicative. Il termine identifica soprattutto il fregio
identificativo degli antichi faraoni: era costituito da un’area circoscritta in un
perimetro oblungo, in cui venivano impressi i geroglifici con il nominativo del
personaggio. È attraverso il C. che gli egittologi identificano monumenti o figure, come
gli oggetti dei quali identificano il proprietario. Spesso il C. era impresso
all’ingresso delle tombe sepolcrali, per cui l’archeologo sapeva a chi era stato
dedicato quel luogo ancora prima di accedervi per la ricerca di eventuali reperti
eventualmente lasciati dai millenari predatori di preziosi.
Cartiglio:
Fregio decorativo, per lo più rappresentante una carta svolta,
per apporvi iscrizioni esplicative. Il termine identifica soprattutto il fregio
identificativo degli antichi faraoni: era costituito da un’area circoscritta in un
perimetro oblungo, in cui venivano impressi i geroglifici con il nominativo del
personaggio. È attraverso il C. che gli egittologi identificano monumenti o figure, come
gli oggetti dei quali identificano il proprietario. Spesso il C. era impresso
all’ingresso delle tombe sepolcrali, per cui l’archeologo sapeva a chi era stato
dedicato quel luogo ancora prima di accedervi per la ricerca di eventuali reperti
eventualmente lasciati dai millenari predatori di preziosi.
Case
dei Pianeti:
Termine impiegato nell'Astrologia (v.) per definire i luoghi nei quali
si trovano i Pianeti del sistema solare, e dai quali emanano le diverse
influenze sugli esseri umani. L'oroscopo astrologico si ottiene mettendo in
corrispondenza Ariete-Casa 1, Toro-Casa 2, ecc. Il significato delle dodici C.
può essere ricapitolato così: ·
Casa 1) l'individuo sul piano psicologico e le sue tendenze di fondo; ·
Casa 2) le sue acquisizioni, fortuna ed affari; casa ·
3) i suoi rapporti col prossimo, l'educazione, gli spostamenti e la
corrispondenza; ·
Casa 4) le sue origini, la sua casa, i beni immobiliari e gli eredi; ·
Casa 5) gli svaghi, i figli, gli amori, le speculazioni e le occasioni; ·
Casa 6) il suo lavoro, i suoi obblighi e la salute; ·
Casa 7) il mondo complementare ed opposto, il matrimonio, le amicizie, le
associazioni e la vita pubblica; ·
Casa 8) morte ed eredità, cambiamenti, inconscio e ferite; ·
Casa 9) vita spirituale, grandi viaggi e sogni; ·
Casa 10) onori, ambizione e vita sociale; ·
Casa 11) amicizie, protezioni e speranze; ·
Casa 12) prove, insuccessi, malattie, desideri repressi, nemici segreti ed
imprevisti (Guida all'Occultismo di J. Tondriau, Ediz. Sugar, Milano, 1975).
Caso: Il caso non esiste. È solo il nome che si sa dare ad una legge che non si conosce (Sesto Principio di Thoth-Hermes).
Cartomanzia: Nome derivato dal termine greco manteia composto con carta, a
significare il metodo di divinazione con le carte normali da gioco, quelle dei Tarocchi
(v.), o di tipo creato espressamente per questo scopo. La C. si basa sull'interpretazione
del seme ( le carte di cuori e fiori sono apportatrici di bene, quelle di picche
annunciano avversità e lutti, quelle di quadri sono neutrali), del colore, del numero e
della figura di ogni carta. Mentre alcuni ne attribuiscono le origini agli Arabi, altri la
fanno risalire al XIV secolo, sostenendo che sia stata inventata per divertire Carlo VI di
Francia durante la sua follìa. Il primo trattato sul modo di leggere le carte pare sia
stato quello pubblicato in Francia nel 1770 da un certo Alliette, di professione
parrucchiere. La C. ebbe grande fortuna in Francia, verso la fine del XVIII secolo, tanto
che la cartomante mademoiselle Lenormant divenne la confidente di Giuseppina Bonaparte, e
quindi anche di Napoleone.
Casta: Nome derivato dal latino castus, puro, attraverso il portoghese casta, con cui vollero rendere due
diversi termini sanscriti varna, colore, e jati, razza. Indica pertanto una
classe di persone che godono di determinati privilegi, e che ad essa appartengono per
esclusivo diritto di nascita. Le C. erano presenti presso gli antichi Egiziani e gli
Ebrei, ma anche in Grecia a designazione dei discendenti di Esculapio, dediti
all’arte medica per diritto esclusivo. Le C. trovarono però piena applicazione tra
gli Arya dell’India. Dove fin dai tempi vedici, inizialmente per distinguere i
conquistatori arya dai vinti indigeni, si imposero quattro C. separate da norme
rigorosissime: · i brahman (v.), dotti e sacerdoti; · i ksatriya, guerrieri e nobiltà terriera; · i vaisya (o baniya), commercianti ed agricoltori; · i sudra, lavoratori in generale, estromessi da templi e
scuole. Al di sotto di questi stavano i paria, i fuori C. (candala, misala,
ecc.), nati da matrimoni misti. Sedersi alla stessa tavola, mangiare un cibo preparato da
un individuo di C. inferiore, erano azioni rigorosamente coperte da inesorabile "tabù".
Era interdetto perfino l’uso intercastale della stessa acqua. Sia il buddhismo che
l’islamismo attenuarono il rigore della suddivisione castale, ma con scarsi e solo
temporanei risultati. Soltanto nel XIX secolo l’opera riformistica anticastale del
Brahmo Samaj diede quei frutti che portarono alla definitiva abolizione delle C. nella
Costituzione indiana del 1947, e nello speciale decreto del 1950. Tuttavia le C.
sopravvivono ancora larvatamente nell’intero ambiente rurale indiano. La Biologia
impiega questo termine per distinguere le funzioni svolte da gruppi di taluni insetti
nell’ambito dell’ambiente in cui vivono ed operano, per esempio le api, le
vespe, le formiche e le termiti.
Casualismo: Termine indicante tutti gli indirizzi filosofici che negano la concezione finalistica, e contrappongono all’ordine razionale del mondo un ordine derivato da combinazioni accidentali, casuali, o comunque soltanto probabili. Già l’atomismo greco antico fornisce un esempio di C., mentre un altro esempio può essere considerato l’evoluzionismo moderno. Il rapporto tra caso e natura, per cui la stessa determinazione finalistica è un caso, è presente in molta parte della riflessione contemporanea sul mondo naturale.
Catacomba:
Dal greco cata cumbz, presso le
grotte, e dal tardo latino catacumba, in origine designava l’area della via
Appia compresa tra l’attuale chiesa di San Sebastiano e la tomba di Cecilia Metella.
È qui che è ubicato uno tra i più antichi cimiteri sotterranei cristiani di Roma, usato
dal I al IV secolo d.C. e denominato ad catacumbas. Nel Medioevo tale nome venne
esteso ad ogni cimitero sotterraneo in altre parti dell’Impero romano. Sono note C.
sparse in tutta Italia e nel bacino del Mediterraneo. Solo a Roma ne è però possibile
l’esplorazione approfondita, grazie all’elevato numero di C. rimaste. Si
estendevano per oltre 100 km., con un totale di 500-750 mila tombe. Situate quasi sempre
fuori dalle mura cittadine, utilizzando spesso grotte o cavità naturali, oppure cave
abbandonate, le C. sono di solito costituite da un ingresso all’aperto visibile,
senza caratteristiche particolari, da un atrio con panche di marmo, e da una serie di
gallerie (criptae) dal tracciato irregolare che segue la conformazione del suolo,
con pareti ricurve rafforzate da mattoni. In terreni pianeggianti si scende fino ad otto
metri sotto il livello del suolo, per mezzo di scale da cui si dipartono varie gallerie,
larghe mediamente 80-90 cm. ed alte circa 2,50 metri. Alle C. situate in terreni ondulati
si accede di solito da una prima galleria più elevata, cui seguono le altre. Nel III e IV
secolo l’andamento delle gallerie si fa poi più regolare e rettilineo. Lungo le
pareti erano disposte le tombe (loci o loculi), a gruppi di quattro o cinque
sovrapposti (pila), con il lato lungo a vista. I margini erano formati da un bordo
incavato per la lastra di marmo od i mattoni, che fungevano da chiusura. Talvolta le
lastre erano ricoperte da uno spesso strato di malta, su cui venivano incise iscrizioni.
Un altro tipo di tomba, piuttosto raro, è quello detto ad arcosolio (v.). Ogni
tanto, senza intervalli regolari, le gallerie si aprono sui cubicola, camere a
pianta quadrata o rettangolare, a volta centrale e absidata, destinate alla tomba di un
martire, o contenenti le tombe di qualche famiglia ricca o di qualche associazione. La
copertura dei cubicoli era per lo più piana, raramente a volta, poggiante su rinforzi
posti agli angoli, in mattoni, in marmo od in tufo; in essa si aprono lucernari (luminaria)
per l’illuminazione. Le C. più antiche hanno anche sale per i banchetti funebri. Nei
primi due secoli esistevano cimiteri all’aperto, soprattutto sulle vie Aureliana
ostiense, Appia ed Ardeatina, poi vennero costruite C. sotto i mausolei di grandi
famiglie, in territorio privato che veniva donato per la tomba di un martire, intorno al
quale altri fedeli chiedevano di essere sepolti. Contrariamente a quanto si crede, le C,
erano protette dalle leggi romane, in quanto risultavano essere tombe di associazioni o collegia
di poveri, di schiavi che cercavano di evitare la sepoltura comune. Non è neanche vero
che le C. servissero da rifugio ai cristiani durante le persecuzioni, cosicché ha solo
valore indicativo l’espressione "chiesa delle C.", usata per designare i
primi secoli della Chiesa cristiana. Dopo l’editto di Costantino (313), prevalse
l’uso di seppellire i morti all’aperto, accanto alle chiese, ma le C. rimasero,
ed alcune vennero addirittura ampliate. Durante l’VIII secolo le incursioni
longobarde distrussero le ultime C. ancora in uso, e le altre caddero presto in totale
abbandono. Le esplorazioni delle C. iniziarono nel XVI secolo, intensificandosi dal 1578
dopo la scoperta del cimitero di Priscilla.
 Catari: Nome con il quale sono indicate alcune sette ereticali dualiste, di probabile origine balcanica (Bulgaria) all'inizio del XII secolo. La dottrina dei C. subì l'influenza diretta dei Bogomili, e quella indiretta dell'antico manicheismo e della gnostica. Si diffusero poi nell'Europa occidentale, assumendo diverse denominazioni: nella Renania, in Francia (Albigesi v.), in Inghilterra ed in Alta Italia (patarini e concorrezzesi), tanto che nel 1167 poté essere tenuto il loro primo concilio a Tolosa. In seguito si ebbero anche neomanichei, apostolici, pauliciani, bulgari, ecc. La lotta organica e spietata della Chiesa contro i C. iniziò con la costituzione Ad abolendam del
1184 di Lucio III, di comune accordo con Federico Barbarossa. L'Inquisizione, istigata da
Innocenzo III, s'incaricò del loro sterminio definitivo, culminante nel 1209 con la
crociata contro gli Albigesi (v.), che a Beziers (Francia meridionale) vide il massacro di
settemila fra donne, vecchi e bambini, e l'incendio della città e della stessa
cattedrale. Nel 1129 a Parigi venne consacrata con un trattato la vittoria della Chiesa di
Roma e dell'Inquisizione, grazie anche all'aiuto armato fornito dal 1126 dal re di Francia
Luigi VII il Giovane. Tuttavia i C. sopravvissero in Francia fino al XIV secolo, ed in
Italia fino all'inizio del XV (v. Montsegur). La dottrina dei C. è caratterizzata da un
rigoroso dualismo: a Dio (il bene) si contrappone il Demonio (il male), creatore del mondo
materiale; le anime degli uomini sono angeli decaduti. I C. rifiutavano l'Antico
Testamento, poiché Dio vi appare come creatore della materia, la gerarchia della Chiesa,
i sacramenti, il matrimonio (e la procreazione in generale), il prestar giuramento, alcuni
cibi (carne, uova e latticini), la proprietà privata, l’acquisto di ricchezze, il
commercio per fini di lucro, mentireb per interesse, fare la guerra, uccidere animali che
non fossero rettili, il Purgatorio. Per i C. Cristo non possiede corpo fisico poichè egli
è un angelo in sembianze umane (docetismo). Ideale dei C. è la endura, cioè il
lasciarsi morire di fame od in altro modo purché violento. Si distinguevano in perfetti
che, dopo un anno di dure prove ascetiche, ricevevano il consolamentum, con
l'imposizione delle mani, avente valore battesimale, ed in credenti, che seguivano
la dottrina pur restando nel mondo, e ricevevano il consolamentum solo in punto di
morte, dato che un'eventuale infedeltà non comportava possibilità di remissione. La
pratica religiosa dei C. consisteva unicamente di preghiere e di prediche. Il loro unico
Libro Sacro era il Vangelo secondo Giovanni.
Catari: Nome con il quale sono indicate alcune sette ereticali dualiste, di probabile origine balcanica (Bulgaria) all'inizio del XII secolo. La dottrina dei C. subì l'influenza diretta dei Bogomili, e quella indiretta dell'antico manicheismo e della gnostica. Si diffusero poi nell'Europa occidentale, assumendo diverse denominazioni: nella Renania, in Francia (Albigesi v.), in Inghilterra ed in Alta Italia (patarini e concorrezzesi), tanto che nel 1167 poté essere tenuto il loro primo concilio a Tolosa. In seguito si ebbero anche neomanichei, apostolici, pauliciani, bulgari, ecc. La lotta organica e spietata della Chiesa contro i C. iniziò con la costituzione Ad abolendam del
1184 di Lucio III, di comune accordo con Federico Barbarossa. L'Inquisizione, istigata da
Innocenzo III, s'incaricò del loro sterminio definitivo, culminante nel 1209 con la
crociata contro gli Albigesi (v.), che a Beziers (Francia meridionale) vide il massacro di
settemila fra donne, vecchi e bambini, e l'incendio della città e della stessa
cattedrale. Nel 1129 a Parigi venne consacrata con un trattato la vittoria della Chiesa di
Roma e dell'Inquisizione, grazie anche all'aiuto armato fornito dal 1126 dal re di Francia
Luigi VII il Giovane. Tuttavia i C. sopravvissero in Francia fino al XIV secolo, ed in
Italia fino all'inizio del XV (v. Montsegur). La dottrina dei C. è caratterizzata da un
rigoroso dualismo: a Dio (il bene) si contrappone il Demonio (il male), creatore del mondo
materiale; le anime degli uomini sono angeli decaduti. I C. rifiutavano l'Antico
Testamento, poiché Dio vi appare come creatore della materia, la gerarchia della Chiesa,
i sacramenti, il matrimonio (e la procreazione in generale), il prestar giuramento, alcuni
cibi (carne, uova e latticini), la proprietà privata, l’acquisto di ricchezze, il
commercio per fini di lucro, mentireb per interesse, fare la guerra, uccidere animali che
non fossero rettili, il Purgatorio. Per i C. Cristo non possiede corpo fisico poichè egli
è un angelo in sembianze umane (docetismo). Ideale dei C. è la endura, cioè il
lasciarsi morire di fame od in altro modo purché violento. Si distinguevano in perfetti
che, dopo un anno di dure prove ascetiche, ricevevano il consolamentum, con
l'imposizione delle mani, avente valore battesimale, ed in credenti, che seguivano
la dottrina pur restando nel mondo, e ricevevano il consolamentum solo in punto di
morte, dato che un'eventuale infedeltà non comportava possibilità di remissione. La
pratica religiosa dei C. consisteva unicamente di preghiere e di prediche. Il loro unico
Libro Sacro era il Vangelo secondo Giovanni.
Catechesi:
Termine indicante l'azione d'insegnamento del catechismo (v.).
Catechismo:
Termine derivato dal tardo greco cathcismoz,
da cathcew, istruire a viva voce, che definisce un breve compendio delle verità
fondamentali della fede e della morale cristiana, espresse in modo semplice e
comprensibile, sotto forma di dialogo. In origine consisteva in una serie di
domande rivolte dal sacerdote ai battezzandi nell'atrio della chiesa: «Ante
Baptistum fit catechismus et exorcismus» (Pietro Lombardo,
Sententiae 1, 43). Quando si battezzarono anche i bambini, la Chiesa volle
realizzare un mezzo d'istruzione pratico ed uniforme, e nacquero così i primi
manuali. Tra i più antichi va ricordata la Disputatio
puerorum per interrogationes et responsiones, dei tempi di Alcuino
(735-804). Nel XIII secolo apparvero i lucidari (Elucidarium
sive dialogus de summa christianae theologiae), cui seguirono i settenari,
messi in voga da Ugo di San Vittore (De
quinque septenis, seu septenariis). Alla diffusione contribuì ovviamente
l'invenzione della stampa. Lutero (v.) nel 1529 pubblicò un piccolo C. (Der
kleine Katechismus) per i fanciulli semplici, con il sottotitolo Enchiridion,
ed un'edizione maggiore (Der grosse
Katechismus) destinata ai parroci e redatta in forma viva e scorrevole.
Anche Calvino (v.) pubblicò nel 1535 De
christianae religionis institutione libri tres, che divenne il C. dei
riformati francesi. La volontà di contrastare questi C. protestanti suggerì
analoghe iniziative in campo cattolico. Il domenicano fra Tommaso Reginaldo nel
1540 stampò a Milano il Simbolo de
Athanasio exposto per modo de dialogo e, pochi anni dopo, San Pietro Canisio
pubblicava a Vienna
(1555) la Summa doctrinae
christianae, detto C. maggiore, che ebbe grande diffusione. Il Concilio di
Trento (v.) nominò un'apposita commissione sotto la direzione di San Carlo
Borromeo, la quale nel 1566 pubblicò il Catechismus
romanus. Un altro celebre C. italiano fu redatto da Mons. Casati, vescovo di
Mondovì (1765), ed ebbe vasta diffusione tra la fine del XIX secolo e gli inizi
del XX. Nel 1913 papa Pio X emanò un C. universale per i fanciulli, ma opera
veramente notevole fu il Catechismus
catholicus (1932) del Card. Gasparri, segretario di stato di Pio XI,
suddiviso in tre parti: bambini, giovani ed adulti, che però non venne mai
approvato ufficialmente. Dopo il Concilio Vaticano II grande notorietà ebbe il
C. olandese: «Il nuovo C., un annuncio
della fede per gli adulti» (1966), composto da teologi di fama mondiale,
esplicitamente approvato da tutti i vescovi olandesi ma violentemente osteggiato
da Roma, che dapprima volle censurarne alcune parti, poi tentò di vietarne la
traduzione in altre lingue. L'opera incontrò un successo enorme, sia nel
testo originale sia nelle traduzioni in tedesco, in francese, in inglese ed in
italiano. Anche il problema dell'insegnamento catechistico (catechesi)
fu oggetto di preoccupato interesse attraverso i secoli della storia della
Chiesa. Con l'organizzazione del catecumenato (v.) cristiano, la catechesi
assume un significato più ristretto, e si applica all'insegnamento orale per
il battesimo (v.). Con il prevalere del battesimo impartito ai bambini, essa
assunse un significato apologetico, in confutazione al paganesimo ed al
giudaismo. Nel Medioevo si confondeva con l'istruzione religiosa impartita sia
in seno alla famiglia sia nelle scuole ecclesiastiche. Con la decadenza di
questa istruzione religiosa la necessità di una catechesi fu sentita, tanto
dalla chiesa cattolica quanto da quella riformata. Si realizzò così una forma
di catechesi orale itinerante, sia da parte di ordini religiosi sia da parte di
protestanti. Dopo il Concilio di Trento, la catechesi cattolica assunse una
caratteristica essenzialmente polemica antiprotestante. Intanto le nuove
scoperte geografiche offrivano ai missionari nuove terre in cui la catechesi
riprendeva l'antica caratteristica prebattesimale, dove l'istruzione
religiosa doveva conformarsi alle esigenze di popolazioni diverse , che spesso
possedevano tradizioni spirituali di altissimo valore. Nella legislazione
moderna della Chiesa, la catechesi è regolata da apposite disposizioni del
Codice di Diritto canonico, e dall'enciclica Acerbo nimis, di Pio X (1905), che è la «magna charta» dell'insegnamento catechistico attuale. Pio XI con
il motu proprio Orbem catholicum (1923)
costituì, presso la Congregazione del Concilio, l'Ufficio catechistico, che
gestisce tutte le opere catechistiche della Chiesa.
Catecumenato: Termine derivato dal greco cathcew, insegnare a viva voce.
Indica il periodo di preparazione che, nella Chiesa antica (come ancora oggi nelle
missioni), precedeva il battesimo. La sua etimologia indica come la base del C. sia la
formazione dottrinale. Verso il IV secolo invalse l’uso di conferire il battesimo il
giorno di Pasqua; perciò il periodo del C. venne regolato sia nel tempo (che la
Costituzione egiziana fissava in tre anni) sia nell’indicazione dei riti preparatori.
I catecumeni erano divisi in audientes (uditori), che dovevano ricevere una
semplice istruzione verbale, ed in competentes od illuminati (già
dottrinalmente formati), che erano ammessi ai riti di iniziazione al battesimo: gli esorcismi
(le rinunce a Satana ed alle sue opere) e gli scrutini (le promesse relative al
vivere cristianamente). Nella domenica delle palme veniva consegnata solennemente la
formula del Credo (traditio Symboli), seguita dalla consegna dei Vangeli (aperitio
aurium) e del Pater Noster. Con il diffondersi del battesimo infantile, questi riti
vennero incorporati nella liturgia battesimale, e vengono tuttora assolti dai padrini.
Catecumeni: Termine designante coloro che seguono il Catecumenato (v.).
Catena: La Massoneria definisce C. d’Amore od Iniziatica il supporto ottenuto dalla
formazione di un cerchio, incrociando le braccia e stringendo le mani dei Fratelli vicini.
Occorre perfezionare i punti di contatto magnetico toccandosi reciprocamente le punte dei
piedi. Essa si propone di generare una sottile corrente energetica, tale da attrarre le
influenze superiori (v. Eggregoro) e rafforzare spiritualmente i componenti della C. Viene
solitamente formata per comunicare le parole semestrali di riconoscimento notificate dal
G.O.I., oppure per indirizzare ad un fine predefinito l’energia risultante verso una
persona od una finalità sociale. Può essere di tipo aperto, con le braccia semplicemente
allargate, in genere usato nelle obbedienze nordiche od alla presenza di profani, e di
tipo chiuso, con le braccia incrociate, braccio sinistro posto sopra il braccio destro,
nelle obbedienze mediterranee. Viene formata su espresso invito del Maestro Venerabile, e
sciolta su comando dello stesso. La C. ricorda che tutti i Massoni formano un’unica,
grande famiglia, indipendentemente dalla razza, dalla lingua e dal ceto. Secondo il De
Guaita, "il significato segreto della C. va ricercato in un Assioma, in cui
i termini principali sono: creare un punto fisso su cui appoggiarsi, stabilirvi la
Batteria (v.) psicodinamica e, da quel punto, scelto come centro, far risplendere
attraverso il mondo la luce astrale, costretta da una volontà di natura spirituale
nettamente definita".
Catene: Secondo il Troisi (Dizionario Massonico), "ornano il capitello delle Colonne del Tempio
massonico, a simboleggiare che colui il quale è prigioniero delle cose terrene non può
avere accesso alla sacralità del tempio. Le C. sono il simbolo del legame tra il Cielo e
la terra, dell’unione e della comunicazione" (v. Cordone).
Catenoteismo:
Termine coniato da M. Müller, dal significato di «un
teismo alla volta». Viene riferito alla religione dei Veda (v.), per la
quale ciascun dio governa a turno il mondo, senza che ciò implichi la negazione
degli altri dei.
Catilina: Lucio Sergio (dal latino Lucius Sergius Catilina), uomo politico romano (108-62 a.C.). Di nobile
anche se non illustre famiglia, combatté con Pompeo Strabone (91-87 a.C.), ed in seguito
fu luogotenente di Silla. Nel 68 ottenne la pretura, dopo la quale governò per due anni
le province d’Africa. Al ritorno venne accusato di concussione, il che gli impedì di
candidarsi alle elezioni consolari del 65 e del 64. In quegli anni abbandonò in
circostanze molto oscure (i suoi avversari parlarono vagamente di una prima congiura)il
partito aristocratico. Alle successive elezioni del 63 si presentò sostenuto dai
principali capi democratici, Crasso e Cesare in testa. Sconfitto da Cicerone (v.), andò
radicalizzando sempre più la propria politica, prendendosi cura degli interessi degli
strati più inquieti della popolazione, come ex contadini espropriati, veterani di Silla
scontenti, ecc. Nuovamente sconfitto alle elezioni del 62, diede vita ad una vasta
congiura per appropriarsi del potere con un atto di forza. Forse alle spalle dei
congiurati c’erano Cesare e Crasso, che però si ritrassero quando Cicerone,
informato da alcune delazioni, rivelò pubblicamente che era in corso un tentativo
rivoluzionario. In novembre C. fu costretto a lasciare Roma, ed a raggiungere un esercito
di veterani, che da tempo aveva predisposto in Etruria. Mentre a Roma Cicerone provvedeva
a distruggere le fila della congiura, C. fu affrontato dall’esercito regolare guidato
da Caio Antonio, l’altro console in carica, ed infine ucciso presso Pistoia.
Catilinarie: Termine usato per definire le quattro orazioni pronunciate da Cicerone al popolo ed al Senato contro Catilina (v.), capo della congiura che si preparava nel 63 a.C., quando cicerone era console. Cicerone si servì’ di tutti i mezzi per smascherare la congiura, e soprattutto della sua eloquenza, e riuscì nell’impresa. Le C. infatti sono considerate tra i suoi capolavori, per la vivacità drammatica, il vigore e la perfezione dello stile.
Catone: Marco Porcio, detto il Censore (dal latino Marcus Porcius Cato),
scrittore e uomo politico romano (234-149 a.C.). nato da una famiglia di agricoltori, da
giovane combatté in Campania, in Sicilia ed al Metauro. Convinto a trasferirsi a Roma dal
patrizio Valerio Flacco, che ne aveva intuito il talento, acquistò subito larga fama per
le sue doti di oratore, e si inserì nella vita politica. Nel 204 fu questore, nel 199
edile, nel 198 pretore in Sardegna, e nel 195 venne eletto console, come esponente
dell’aristocrazia tradizionale, in contrapposizione alla nuova corrente della
nobiltà guidata da Scipione. Nel 184 ottenne infine la censura, la cui rigidezza restò
famosa , tanto da meritargli il titolo di Censorius. Egli colpì ogni forma di
lusso, ed espulse dal Senato i membri che giudicava indegni. In politica estera era
diffidente sull’espansione nelle province al di fuori dell’Italia, e fu acerrimo
nemico di Cartagine. È restata proverbiale la frase con cui terminava ogni suo discorso:
"ceterum censeo Carthaginem delendam esse" (Del resto penso che Cartagine
debba essere distrutta). C. fu un uomo tenace, aggressivo fino alla durezza, sostenitore
accanito dei costumi antichi. Queste caratteristiche ritornano nelle sue orazioni, di cui
restano ampi frammenti ed 80 titoli. Tra le più famose ricordiamo quella a favore dei
Rodii, quella contro Minucio Termo e De sumptu (sulle spese). Il suo stile è
incisivo e spezzato, talvolta oscuro, ma sempre ricco di artifici oratori e di grande
passione. Scrittore eclettico, C. compose varie opere, tra le quali. Origines (Le
origini), opera perduta in 7 libri; i primi 3 trattavano la preistoria di Roma e delle
città italiche, gli altri 4 gli avvenimenti fino al 149. La novità di quest’opera
è di aver trattato in latino una materia fino ad allora affidata al greco. Conservato è
invece il De agricoltura liber, un manuale tecnico per tutte le questioni
riguardanti la conduzione di un fondo agricolo. Contiene anche ricette, pratiche rituali
ed argomenti di medicina. Si ricordano infine i Praecepta ad filium (Precetti al
figlio), enciclopedia di ogni genere di argomenti.
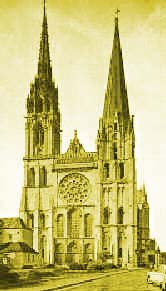 Cattedrali Gotiche: Basta trovare
la pietra giusta e rimuoverla: l'intera cattedrale si affloscerà come un castello di
carte. Questa è una delle numerose leggende a proposito delle C., strutture svettanti
verso il cielo ed architettonicamente arditissime, sostenute da un gioco di spinte,
controspinte e "chiavi di volta" tanto bilanciate da far appunto pensare
che togliendo un solo elemento, la chiave di tutte le chiavi, si provocherebbe
un'inarrestabile reazione a catena. C'è chi afferma che i loro costruttori fossero gli
eredi spirituali di Hiram, il mitico (e biblico) architetto dell'antico Tempio di
Gerusalemme: sarebbero stati i Cavalieri Templari
a indagare sugli antichi segreti ebraici nascosti nel sottosuolo di quel paese, a
scoprire, in qualche nascondiglio sopravvissuto alla distruzione del Tempio, le "Leggi
Divine dei Numeri, dei Pesi e delle Misure" che governano questo tipo di
costruzioni. Le leggende sulle C. cominciarono a nascere fin dalla loro origine, grazie
anche a una serie di coincidenze che non è difficile definire misteriose. Esse,
infatti, cominciarono a sorgere all'improvviso attorno al XII secolo, proprio
quando i Templari ritornarono
in Francia, e risulta molto difficile considerarlo una logica evoluzione del precedente
stile romanico. I loro edificatori appartenevano a delle corporazioni con fortissime
componenti esoteriche (i Compagnons ed i Maçons ). La maggior parte delle
C. sorgono su luoghi sacri precedenti, soprattutto quelli in cui si praticava il culto
della Grande Madre,
oppure su punti tradizionalmente considerati nodi di correnti
terrestri (v. linee sincroniche). Le decorazioni delle loro facciate, le statue
che adornano i transetti e le navate, le vetrate ed i disegni dei pavimenti, sono
letteralmente gremiti di simboli magici, esoterici, alchemici. Niente è casuale nelle
cattedrali, da quella di Chartres (v.) e Canterbury (v.) alla più recente Sagrada
Familia di Barcellona, che il suo costruttore, Antoni Gaudì, definì "la
prima C. di un nuovo genere". Nel suo saggio I segreti delle Cattedrali,
il Fulcanelli sostiene che le cattedrali gotiche sono veri e propri libri di pietra,
gigantesche dimore filosofali che, con le loro forme e le loro decorazioni,
descrivono il processo dell'opera alchemica, ovvero il percorso iniziatico (spesso
rappresentato dalla presenza di un labirinto) compiuto dall'uomo per passare dallo stadio
di bruto a quello di uomo-dio. Tra le tante figure simboliche ricorre la rosa, che in
termini esoterici rappresenta sia il Santo Graal (v.), sia il leggendario Sigillo
di Re Salomone, dotato di una potentissima magia, sia (come spiega sempre Fulcanelli),
il geroglifico alchemico che indica il tempo necessario alla preparazione della pietra
filosofale. La precisa disposizione delle C. le trasformerebbe in veri e propri ricevitori
della potenza solare (proveniente dal Cielo) e di quella lunare (proveniente dalla
Grande
Madre nascosta nelle viscere della Terra). In tal modo le due forze
percorrerebbero "la colonna vertebrale dei fedeli, aprendoli
all'illuminazione". Nei sotterranei di molte C. si troverebbero pozzi la cui
profondità corrisponderebbe all'altezza della guglia più alta, in modo da creare una
sorta di simmetria tra Cielo e Terra. Una scelta di carattere simbolico oppure, come
sostengono alcuni, un ulteriore artificio di natura puramente fisica per aumentare il loro
potere di risonanza eterea.
Cattedrali Gotiche: Basta trovare
la pietra giusta e rimuoverla: l'intera cattedrale si affloscerà come un castello di
carte. Questa è una delle numerose leggende a proposito delle C., strutture svettanti
verso il cielo ed architettonicamente arditissime, sostenute da un gioco di spinte,
controspinte e "chiavi di volta" tanto bilanciate da far appunto pensare
che togliendo un solo elemento, la chiave di tutte le chiavi, si provocherebbe
un'inarrestabile reazione a catena. C'è chi afferma che i loro costruttori fossero gli
eredi spirituali di Hiram, il mitico (e biblico) architetto dell'antico Tempio di
Gerusalemme: sarebbero stati i Cavalieri Templari
a indagare sugli antichi segreti ebraici nascosti nel sottosuolo di quel paese, a
scoprire, in qualche nascondiglio sopravvissuto alla distruzione del Tempio, le "Leggi
Divine dei Numeri, dei Pesi e delle Misure" che governano questo tipo di
costruzioni. Le leggende sulle C. cominciarono a nascere fin dalla loro origine, grazie
anche a una serie di coincidenze che non è difficile definire misteriose. Esse,
infatti, cominciarono a sorgere all'improvviso attorno al XII secolo, proprio
quando i Templari ritornarono
in Francia, e risulta molto difficile considerarlo una logica evoluzione del precedente
stile romanico. I loro edificatori appartenevano a delle corporazioni con fortissime
componenti esoteriche (i Compagnons ed i Maçons ). La maggior parte delle
C. sorgono su luoghi sacri precedenti, soprattutto quelli in cui si praticava il culto
della Grande Madre,
oppure su punti tradizionalmente considerati nodi di correnti
terrestri (v. linee sincroniche). Le decorazioni delle loro facciate, le statue
che adornano i transetti e le navate, le vetrate ed i disegni dei pavimenti, sono
letteralmente gremiti di simboli magici, esoterici, alchemici. Niente è casuale nelle
cattedrali, da quella di Chartres (v.) e Canterbury (v.) alla più recente Sagrada
Familia di Barcellona, che il suo costruttore, Antoni Gaudì, definì "la
prima C. di un nuovo genere". Nel suo saggio I segreti delle Cattedrali,
il Fulcanelli sostiene che le cattedrali gotiche sono veri e propri libri di pietra,
gigantesche dimore filosofali che, con le loro forme e le loro decorazioni,
descrivono il processo dell'opera alchemica, ovvero il percorso iniziatico (spesso
rappresentato dalla presenza di un labirinto) compiuto dall'uomo per passare dallo stadio
di bruto a quello di uomo-dio. Tra le tante figure simboliche ricorre la rosa, che in
termini esoterici rappresenta sia il Santo Graal (v.), sia il leggendario Sigillo
di Re Salomone, dotato di una potentissima magia, sia (come spiega sempre Fulcanelli),
il geroglifico alchemico che indica il tempo necessario alla preparazione della pietra
filosofale. La precisa disposizione delle C. le trasformerebbe in veri e propri ricevitori
della potenza solare (proveniente dal Cielo) e di quella lunare (proveniente dalla
Grande
Madre nascosta nelle viscere della Terra). In tal modo le due forze
percorrerebbero "la colonna vertebrale dei fedeli, aprendoli
all'illuminazione". Nei sotterranei di molte C. si troverebbero pozzi la cui
profondità corrisponderebbe all'altezza della guglia più alta, in modo da creare una
sorta di simmetria tra Cielo e Terra. Una scelta di carattere simbolico oppure, come
sostengono alcuni, un ulteriore artificio di natura puramente fisica per aumentare il loro
potere di risonanza eterea.
 Cartiglio:
Fregio decorativo, per lo più rappresentante una carta svolta,
per apporvi iscrizioni esplicative. Il termine identifica soprattutto il fregio
identificativo degli antichi faraoni: era costituito da un’area circoscritta in un
perimetro oblungo, in cui venivano impressi i geroglifici con il nominativo del
personaggio. È attraverso il C. che gli egittologi identificano monumenti o figure, come
gli oggetti dei quali identificano il proprietario. Spesso il C. era impresso
all’ingresso delle tombe sepolcrali, per cui l’archeologo sapeva a chi era stato
dedicato quel luogo ancora prima di accedervi per la ricerca di eventuali reperti
eventualmente lasciati dai millenari predatori di preziosi.
Cartiglio:
Fregio decorativo, per lo più rappresentante una carta svolta,
per apporvi iscrizioni esplicative. Il termine identifica soprattutto il fregio
identificativo degli antichi faraoni: era costituito da un’area circoscritta in un
perimetro oblungo, in cui venivano impressi i geroglifici con il nominativo del
personaggio. È attraverso il C. che gli egittologi identificano monumenti o figure, come
gli oggetti dei quali identificano il proprietario. Spesso il C. era impresso
all’ingresso delle tombe sepolcrali, per cui l’archeologo sapeva a chi era stato
dedicato quel luogo ancora prima di accedervi per la ricerca di eventuali reperti
eventualmente lasciati dai millenari predatori di preziosi.