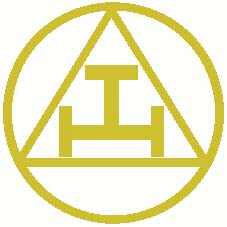Aramaico: Lingua semitica parlata dagli Aramei (v.). La molteplicità delle tribù aramee e
le loro vaste attività commerciali contribuirono a diffonderne la lingua, specialmente in
Babilonia ed in Assiria, anche dopo il crollo politico degli Aramei. La scrittura A.
alfabetica si diffuse rapidamente grazie alla sua semplicità, confrontata alla
complessità della scrittura cuneiforme. Con l’avvento dell’impero persiano
l’A. divenne la lingua ufficiale di comunicazione fra la cancelleria imperiale e le
satrapie occidentali, fino all’Egitto. Prima dell’epoca cristiana l’A. era
diffuso in tutto il territorio fra il Mediterraneo e le montagne dell’Armenia e del
Kurdistan; dopo la cattività di Babilonia, nella Palestina aveva sostituito
l’ebraico, ed era la lingua parlata da Gesù e dai suoi discepoli. L’espansione
islamica sostituì ovunque la lingua araba all’A., di cui ora restano scarsi avanzi
invia di estinzione. L’A. è noto in una fase antica (iscrizioni a partire del IV
secolo a.C.; passi biblici, soprattutto in Esdra ed in Daniele), ed in una
fase più recente, in cui appare diviso in un ramo occidentale ed in uno orientale. Al
primo appartengono l’A. giudaico e palestinese cristiano, il samaritano, il nabateo
ed il palmireno; al secondo il siriaco, che ebbe un grande sviluppo letterario, il
talmudico-babilonese, ed il mandeo.
Aramei: Uno dei grandi gruppi etnici e linguistici in cui si suddivide la stirpe semitica. I testi cuneiformi dell’XI secolo a.C. parlano degli Aramaia che, provenienti dalla Siria,
avevano invaso la Mesopotania settentrionale, territorio a cui la Bibbia assegnerà poi il
nome di Aram. Questi A. mesopotanici, la cui potenza raggiunse l’apogeo tra il
1080 ed il 930 a.C., caddero sotto l’egemonia assira già nella seconda metà del X
secolo. Varie successive sottomissioni non compromisero affatto la continuazione della
penetrazione etnica e linguistica degli A. nelle regioni comprese tra il Mediterraneo e
l’altopiano iranico, facendo prevalere l’aramaico (v.) sulle lingue delle
popolazioni indigene. La vastità di tale espansione è documentata dalla diffusione della
scrittura aramaica, ai cui modelli risalgono quasi tutti i tipi di scrittura alfabetica
non di origine greco-latina. L’aramaismo, venendo a contatto con la civiltà greca,
decadde con la conquista di Alessandro Magno, ma riprese vigore sotto l’impero romano
con il diffondersi di colonie aramaiche in occidente.
Ararat: Montagna vulcanica dell’Armenia, nella Turchia orientale, al confine con l’Iran, dove raggiunge i 5165 m. d’altezza. È tra i più antichi monti conosciuti dall’umanità, sul quale, secondo il racconto biblico, si arenò l’Arca di Noé (v.) dopo il diluvio universale. Secondo la Genesi (8, 3-4) "Le acque si
ritirarono a poco a poco dalla terra, e passati 150 giorni si abbassarono. Al diciassette
del settimo mese l’arca si fermò sulla montagna dell’A., e le acque
continuarono ad abbassarsi fino al decimo mese; ed il primo giorno del decimo mese
apparvero le vette dei monti". Secondo una leggenda medievale denominata dei "Santi
dell’A.", sulla stessa montagna si sarebbero rifugiati diecimila
soldati romani convertitisi al cristianesimo sotto l’imperatore Antonino Pio
(138-161). Essi vi condussero vita eremitica, ma furono presto stanati tutti dalle legioni
romane e crocifissi. Il Baronio comunque li inserì nel martirologio romano.
 Arca
dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto
israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate
da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita
dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano
infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore
poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro
scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due
Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei
9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai
Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele
4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei
prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un
padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re
Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).
Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli
oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre
Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del
monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto
in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è
focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham
Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,
Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,
gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della
regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche
peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta
Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione
templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),
noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di
un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato
e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben
protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di
Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata
il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato
l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della
Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una
raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale
della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.
Arca
dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto
israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate
da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita
dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano
infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore
poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro
scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due
Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei
9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai
Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele
4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei
prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un
padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re
Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).
Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli
oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre
Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del
monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto
in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è
focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham
Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,
Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,
gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della
regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche
peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta
Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione
templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),
noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di
un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato
e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben
protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di
Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata
il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato
l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della
Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una
raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale
della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.
Arca di Noé: Grande cassone in legno che Noè, su ordine di Yahweh, costruì prima del Diluvio Universale,
per ricoverarvi sé stesso con i familiari, ed una coppia di tutte le specie animali (Genesi
6, 13-22). Dio stesso indicò a Noè le modalità di costruzione e le misure
dell’A.: fabbricata in legno resinoso, spalmata dentro e fuori di bitume, lunga 300
cubiti, larga 50 ed alta 30 (m. 187 x 22,5 x 13,5). Era divisa in tre ripiani alti ognuno
circa 5 metri. Aveva una porta di fianco, per l’ingresso degli animali, che venne
chiusa da Yahweh stesso (Genesi 7, 16). Era sormontata da un tetto a coperchio, ed
aveva un’apertura in alto (ebr. Söhar, finestra) alta un cubito (cm. 45), che
correva lungo tutte le pareti dell’A. Secondo la Bibbia essa sarebbe approdata sul
monte Ararat, in Turchia (nelle altre tradizioni i punti d'approdo sono, ovviamente,
differenti). La ricerca della prova storica della narrazione biblica ha occupato per un
paio di secoli decine di spiriti ardimentosi. Nel 1829, un medico tedesco, il dottor Friedrich
W. Parrot, compì la prima ascensione documentata sull'Ararat, e visitò tra l'altro
il monastero di Echmiadzin, dove i Pope ortodossi venerano una croce che sostengono
essere stata costruita con il legno dell'A. Altre spedizioni senza successo furono
effettuate nel 1835 (Karl Behrens), nel 1845 (Hermann Von Abich), nel 1846 (Danby
Seymour), nel 1850 (col. Khodzko) e nel 1856 (Robert Stuart). Il primo
avvistamento dell'Arca avvenne in una data imprecisata tra il 1850 ed il 1880. Un armeno, Hail
Yearam, non solo avrebbe rinvenuto il fantastico relitto, ma vi sarebbe addirittura
entrato. L'inglese Sir James Bryce, nel 1876, riportò a Londra la prima prova
dell'esistenza dell'A.: un pezzo di legno vecchio almeno di tremila anni, ritrovato a più
di quattromila metri di quota. Nel 1883 il governo turco annunciò ufficialmente la
scoperta dell'A., ma poi della notizia non fu più fatta menzione. Altri spettacolari
avvistamenti sono stati effettuati nel nostro secolo da un pastore armeno di nome Hagopian
(1902) e da un pilota russo, Vladimir Roskovitsky (1916). L'avvenimento interessò
gli Zar, che inviarono truppe a investigare. Si dice che i soldati abbiano trovato l'A.,
facendo accurate misurazioni; ma dopo pochi giorni scoppiò la Rivoluzione d’Ottobre,
e la notizia finì nel dimenticatoio. Solo molti anni dopo l'ex colonnello zarista Alexander
Koor, che aveva partecipato alle precedenti ricerche, confermò la scoperta, fornendo
anche dettagliati diagrammi della zona del ritrovamento. Avvistamenti più recenti sono
stati effettuati da piloti russi e da satelliti spia americani. Questi ultimi avrebbero
fotografato sulla sommità dell'Ararat un manufatto semisepolto dal ghiaccio, simile alla
chiglia di una grande imbarcazione. Poi, per questioni politiche, le spedizioni
sull'Ararat sono state proibite dal governo turco. Cionondimeno, le associazioni di
ricercatori dell'A. (tra cui l'americana Search Foundation ) continuano ad
aumentare di numero. Tra le spedizioni più recenti, tutte infruttuose, é annoverata
anche quella organizzata dall'ex astronauta John Irwin (1982), uno dei pochi uomini
che abbiano posto piede sulla Luna.
Arcangelo
Michele: v
Michele Arcangelo (San).
Arcano: Misterioso, segreto, occulto, enigmatico, criptico, celato, nascosto; cosa che
non è possibile chiarire o conoscere. Nel linguaggio ermetico è l’acqua mercuriale
decantata, oppure il Mercurio con l’aggiunta dello Zolfo filosofico, oppure ancora
l’Antimonio (v.). Secondo Elifas Levi (Il Grande Arcano, Ediz. Atanor, 1994),
"Il Grande A., l’A. invincibile, l’A. pericoloso, l’A.
incomprensibile, si può formulare come la divinità dell’uomo. È indicibile,
poiché appena viene formulata, la sua espressione risulta essere la più mostruosa delle
menzogne. In effetti l’uomo non è Dio. Tuttavia la più ardita, la più oscura, ed
assieme la più splendida delle religioni, ci dice di adorare l’Uomo-Dio.
Gesù Cristo, che questa religione dichiara vero uomo, uomo completo, uomo finito, uomo
mortale come ogni altro uomo, ma che è allo stesso tempo totalmente Dio, mentre la
teologia osa proclamare la comunione degli idiomi, sarebbe a dire l’adorazione
rivolta alla carne … Il Serpente disse: "Eritis sicut dii". Gesù
Cristo, schiacciando la testa del serpente sotto il piede di sua Madre, osa dire: "Eritis
non sicut dii, non sicut Deus, sed eritis Deus". Tutto ciò che il mondo ha visto
e sperimentato fino ad oggi non dà la soluzione del problema posto dalla Magia e dal
Vangelo: il Grande A. dell’Uomo-Dio (v. anche Tarocchi).
Archetipo: Termine derivato dal greco arcetupon, modello, primo esemplare. · In letteratura il termine viene usato quando ci si vuol riferire
ad un’opera che per prima ha assunto una certa configurazione che si è proposta come
esempio da seguire a quelle successive. · In filosofia il
termine viene impiegato per indicare quelle idee che si pongono come sfera trascendente
rispetto alla materia, costituendo il modello eterno, in base al quale vengono a formarsi
le cose. È questo il significato prevalso nella tradizione del pensiero, che trova la sua
origine in Platone. Kant a sua volta parla di intellectus archetypus, intendendo
l’intelletto divino che intuisce la realtà senza per questo essere costretto a fare
i conti con l’esperienza sensibile. · Il termine viene
usato anche in filologia, nel cui ambito con esso ci si riferisce ad un manoscritto
perduto, ma tanto noto da poter essere ricostruito, attraverso la critica testuale, con
sufficiente esattezza. L’A. è un testo che, rispetto ai codici noti, è più vicino
all’originale. Tale vicinanza è però relativa, poiché l’A. può presentarsi
guastato da interpolazioni o lacunoso, di modo che l’editore o curatore di un testo
(talvolta indotto a postulare l’esistenza di più A.), per porre a ciò rimedio, è
spinto ad emendare il testo stesso per via di congetture. ·
Infine in psicologia il termine è diventato famoso grazie a Carl Gustav Jung il quale,
nella sua concezione dell’inconscio collettivo, ha affermato la presenza di idee
madri (appunto gli A.) nella psiche arcaica. Ciò sarebbe testimoniato
dall’affinità fra i riti ed i culti dei primitivi e le immagini dei sogni, che sono
tutti simboli radicati nel profondo dell’anima collettiva come serbatoio perenne,
mantenendosi inalterato nel corso dei secoli e dei millenni.
Archiatra: Termine derivato dal greco iatroz, medico, ed il prefisso arci, indicante il sommo grado di un ufficio. L’A. Pontificio è
il medico privato del papa. Con tale qualifica l’A. acquisiva il titolo di
monsignore, anche se era ammogliato, ed entrava a far parte della Camera Segreta con il
rango di di cameriere segreto. Questa appartenenza gli è conservata tuttora, anche se il
nome in sé è in disuso.
Archimandrita: Termine con il quale fin dal IV secolo si indicava presso i cristiani di rito greco ortodosso il capo di un ordine religioso o di un monastero. Dal greco arcimandrithz,
capo della mandria o dell’ovile, capo di una scuola, di una setta o di altra
compagnia di persone. Dopo il VI secolo il titolo fu riservato al superiore di una
federazione di monasteri, diventando sinonimo di esarca (v.). In tempi più recenti si
distingue l’A. effettivo, superiore di un importante monastero, e l’A. titolare
la cui dignità è concessa honoris causa a monaci ed anche (ma abusivamente) a sacerdoti
secolari. L’A. del monastero basiliano di Grottaferrata è anche esarca con
territorio proprio (abate nullius). Il Superiore generale dei Basiliani ruteni ha
il titolo di Protoarchimandrita. Dante Alighieri, parlando nella Divina Commedia di San
Francesco d’Assisi e della sua regola, dice: "la santa voglia d’esto
A." (Paradiso XI, 99).
Archimede: Matematico e fisico greco (287-212 a.C.), il cui nome è legato a fondamentali studi nel campo dell’idrostatica, e soprattutto sul calcolo delle aree e dei volumi. Sue opere più importanti sono : il Metodo (rinvenuto nel 1906), l’Arenario, Della sfera e del cilindro, la Quadratura della parabola. Ad A. sono attribuite molte invenzioni meccaniche d’ordine pratico, come quelle della vite senza fine e del paranco. È molto famoso il principio d’A., per cui "ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta
diretta verso l’alto pari al peso del liquido spostato".
 Archipendolo:
Importante attrezzo operativo, indispensabile nell’Arte muratoria. Simbolo della
Libera Muratoria, denominato anche Livella (v.).
Archipendolo:
Importante attrezzo operativo, indispensabile nell’Arte muratoria. Simbolo della
Libera Muratoria, denominato anche Livella (v.).
Architetti
Revisori (Grandi): Il Collegio dei Grandi A.R. è
l’organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria del Grande
Oriente d’Italia (Art. 43 Co.). I componenti il Collegio dei G.A.R. sono eletti dalla
Gran Loggia. Possono essere eletti Componenti il Collegio dei G.A.R. i Fratelli con almeno
cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro. Essi durano in carica cinque anni, e non
sono rieleggibili nel quinquennio successivo. Il Regolamento dell’Ordine determina il
numero dei Componenti il Collegio dei G.A.R., le modalità di elezione, la formalità
delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La carica di G.A.R. è
incompatibile con ogni altra carica massonica, sia elettiva che di nomina (Art. 44 Co.).
Il Collegio dei G.A.R. si riunisce in via ordinaria ogni trimestre, e quando il Presidente
lo giudichi opportuno. Svolge la sua attività in sessioni collegiali. Il Presidente
assiste alla compilazione dell’inventario (Art. 45 Co.). Il collegio dei G.A.R.: · a) controlla l’amministrazione patrimoniale e finanziaria del
G.O.I. e la regolare tenuta dei libri contabili; · b) esamina
i documenti giustificativi di spesa; · c) controlla la
corrispondenza del bilancio consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili; · d) accerta la consistenza di
cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli; · e)
riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria
svolta dalla Giunta del G.O.I. nell’anno precedente (Art. 46 Co.). Il numero dei
Componenti il Collegio dei G.A.R. è di cinque. La gran Loggia ogni cinque anni elegge il
Collegio dei G.A.R. fra i Fratelli Maestri aventi il requisito fissato dall’art. 44
della Costituzione (Art. 136 Re.). Entro i trenta giorni successivi il Gran Maestro
convoca i cinque Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e ne riceve la
promessa solenne (Art. 137 Re.). Il Collegio dei G.A.R. è convocato, senza speciali
formalità, dal Presidente per lo svolgimento dei compiti fissati dall’art. 46 della
Costituzione (Art. 138 Re.).I Componenti il Collegio dei G.A.R. che non abbiano
partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre per
rinuncia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti
Massonici. Il Gran Maestro, constatata l’avvenuta decadenza, provvede alla
sostituzione dei Componenti con i primi non eletti. Ove, nell’intervallo fra due
sessioni di Gran Loggia, l’elenco dei non eletti non consenta che il Collegio sia
composto da cinque componenti, il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi
nella successiva sessione di Gran Loggia (Art. 139 Re.).
Architetto Revisore: Carica di ufficiale di Loggia, cui viene designato dal Maestro Venerabile un fratello Maestro con almeno un anno di anzianità nel grado. L’A.R. controlla ogni documento di carattere contabile interessante la gestione della Loggia. Provvede a rivedere la contabilità ed il conto consultivo annuale, riferendone alla Loggia riunita in Terzo Grado (Art. 47 del Regolamento dell’Ordine).
Architettura:
Arte e tecnica
di ideazione, progettazione e realizzazione di edifici ed opere edilizie in
genere, per le quali è necessaria la mediazione del disegno. Le più antiche
realizzazioni architettoniche sono identificate nei monumenti megalitici (dolmen
e menhir, v.) di epoca preistorica. La
vera A. ha però inizio nella prima fase storica in cui il materiale costruttivo
(pietra e roccia) venne lavorato preventivamente, od elaborato artificialmente
(mattoni in laterizio e terrecotte). Ciò avvenne in Mesopotania ed in Egitto
verso il 3000 a.C. L'esperienza architettonica destinata ad incidere più
profondamente e durevolmente sull'evoluzione dell'A. occidentale fu quella
greca. Il tempio greco rappresenta il punto d'incontro tra una raffinata
concezione dell'ordine geometrico ed una profonda sensibilità estetica. Nel
mondo romano l'eredità dell'A. greca venne liberamente rielaborata, e si
arricchì di esperienze costruttive originali, come l'arco (v. figura) e la
volta. La successiva A. religiosa bizantina (basilica di Santa Sofia in
Costantinopoli) si ricollega direttamente agli edifici romani, mentre in
Occidente, e nello stesso periodo, il Cristianesimo predilisse come veicolo
espressivo la chiesa a pianta basilicale, schema che determinò in prevalenza
l'indirizzo della successiva A. religiosa europea. Allo schema dell'abbazia
benedettina caratterizzante il Medioevo, si sostituisce, a partire dall'XI
secolo, il romanico, il
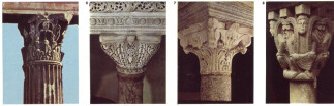 primo
degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per
secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile
romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un
luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il
Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della
tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in
questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di
tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella
transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in
seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel
neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato
dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi
materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art
Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità
offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi
prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche
e funzionali, propugnato dal funzionalismo.
Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni
dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le
nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si
sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza
verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più
rappresentativi, ovvero: ·
1) Egizio, del tempio di Amon-Ra a Karnak (ca. 1500 a.C.); ·
2) Dorico, della basilica di Paestum (fine VI secolo a.C.); ·
3) Ionico di Delfi (VI secolo a.C.); ·
4) Corinzio (fine V secolo a.C.); ·
5) Romano, del tempio di Castore e Polluce a Roma (inizio II secolo d.C.); ·
6) Bizantino, della chiesa sei Santi Sergio e Bacco ad Istambul (VI secolo
d.C.); ·
7) Composito preromanico, della chiesa di Jouarre, Francia (VI secolo d.C.); ·
8) Romanico figurato, del monastero di San Cugat del Vallés, Spagna (XII secolo
d.C.). Y
(Massoneria):
Nel corso della cerimonia di iniziazione al Grado di Compagno d'Arte, secondo
un interessante e significativo rituale praticato all'inizio del XIX secolo,
il Maestro Venerabile definisce l'A. come segue: «L'A., la più nobile fra le
Arti manuali, è la scienza della quale i Saggi dell'antichità si sono
serviti per esprimere il loro concetto di Bellezza. Tali Saggi furono i nostri
illustri predecessori, che ci trasmisero il titolo distintivo di Massoni, del
quale tanto ci onoriamo. Gli edifici della prima età sono poco noti, le città
da loro fondate sono scomparse. Se il nome dei più illustri fra quei Maestri è
restato ignorato, la Tradizione e la Storia hanno potuto tramandarcene qualcuno.
Caino costruì una città chiamata Enoc (Genesi 4, 17); Noé fabbricò l'Arca, nella quale si salvò durante il Diluvio
Universale (Genesi 2, 6, 9); Nemroth
costruì la Torre di Babele, e pose le prime fondamenta di Babilonia (Genesi
2, 1-9); il nostro Maestro Hiram (v.) fu
il costruttore del Tempio di Salomone (1 Re 7, 13); Pietro
edificò nell'Asia Minore il Tempio di Minerva a Priene; Dedalo costruì a
Creta il famoso Labirinto (v.); e
Vitruvio fu il più famoso fra gli architetti romani. L'A. ebbe
la sua culla in Egitto, paese originario della Libera Muratoria. Lo studio
dell'A. ha lo scopo di far
comprendere all'iniziato (v.) la
cura che egli deve apportare nella decorazione del tempio che noi vogliamo
edificare alla Verità ed al Progresso. Ricordatevi che il solo ornamento che
possa convenirgli è la Virtù dei massoni incaricati della sua edificazione»
primo
degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per
secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile
romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un
luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il
Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della
tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in
questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di
tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella
transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in
seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel
neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato
dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi
materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art
Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità
offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi
prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche
e funzionali, propugnato dal funzionalismo.
Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni
dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le
nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si
sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza
verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più
rappresentativi, ovvero: ·
1) Egizio, del tempio di Amon-Ra a Karnak (ca. 1500 a.C.); ·
2) Dorico, della basilica di Paestum (fine VI secolo a.C.); ·
3) Ionico di Delfi (VI secolo a.C.); ·
4) Corinzio (fine V secolo a.C.); ·
5) Romano, del tempio di Castore e Polluce a Roma (inizio II secolo d.C.); ·
6) Bizantino, della chiesa sei Santi Sergio e Bacco ad Istambul (VI secolo
d.C.); ·
7) Composito preromanico, della chiesa di Jouarre, Francia (VI secolo d.C.); ·
8) Romanico figurato, del monastero di San Cugat del Vallés, Spagna (XII secolo
d.C.). Y
(Massoneria):
Nel corso della cerimonia di iniziazione al Grado di Compagno d'Arte, secondo
un interessante e significativo rituale praticato all'inizio del XIX secolo,
il Maestro Venerabile definisce l'A. come segue: «L'A., la più nobile fra le
Arti manuali, è la scienza della quale i Saggi dell'antichità si sono
serviti per esprimere il loro concetto di Bellezza. Tali Saggi furono i nostri
illustri predecessori, che ci trasmisero il titolo distintivo di Massoni, del
quale tanto ci onoriamo. Gli edifici della prima età sono poco noti, le città
da loro fondate sono scomparse. Se il nome dei più illustri fra quei Maestri è
restato ignorato, la Tradizione e la Storia hanno potuto tramandarcene qualcuno.
Caino costruì una città chiamata Enoc (Genesi 4, 17); Noé fabbricò l'Arca, nella quale si salvò durante il Diluvio
Universale (Genesi 2, 6, 9); Nemroth
costruì la Torre di Babele, e pose le prime fondamenta di Babilonia (Genesi
2, 1-9); il nostro Maestro Hiram (v.) fu
il costruttore del Tempio di Salomone (1 Re 7, 13); Pietro
edificò nell'Asia Minore il Tempio di Minerva a Priene; Dedalo costruì a
Creta il famoso Labirinto (v.); e
Vitruvio fu il più famoso fra gli architetti romani. L'A. ebbe
la sua culla in Egitto, paese originario della Libera Muratoria. Lo studio
dell'A. ha lo scopo di far
comprendere all'iniziato (v.) la
cura che egli deve apportare nella decorazione del tempio che noi vogliamo
edificare alla Verità ed al Progresso. Ricordatevi che il solo ornamento che
possa convenirgli è la Virtù dei massoni incaricati della sua edificazione»
Arcontici:
Denominazione attribuita ad eretici del IV secolo citati da
Sant'Epifanio. Erano così chiamati perché ponevano al di sopra d'ogni
essere un ente, la «Madre
Luminosa», che stava nell'ottavo cielo e governava, coadiuvata da
sette arconti, aiutati da angeli loro creature, i sette cieli circostanti. A
questi si opponevano Sabaoth, il dio dei Giudei e padre di Satana. Dall'unione
carnale del demonio con Eva sarebbero nati Caino ed Abele, mentre invece Adamo
avrebbe avuto da Eva il solo Seth.
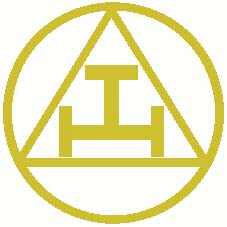 Arco Reale: Quando all’interno
della massoneria inglese nel 1751 avvenne la divisione fra le due Logge rivali degli Ancients
e dei Moderns, furono i primi a considerare maggiormente l’A.R., e già i
primi verbali della Gran Loggia degli Ancients dimostrano che l’A.R. vi fu subito
praticato. Il primo documento attestante l’uso del sistema presso i Moderns è un
verbale risalente al 1758, e riguardante una Loggia che, pur appartenendo ufficialmente ai
Moderns, lavorava con il rituale Ancients. Considerando questi fatti, e ricordando che i
massoni Antients affermavano di voler ripristinare le più antiche tradizioni
dell’Ordine, si può ipotizzare che l’A.R., od almeno alcuni suoi elementi,
fossero praticati in epoca molto precedente a quelle considerate, anche se si può
supporre che ciò avvenisse più nei contenuti spirituali che nelle successive forme
rituali. Gli insegnamenti dell’A.R. erano, nelle Logge dei Moderns, parte integrante
del grado di Maestro Massone, evidentemente con modalità ritenute non esaurienti se, il
22 luglio 1766 Lord Blayney, Gran Maestro dei Moderns, firmò il Charter of Compact of
the Grand and Royal Chapter of the Holy Royal Arch of Jerusalem, da cui poi originò
direttamente, nel 1817, il Gran Capitolo Unito, denominato nel 1822 Supremo Gran Capitolo
dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra. Tra i firmatari c’era anche Thomas
Dunckrley, che nel 1766 fu incaricato dalla Gran Loggia dei Moderns di rivedere i
catechismi massonici. In quella occasione la vera Parola del Maestro Massone fu
estrapolata dal Terzo Grado e trasferita appunto al Rituale del Sacro Arco Reale di
Gerusalemme; scelta questa che ebbe grande peso nel preparare la strada per l’Unione
delle due Grandi logge rivali nel 1813, anno in cui fu sancito che l’A.R. faceva
parte della pura antica Massoneria. La Massoneria dell’A.R. degli Ancients e dei
Moderns visse separatamente per altri quattro anni, fino al 18 agosto 1817, data
dell’Unione, in cui fu stabilito dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra che i
capitoli del Sacro A.R. di Gerusalemme Inglese devono essere aggregati alle Logge
dell’Ordine, assumendone lo stesso numero distintivo e la stessa età, a prescindere
dal momento dell’aggregazione. Nacque così il Gran capitolo Unito, oggi Supremo Gran
Capitolo dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra, Galles e dipendenze, che alla fine
del 1983 governava 9013 Capitoli su 9088 Logge della Gran Loggia Unita. Prima
dell’Unione del 1813 era necessario per tutti i candidati, sia degli Ancients che dei
Moderns, essere stati precedentemente Maestro Venerabile in una Loggia dell’Ordine.
Nel 1843 il Supremo Gran Capitolo ritenne come qualificazione sufficiente per essere
proposti per l’Esaltazione l’essere Maestro muratore da almeno un anno,
riducendo nel 1893 tale periodo probatorio a quattro settimane, come è tutt’oggi. In
Italia la consacrazione del primo Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme
ebbe luogo a Firenze nel novembre 1976, con la partecipazione di oltre sessanta Compagni
della Gran Loggia Unita d’Inghilterra. Da quel momento fu costituito il Supremo Gran
Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme per l’Italia, in seno al
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Simboli dell’A.R. di particolare
rilevanza sono: il triplo Tau, il Nome Ineffabile ed il Sigillo di Salomone, o Stella a
sei punte od esagramma od esalpha (v.). Il triplo Tau inscritto in un triangolo ed in un
cerchio è considerato simbolo sacro per eccellenza, che per Jung rappresenta
nell’inconscio collettivo la delimitazione dell’ambito sacroe la fissazione su
un centro spirituale universale. in origine era una Tau sovrapposta ad una H, per indicare
"Templum Hierosolymae" (Tempio di Gerusalemme), acquisendo poi una
propria autonomia simbolica.
Arco Reale: Quando all’interno
della massoneria inglese nel 1751 avvenne la divisione fra le due Logge rivali degli Ancients
e dei Moderns, furono i primi a considerare maggiormente l’A.R., e già i
primi verbali della Gran Loggia degli Ancients dimostrano che l’A.R. vi fu subito
praticato. Il primo documento attestante l’uso del sistema presso i Moderns è un
verbale risalente al 1758, e riguardante una Loggia che, pur appartenendo ufficialmente ai
Moderns, lavorava con il rituale Ancients. Considerando questi fatti, e ricordando che i
massoni Antients affermavano di voler ripristinare le più antiche tradizioni
dell’Ordine, si può ipotizzare che l’A.R., od almeno alcuni suoi elementi,
fossero praticati in epoca molto precedente a quelle considerate, anche se si può
supporre che ciò avvenisse più nei contenuti spirituali che nelle successive forme
rituali. Gli insegnamenti dell’A.R. erano, nelle Logge dei Moderns, parte integrante
del grado di Maestro Massone, evidentemente con modalità ritenute non esaurienti se, il
22 luglio 1766 Lord Blayney, Gran Maestro dei Moderns, firmò il Charter of Compact of
the Grand and Royal Chapter of the Holy Royal Arch of Jerusalem, da cui poi originò
direttamente, nel 1817, il Gran Capitolo Unito, denominato nel 1822 Supremo Gran Capitolo
dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra. Tra i firmatari c’era anche Thomas
Dunckrley, che nel 1766 fu incaricato dalla Gran Loggia dei Moderns di rivedere i
catechismi massonici. In quella occasione la vera Parola del Maestro Massone fu
estrapolata dal Terzo Grado e trasferita appunto al Rituale del Sacro Arco Reale di
Gerusalemme; scelta questa che ebbe grande peso nel preparare la strada per l’Unione
delle due Grandi logge rivali nel 1813, anno in cui fu sancito che l’A.R. faceva
parte della pura antica Massoneria. La Massoneria dell’A.R. degli Ancients e dei
Moderns visse separatamente per altri quattro anni, fino al 18 agosto 1817, data
dell’Unione, in cui fu stabilito dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra che i
capitoli del Sacro A.R. di Gerusalemme Inglese devono essere aggregati alle Logge
dell’Ordine, assumendone lo stesso numero distintivo e la stessa età, a prescindere
dal momento dell’aggregazione. Nacque così il Gran capitolo Unito, oggi Supremo Gran
Capitolo dei Massoni dell’A.R. d’Inghilterra, Galles e dipendenze, che alla fine
del 1983 governava 9013 Capitoli su 9088 Logge della Gran Loggia Unita. Prima
dell’Unione del 1813 era necessario per tutti i candidati, sia degli Ancients che dei
Moderns, essere stati precedentemente Maestro Venerabile in una Loggia dell’Ordine.
Nel 1843 il Supremo Gran Capitolo ritenne come qualificazione sufficiente per essere
proposti per l’Esaltazione l’essere Maestro muratore da almeno un anno,
riducendo nel 1893 tale periodo probatorio a quattro settimane, come è tutt’oggi. In
Italia la consacrazione del primo Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme
ebbe luogo a Firenze nel novembre 1976, con la partecipazione di oltre sessanta Compagni
della Gran Loggia Unita d’Inghilterra. Da quel momento fu costituito il Supremo Gran
Capitolo dell’Ordine del Sacro A.R. di Gerusalemme per l’Italia, in seno al
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Simboli dell’A.R. di particolare
rilevanza sono: il triplo Tau, il Nome Ineffabile ed il Sigillo di Salomone, o Stella a
sei punte od esagramma od esalpha (v.). Il triplo Tau inscritto in un triangolo ed in un
cerchio è considerato simbolo sacro per eccellenza, che per Jung rappresenta
nell’inconscio collettivo la delimitazione dell’ambito sacroe la fissazione su
un centro spirituale universale. in origine era una Tau sovrapposta ad una H, per indicare
"Templum Hierosolymae" (Tempio di Gerusalemme), acquisendo poi una
propria autonomia simbolica.
Areopago: Nome del
promontorio che sorgeva al di sopra dell'Acropoli di Atene, in cui teneva le sue sedute il
più antico consiglio della città. Successivamente designò la suprema corte di giustizia
degli ateniesi, che avrebbe derivato il proprio nome da quello del dio Ares (Areios),
il latino Marte, e dal monte (in greco pagos) su cui sorgeva quel tribunale. Aveva
poteri giudiziari, religiosi e politici, occupandosi soprattutto del giudizio di omicidi
premeditati, della stretta sorveglianza delle pratiche dei culti e dell'osservanza della
moralità pubblica e privata. Il giudizio vi veniva espresso dai giudici, dopo il
dibattimento tra accusa e difesa, a mezzo di pietruzze (o dischetti), di colore bianco per
l'assoluzione e nero per la condanna. Le bianche erano deposte in un'urna di rame, e le
nere in una di legno. Dal loro computo derivava la sentenza. La carica di giudice era
elettiva, ed era aperta sia agli ateniesi che agli stranieri. Prima di avviare il
dibattito della causa, si offrivano sacrifici agli dei, sui quali prestavano giuramento
accusato ed accusatore. Durante la dominazione romana l'A. aveva anche compiti di polizia
e di sorveglianza sull'educazione dei giovani.
Ares: Figlio di Giove e di
Giunone, era il dio greco della guerra, onorato in Roma sotto il nome di Marte. Suoi
abituali compagni erano la Discordia, la Strage, la Paura ed il Terrore.
Amava la guerra in modo selvaggio e brutale, inebriandosi del sangue come suo elemento
vitale. Raffigurato armato di corazza ed elmo, impugnante lancia e scudo, si avventava sui
campi di battaglia tra selvagge urla di guerra, seminando ovunque l'orrore e la strage.
Era l'amante ufficiale di Afrodite-Venere, dalla quale ebbe vari figli, tra i quali Eros (Cupido),
Anteros, Deimos, Fobos, Alcippe ed Armonia. Ebbe una fierissima contesa con Nettuno,
avendone ucciso il figlio Alirrozio, che gli aveva insidiato la figlia Alcippe. Nettuno lo
citò in giudizio davanti ad un tribunale composto da dodici dei, dove A. seppe difendersi
tanto bene da risultarne prosciolto. Il luogo del giudizio prese poi da lui il nome di
Areopago (v.). Originariamente il romano Marte era considerato dio dell'agricoltura, e gli
era stato perciò dedicato Marzo, il primo mese di primavera. In seguito, con
l'appellativo di Gradivo, divenne il dio della guerra, a cui furono dedicati molti templi
di Roma, come al Campo di Marte ed al foro d'Augusto, dov'era oggetto di grande devozione,
soprattutto quale dio vendicatore delle offese ricevute.
Aria: Miscuglio gassoso
inodore, insapore e comburente, costituito essenzialmente da azoto ed ossigeno, che forma
l'atmosfera indispensabile alla vita animale e vegetale. Come suggerisce il suo
simbolo alchemico, essa rappresenta il flusso del divenire che si arresta nel
Microcosmo di colui che lo potrebbe generare come Fuoco. Arrestandosi il flusso, si ferma
la percezione del divenire. Perciò il modo di essere associato all’Aria rappresenta
il modo di essere associato al pensiero non operante. Questo fa spostare maggiormente
l’attenzione sulla coscienza del tempo presente, e tende a far prevalere la presenza
di un Microcosmo individuale chiuso nel proprio pensiero. La prevalenza incontrollata di
un Microcosmo troppo individuale implica una reale difficoltà nella percezione delle
nostre responsabilità operative nelle relazioni con il Macrocosmo, in quanto un
microcosmo individuale tende a "vedere" solo se stesso. In tal senso
prende significato la tradizionale esortazione al superamento di ogni individualità
profana. Negli elementi Aria e Terra, profanamente vissuti, sono racchiusi i principi
della generazione dei metalli all’interno del Microcosmo. L’Aria non è un
elemento dinamico: non scorre, e da solo non può generare vere trasformazioni nel
divenire. Aria e Scalpello (o bulino) derivano da un unico termine latino, "caelum",
per cui l'attrezzo, importante nel rituale del Compagno d'Arte, viene definito Aria
dei filosofi. Viene simbolicamente rappresentata da un triangolo rettangolo con vertice in
alto, sbarrato orizzontalmente come nella figura. Nel Tempio Massonico viene impiegata dal
1° Sorvegliante nel corso del rito di Iniziazione del neofita.
Arianesimo: Grande eresia
che, promossa da Ario (v.), sconvolse il mondo cristiano dal IV al VI secolo. Trova
origine già nel subordinazionismo di Origene e di Luciano d’Antiochia, maestro di
Ario alla scuola teologica ancora influenzata dalla tradizione eretica di Paolo di
Samosata. L’A. scosse profondamente la Chiesa, non soltanto nella sua ortodossia
dottrinale ma anche nella sua compagine religiosa, ed ebbe conseguenze negative anche per
le molte interferenze politiche createsi intorno. L’A. nella sua sostanza nega il
dogma della Trinità. Base e fondamento della religione cristiana, che afferma una sola
essenza essenza divina sussistente i tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, distinte
tra loro nelle manifestazioni, ma coeterne ed uguali in tutto. L’A. riconosce
l’esistenza delle tre persone, ma afferma che solo il Padre è veramente Dio eterno e
non creato (agennhtoz); la seconda persona, il Verbo, chiamata Figlio in senso
adottivo, non è veramente Dio, ma è la prima creatura, la più eccellente, creata da Dio
per essere intermediaria fra lui ed il mondo fin dall’atto della creazione; la terza
persona, lo Spirito Santo, è considerata una creatura molto al di sotto del verbo,
L’A. scalza dalle fondamenta anche i dogmi dell’Incarnazione e della Redenzione,
perché il Verbo avrebbe preso dalla natura umana soltanto la carne, e non l’anima
ragionevole. L’A. fu solennemente condannato dal I Concilio ecumenico di Nicea, in
Bitinia (325), dove fu proclamato il simbolo niceno, in cui si dichiara che il verbo è
consustanziale al Padre. Di fronte a questa chiara dichiarazione dell’ortodossia
l’A. assunse atteggiamenti dottrinali: 1) Gli ariani puri dichiararono che il
Verbo era del tutto dissimile dal Padre, e furono detti anomei od anche aeziani o
eunomiani, dai nomi dei loro maggiori esponenti Aezio di Antiochia ed Eunomio di Cizico.
2) I semi-ariani detti omeusiani od omoiusani, poiché invece di chiamare il Verbo
consustanziale al Padre quanto all’essenza lo dicevano simile; verso di loro gli
esponenti dell’ortodossia (s.Ilario, s.Atanasio) si dimostrarono concilianti; gran
numero di essi però negava comunque la divinità dello Spirito Santo. 3) Gli omeisti,
che affermavano semplicemente che il Figlio era simile al Padre, senza ulteriori
precisazioni. Questa formula divenne il credo dell’A. ufficiale dell’impero
romano e, con qualche aggiunta indicativa, dell’A. dei popoli barbari. 4) I macedoniani,
dal nome di Macedonio, vescovo ariano (351-360) di Costantinopoli, o pneumotomachi (avversari
dello Spirito), che negavano la divinità dello Spirito Santo, facendone la prima creatura
del Figlio o Verbo. I macedoniani si distinguevano dagli ariani propriamente detti, e
costituivano una setta a parte perché, pur negando la divinità dello Spirito Santo,
credevano nella divinità del Verbo.
Ariete: Il primo segno dello
Zodiaco (v.), il cui simbolo astrologico è (^ ). Appartiene all'elemento Fuoco. Il
termine indica il nome del famoso montone dal Vello d'oro, sul cui dorso i due
fratelli Frisso ed Elle si sottrassero alla persecuzione di Democide, moglie del loro zio,
che non perdonava a Frisso d'aver respinto il suo insano amore. Giunto nella Colchide
(v.), Frisso sacrificò a Giove l'A., e ne appese la pelle (appunto il famoso Vello
d'oro) nel bosco di Ares (v.), e facendolo custodire da un terribile drago. Quando il prezioso talismano venne conquistato da Giasone, e da questi poi consegnato a Pelia in ricordo della gloriosa spedizione degli Argonauti di cui esso era stata causa, l'A. fu assunto in cielo, dando il nome ad una costellazione. L'A. era oggetto di culto per gli abitanti di Tebe, in Egitto; infatti il lungo viale che conduce al tempio di Karnak è delimitato da una duplice fila di questi animali. Il dio Amon Ra ha la testa di A., e la sua supremazia copre il periodo bimillenario precedente l'era cristiana. In Cina, nel Tao (v.), la divinità del mondo ha testa di A. e piedi rappresentati da due pesci. Un corpo di serpente con il capo di A. presso i celti rappresentava la magia della nascita e dell'origine della vita. Infatti molti monumenti gallici, come quelli di Autun, di Sireuil e di Beauvais, presentano l'immagine di u dio accompagnato da un serpente con la testa di A. Presso i cristiani l'A. si tramuta in agnello pasquale, nell'agnello di dio che si sacrifica volontariamente per la salvezza dei peccatori. È corrispondente all'ascesa del sole, al passaggio dalle tenebre alla luce e dal freddo al caldo. Segno maschile per eccellenza, simboleggia l'indipendenza, il coraggio e la virilità. Secondo l'astrologia, comprende i nati dal 21 marzo al 20 aprile. Viene definito come il più misterioso segno zodiacale, avendo in embrione i tratti salienti degli altri undici, riunendo quindi i loro pregi e difetti. Dotati di una forte personalità, sono istintivamente portati al comando dalla loro volontà di emergere, rifiutando di confondersi con la massa. Se convinti della bontà delle loro ragioni e degli scopi prefissi, sono coraggiosi fino alla temerarietà. Difficile fermarli o convincerli ad agire diversamente, perché sono dotati di una carica dirompente, indomita e trascinante. Scarsamente diplomatici, sono impulsivi e capaci di concludere qualsiasi rapporto anche in perdita se intendono troncarlo ed uscirne. Hanno incredibili capacità creative e distruttive, individualismi eccessivi e prepotenti, ma possiedono capacità di amare, di raggiungere alte mete spirituali, di sacrificarsi per un ideale o per un essere molto amato. Vivono proiettati nel futuro, e ritengono che il tempo non debba loro sfuggire, ed anche che la giovinezza sia un dono immenso e meraviglioso. La loro energia e l'ardore, accomunati al bisogno di primeggiare, li portano ad agire con slancio, impulsivamente, senza eccessive riflessioni. Non essendo né pazienti né costanti, agiscono disordinatamente, convulsamente. "Io" e "subito"
sono di norma le parole chiave della sua vita. Il loro difetto peggiore è l'imprudenza,
che si accompagna ad un continuo desiderio di cambiamento coinvolgente mete, abiti, casa
ed arredamento. Non sono certo casalinghi. Come l'animale che simboleggia il segno,
attacca frontalmente l'ostacolo, senza mai aggirarlo, come se l'adozione di una qualsiasi
tattica costituisse soltanto un'inutile perdita di tempo. Fondamentalmente solo leali,
incapaci di serbare a lungo rancore. Dotati di eccezionale e stringente logica, usano un
linguaggio molto preciso, con capacità e forza di convinzione notevoli. Considerano
religione e filosofia dei modi di vita, e non fatti speculativi ed astratti. Riesce loro
difficile fare tesoro di qualsiasi lezione, per cui sono portati a ripetere gli stessi
errori già commessi. Esotericamente il nato nell'A. può essere considerato come un drago
che lotta contro le tentazioni dell'egoismo e del mondo circostante, quasi un fulgido
eroe, carico di forza, di energia e di coraggio. La sua memoria di vita vissuta si
manifesta in incapacità a programmare, a vivere nel presente ed a ricordare. Dal presente
ricava una lezione per ampliare la sua saggezza spirituale, che è quella che lo induce a
rifiutare la programmazione del domani. Solo vivendo nella cosciente appartenenza al
Tutto, in piena solitudine interiore, potrà accedere alle grandi altezze della vita
spirituale.
 Ario: Famoso eresiarca (Libia
256-Costantinopoli 336 d.C.) è il padre dell’arianesimo (v.). Già discepolo di
Luciano d’Antiochia, nel 306 era ad Alessandria, dove fu ordinato diacono (308) dal
vescovo Pietro, e poco dopo scomunicato per aver aderito allo scisma di Melezio.
Riconciliato dal successore Achilla ed ordinato prete (312), nel 313 fu posto a capo della
chiesa di Baucalis in Alessandria. Fra il 318 ed il 320 ebbero inizio i suoi primi
contrasti col vescovo Alessandro, successore di Achilla, circa la sua dottrina sulla
Trinità, improntata al subordinazionismo, negante la divinità del verbo. Scomunicato
(321) dal suo vescovo, trovò rifugio ed aiuto presso il vescovo Eusebio di Nicomedia, che
fece riconoscere da un sinodo l’ortodossia delle sue dottrine. Durante il soggiorno a
Nicomedia, A. scrisse la sua opera principale, Thalia (banchetto), scritto parte in
prosa e parte in versi, onde rendere più accessibili alle masse le sue teorie.
Costantino, intervenendo nella disputa tra A. ed Alessandro, indisse il concilio ecumenico
di Nicea (325), che condannò A.; ma questi rifiutò di firmare il simbolo conclusivo, e
venne perciò esiliato nell’Illirico. Richiamato in patria, fu riabilitato dal
concilio di Gerusalemme (355), nonostante l’opposizione di Atanasio, patriarca di
Alessandria, che prese la via dell’esilio mentre A. rientrava in città. Scacciato da
un’insurrezione popolare, fu chiamato a Costantinopoli dall’imperatore, per
essere ricevuto nella comunione della Chiesa. Senonché alla vigilia della solenne
cerimonia moriva improvvisamente in una strada della città.
Ario: Famoso eresiarca (Libia
256-Costantinopoli 336 d.C.) è il padre dell’arianesimo (v.). Già discepolo di
Luciano d’Antiochia, nel 306 era ad Alessandria, dove fu ordinato diacono (308) dal
vescovo Pietro, e poco dopo scomunicato per aver aderito allo scisma di Melezio.
Riconciliato dal successore Achilla ed ordinato prete (312), nel 313 fu posto a capo della
chiesa di Baucalis in Alessandria. Fra il 318 ed il 320 ebbero inizio i suoi primi
contrasti col vescovo Alessandro, successore di Achilla, circa la sua dottrina sulla
Trinità, improntata al subordinazionismo, negante la divinità del verbo. Scomunicato
(321) dal suo vescovo, trovò rifugio ed aiuto presso il vescovo Eusebio di Nicomedia, che
fece riconoscere da un sinodo l’ortodossia delle sue dottrine. Durante il soggiorno a
Nicomedia, A. scrisse la sua opera principale, Thalia (banchetto), scritto parte in
prosa e parte in versi, onde rendere più accessibili alle masse le sue teorie.
Costantino, intervenendo nella disputa tra A. ed Alessandro, indisse il concilio ecumenico
di Nicea (325), che condannò A.; ma questi rifiutò di firmare il simbolo conclusivo, e
venne perciò esiliato nell’Illirico. Richiamato in patria, fu riabilitato dal
concilio di Gerusalemme (355), nonostante l’opposizione di Atanasio, patriarca di
Alessandria, che prese la via dell’esilio mentre A. rientrava in città. Scacciato da
un’insurrezione popolare, fu chiamato a Costantinopoli dall’imperatore, per
essere ricevuto nella comunione della Chiesa. Senonché alla vigilia della solenne
cerimonia moriva improvvisamente in una strada della città.
 Arca
dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto
israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate
da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita
dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano
infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore
poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro
scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due
Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei
9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai
Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele
4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei
prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un
padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re
Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).
Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli
oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre
Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del
monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto
in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è
focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham
Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,
Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,
gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della
regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche
peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta
Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione
templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),
noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di
un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato
e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben
protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di
Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata
il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato
l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della
Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una
raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale
della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.
Arca
dell'Alleanza: Nel Pentateuco è così chiamato il più antico e sacro oggetto
israelitico. Costruita da Besaleel, figlio di Uri, secondo le precise indicazioni dettate
da Yahweh a Mosè (Esodo 25, 10-22), consisteva in una cassa di legno di acacia rivestita
dentro e fuori di lamine d'oro puro. Alla base aveva quattro anelli d'oro, in cui erano
infilate in permanenza due stanghe d'acacia per il trasporto. Sulla faccia superiore
poggiava una lastra d'oro detta propiziatorio, sormontata da due cherubini in oro
scolpito, con le ali distese a protezione dell'A. Conteneva l'Alleanza, ovvero le due
Tavole della Legge (v.) ed un'urna d'oro ripiena di manna, nonché la verga di Aronne (Ebrei
9, 4). L'A. seguì gli Israeliti nel loro lungo pellegrinaggio nel deserto. Catturata dai
Filistei, fu presto restituita a causa delle sventure che aveva provocato (I Samuele
4, 6), che fanno pensare all'A. come un ricettacolo di enorme energia divina, fonte dei
prodigi anche spettacolari che essa compiva. Solennemente trasportata da re Davide in un
padiglione sul monte Sion (II Samuele 6), fu definitivamente collocata da re
Salomone nel Tabernacolo del Tempio da lui costruito in Gerusalemme (I Re 8, 3-11).
Nella distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor (587 a.C.) non figura fra gli
oggetti sacri rubati dai Babilonesi (Geremia 52, 17-23) e scomparve per sempre
Un'antica tradizione vuole che il profeta Geremia l'avesse nascosta in una grotta del
monte Nebo (II Maccabei 2, 4-8). Secondo ricerche recentemente condotte soprattutto
in Etiopia, fanno pensare che l'A. non sia altro che il Sacro Graal, oggetto su cui è
focalizzata la leggenda di re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola rotonda (v.). Graham
Hancock, nel suo libro "Il Mistero del Sacro Graal" (Ediz. Piemme,
Casale Mon.to, 1995) sostiene che secondo il Kebra Nagast, il libro sacro ai falasha,
gli ebrei etiopi, nel corso del X secolo a.C. Menelik, figlio di re Salomone e della
regina di Saba, avrebbe praticamente salvato l'A. trasportandola, attraverso rocambolesche
peripezie, proprio in Etiopia. Essa sarebbe tuttora gelosamente custodita nel Sancta
Sanctorum di in uno degli spettacolosi Templi monolitici, di probabile costruzione
templare, presenti nella zona, decorati con numerose croci ansate (Croix pattèe),
noto simbolo dei Cavalieri del Tempio. Si troverebbe ad Axum, sotto la diretta custodia di
un Nebura-ed, il capo dei sacerdoti e guardiano dell'A., l'unico autorizzato
e soprattutto in grado di avvicinare l'A. senza subire danni fisici anche mortali. Ben
protetta all'interno di un Tempio dotato di torri e di merli, denominata Santa Maria di
Sion, essa ne uscirebbe soltanto in occasione della sacra festa popolare detta Timkat, celebrata
il 18 gennaio di ogni anno. Taluni sostengono che in processione non sarebbe portato
l'originale dell'A., ma un talbot, una specie di riproduzione delle Tavole della
Legge, di cui esistono esemplari in tutte le chiese etiopiche, nonché in una
raffigurazione della regina di Saba visibile sotto il porticato esterno settentrionale
della famosissima cattedrale gotica di Chartres, in Francia.
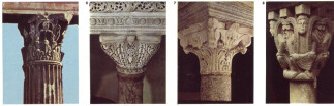 primo
degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per
secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile
romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un
luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il
Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della
tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in
questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di
tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella
transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in
seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel
neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato
dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi
materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art
Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità
offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi
prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche
e funzionali, propugnato dal funzionalismo.
Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni
dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le
nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si
sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza
verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più
rappresentativi, ovvero:
primo
degli stili rigorosamente definiti che, per fasi successive, scandiscono per
secoli la storia dell'A. occidentale. Segue poi il gotico che, dello stile
romanico, dissolve la spazialità chiusa, trovando la propria espressione in un
luminoso verticalismo teso verso gli spazi celesti (v. Chartres). Il
Quattrocento evidenzia un'A. protesa verso il recupero rinascimentale della
tradizione greca e romana, ed il peculiare sviluppo dell'A. civile. È in
questo periodo che nasce il tipo del palazzo moderno. L'Italia fu al centro di
tale rinnovamento, e continuò a tenere una posizione dominante nella
transizione dell'A. rinascimentale al manierismo prima ed al barocco poi, in
seguito evolutosi e dissoltosi nei preziosismi dello stile rococò e nel
neoclassicismo. Lo sviluppo dell'A. moderna è stato caratterizzato
dall'innovazione delle tecniche costruttive, e dall'impiego di nuovi
materiali, dal ferro al cemento armato. Agli inizi del Novecento l'Art
Nouveau trasformò in esiti prevalentemente decorativi le nuove possibilità
offerte dalla rivoluzione industriale nell'A., ma nei decenni successivi
prevalse invece il criterio di una rigorosa corrispondenza tra ragioni estetiche
e funzionali, propugnato dal funzionalismo.
Recentemente l'A. organica mira ad integrare le tradizionali funzioni
dell'edificio con altre più complesse, in una prospettiva che considera le
nuove esigenze legate a fattori urbanistici e sociali. Dopo gli anni Sessanta si
sono infine manifestate un'accentuata ricerca tecnologica ed una tendenza
verso l'eclettismo. Nella figura a colori sono rappresentati i capitelli più
rappresentativi, ovvero: