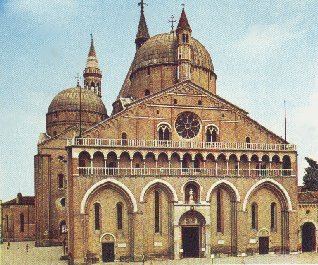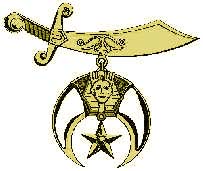 Antico Ordine
Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of
the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le
due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una
semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di
ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.
Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,
disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora
usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si
risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i
membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la
Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.
Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,
che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,
nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati
Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto
che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato
il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming
venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna
pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più
frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di
55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente
William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I
membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente
tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906
venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre
360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini
invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i
bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento
ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto
anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno
validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al
Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.
I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a
titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti
per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte
di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai
contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello
Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli
Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European
Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio
Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti
Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi
è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.
Antico Ordine
Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of
the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le
due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una
semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di
ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.
Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,
disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora
usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si
risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i
membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la
Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.
Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,
che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,
nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati
Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto
che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato
il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming
venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna
pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più
frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di
55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente
William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I
membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente
tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906
venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre
360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini
invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i
bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento
ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto
anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno
validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al
Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.
I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a
titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti
per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte
di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai
contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello
Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli
Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European
Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio
Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti
Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi
è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.
 Antico Rito Noachita: L’Antico
Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e
gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della
Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della
Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate
forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi
e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore
dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;
nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i
viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque
post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e
sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre
gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:
1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real
Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza
di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato
l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre
articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica
essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una
Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo
biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,
dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,
secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale
più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione
dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado
il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel
luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai
Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,
quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano
tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di
lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama
l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua
potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi
tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua
insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato
sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione
umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si
uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base
del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni
del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta
tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla
sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della
verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica
e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore
crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza
condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate
dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo
che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la
vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa
ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La
vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui
fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte
dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che
nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata
proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse
internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del
noachismo massonico italiano.
Antico Rito Noachita: L’Antico
Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e
gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della
Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della
Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate
forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi
e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore
dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;
nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i
viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque
post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e
sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre
gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:
1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real
Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza
di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato
l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre
articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica
essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una
Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo
biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,
dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,
secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale
più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione
dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado
il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel
luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai
Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,
quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano
tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di
lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama
l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua
potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi
tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua
insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato
sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione
umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si
uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base
del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni
del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta
tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla
sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della
verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica
e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore
crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza
condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate
dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo
che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la
vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa
ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La
vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui
fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte
dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che
nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata
proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse
internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del
noachismo massonico italiano.
 Antico
Testamento: È un’espressione fu impiegata per la prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "Testamento" è
l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in
cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio. È
la prima delle due parti di cui è composta la Bibbia (v.) dei cristiani, corrispondente a
grandi linee alla Bibbia ebraica, nota come Tanak. Tale termine è formato dalle
iniziali dalle tre parole che indicano le sue parti: Töràh (Pentateuco), Nevi’im
(Profeti) e Ketüvim (Scritti ed Agiografi). Dagli ebrei viene anche usato il
termine miqrä, lettura. Si presume che fin dall’antichità esistesse una
biblioteca sacra in cui probabilmente si conservavano il Decalogo, il Libro
dell’Alleanza (con il Libro delle guerre del Signore, Numeri 21, 14, ed il
Libro del Giusto, Giosué 10, 13), il Patto di Giosué (G. 24, 26) ed il Patto
di Samuele(I S. 10, 25). In II Re 22 si parla del Libro della Legge,
trovato nei sotterranei del Tempio durante il regno di re Giosia (forse il Deuteronomio).
In Re sono ricordati il Libro degli atti di Salomone, ed i Libri degli
Annali dei re di Giuda e dei re d’Israele. I manoscritti del Mar Morto (v.), di
cui il più antico frammento è stato datato al V secolo a.C., ed i più recenti al II
secolo d.C., hanno –restituito tutti i libri dell’A. con eccezione del Libro
di Ester. È interessante rilevare che nei diversi manoscritti si riscontrano varianti che aiutano a spiegare le differenze tra il testo comunemente accettato e le più antiche traduzioni conosciute: la greca dei Settanta (v.) e quella aramaica. Una lista redatta nel corso del sinodo di Yamnia (90-100 d.C.) sintetizza i risultati di una lunghissima indagine selettiva (durata dal V secolo a.C. al II secolo d.C.), elenca i 24 libri ritenuti di ispirazione divina, detti canonici, mentre i libri non accettati furono poi definiti extracanonici od apocrifi. I 24 libri canonici sono: 5 Torah; Pentateuco;
Bereshit (Genesi); Shemot (Esodo); Waiqra (Levitico); Bamidbar
(Numeri); Devarim (Deuteronomio); 8 Nëvi’im (Profeti); 4 ri’shonim
(anteriori); Yehoshua’ (Giosué); Shöfetim (Giudici); Shemü’el
(Samuele I e II); Melakhim I-II (Re I e II); 4 aharönim (posteriori); Yesha’yah
(Isaia); Yirmeyäh (Geremia); Yehezqë’l (Ezechiele); 12 profeti
minori in un solo libro: Höshëa’ (Osea), Yö’ël (Gioele), ‘Amos;
‘Obadyah (Abdia), Yönah (Giona), Mikhäh (Michea), Nahuma, Habacük
(Abacuc), Zefanyäh (Sofonia), Hagay (Aggeo), Zekaryah (Zaccaria),
Mal’äkhi (Malachia); 11 Këtuvin (Agiografi); Tehillim (Salmi); Mishlòë
(Proverbi), ‘Iyöb (Giobbe), Shir hashirim (Cantico dei cantici), Rüt,
‘Ekhah (Lamentazioni), Qohelet (Ecclesiaste), ‘Estër, Däni’el
(Daniele), ‘Ezra-nehemyäh (Esdra-Neemia), Divrë hayämin I-II (Cronache
I-II). In contrasto con la decisione di Yamnia, gli Ebrei di Alessandria d’Egitto,
che da tempo avevano adottato la lingua greca, considerarono ispirati alcuni libri scritti
originariamente in greco, adottando una raccolta più ampia della precedente, come risulta
dai manoscritti dei Settanta. Tale raccolta servì da base per il Canone
cattolico dell’A., di cui fanno parte alcuni degli apocrifi, con denominazione
cristiana Deuteronomio, ed alcune aggiunte ai libri di Daniele ed Esdra. La Bibbia
protestante segue invece il canone ebraico. L’espressione A. fu impiegata per la
prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "testamento" è l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio.
Antico
Testamento: È un’espressione fu impiegata per la prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "Testamento" è
l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in
cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio. È
la prima delle due parti di cui è composta la Bibbia (v.) dei cristiani, corrispondente a
grandi linee alla Bibbia ebraica, nota come Tanak. Tale termine è formato dalle
iniziali dalle tre parole che indicano le sue parti: Töràh (Pentateuco), Nevi’im
(Profeti) e Ketüvim (Scritti ed Agiografi). Dagli ebrei viene anche usato il
termine miqrä, lettura. Si presume che fin dall’antichità esistesse una
biblioteca sacra in cui probabilmente si conservavano il Decalogo, il Libro
dell’Alleanza (con il Libro delle guerre del Signore, Numeri 21, 14, ed il
Libro del Giusto, Giosué 10, 13), il Patto di Giosué (G. 24, 26) ed il Patto
di Samuele(I S. 10, 25). In II Re 22 si parla del Libro della Legge,
trovato nei sotterranei del Tempio durante il regno di re Giosia (forse il Deuteronomio).
In Re sono ricordati il Libro degli atti di Salomone, ed i Libri degli
Annali dei re di Giuda e dei re d’Israele. I manoscritti del Mar Morto (v.), di
cui il più antico frammento è stato datato al V secolo a.C., ed i più recenti al II
secolo d.C., hanno –restituito tutti i libri dell’A. con eccezione del Libro
di Ester. È interessante rilevare che nei diversi manoscritti si riscontrano varianti che aiutano a spiegare le differenze tra il testo comunemente accettato e le più antiche traduzioni conosciute: la greca dei Settanta (v.) e quella aramaica. Una lista redatta nel corso del sinodo di Yamnia (90-100 d.C.) sintetizza i risultati di una lunghissima indagine selettiva (durata dal V secolo a.C. al II secolo d.C.), elenca i 24 libri ritenuti di ispirazione divina, detti canonici, mentre i libri non accettati furono poi definiti extracanonici od apocrifi. I 24 libri canonici sono: 5 Torah; Pentateuco;
Bereshit (Genesi); Shemot (Esodo); Waiqra (Levitico); Bamidbar
(Numeri); Devarim (Deuteronomio); 8 Nëvi’im (Profeti); 4 ri’shonim
(anteriori); Yehoshua’ (Giosué); Shöfetim (Giudici); Shemü’el
(Samuele I e II); Melakhim I-II (Re I e II); 4 aharönim (posteriori); Yesha’yah
(Isaia); Yirmeyäh (Geremia); Yehezqë’l (Ezechiele); 12 profeti
minori in un solo libro: Höshëa’ (Osea), Yö’ël (Gioele), ‘Amos;
‘Obadyah (Abdia), Yönah (Giona), Mikhäh (Michea), Nahuma, Habacük
(Abacuc), Zefanyäh (Sofonia), Hagay (Aggeo), Zekaryah (Zaccaria),
Mal’äkhi (Malachia); 11 Këtuvin (Agiografi); Tehillim (Salmi); Mishlòë
(Proverbi), ‘Iyöb (Giobbe), Shir hashirim (Cantico dei cantici), Rüt,
‘Ekhah (Lamentazioni), Qohelet (Ecclesiaste), ‘Estër, Däni’el
(Daniele), ‘Ezra-nehemyäh (Esdra-Neemia), Divrë hayämin I-II (Cronache
I-II). In contrasto con la decisione di Yamnia, gli Ebrei di Alessandria d’Egitto,
che da tempo avevano adottato la lingua greca, considerarono ispirati alcuni libri scritti
originariamente in greco, adottando una raccolta più ampia della precedente, come risulta
dai manoscritti dei Settanta. Tale raccolta servì da base per il Canone
cattolico dell’A., di cui fanno parte alcuni degli apocrifi, con denominazione
cristiana Deuteronomio, ed alcune aggiunte ai libri di Daniele ed Esdra. La Bibbia
protestante segue invece il canone ebraico. L’espressione A. fu impiegata per la
prima volta dall’apostolo Paolo (2 Corinzi 3, 14); "testamento" è l’atto giuridico unilaterale mediante il quale si dona senza ricevere alcunché in cambio, ed in questo specifico caso indica il dono gratuito della Rivelazione di Dio.
Anticristo: Anti Messia, in cui il prefisso ha il duplice significato di opposizione e di sostituzione. Avversario di Cristo che, verso la fine dei tempi, sedurrà molti cristiani, ma sarà poi annientato proprio da Cristo nella sua parusìa (v.). Nell’apocalittica giudaica non appare un A.
individuale, ma prevale un’identificazione fra A. e nemico del popolo di Dio. Neanche
i Vangeli parlano di un A. individuale, e Gesù si limita a preannunciare molti
pseudocristi e pseudoprofeti (Matteo 24-25; Marco 13, 22; Giovanni 5,
43). La prima menzione esplicita dell’A. appare in s. Paolo, che lo identifica con
l’uomo dell’iniquità, colui che si contrappone e s’innalza sopra
ogni cosa che viene definita Dio, fino ad assidersi nel tempio di Dio, additando sé
stesso come Dio (II Tessalonicesi 2). Nelle sue epistole Giovanni afferma che
l’A. è già nel mondo, anzi "sono già apparsi molti A." (I
2, 18), e dichiara: "Questi è l’A. che nega il Padre ed il
Figlio" (I 2, 22). L’Apocalisse è il quadro profetico della lotta fra
Cristo e l’A.: la Bestia del mare (13, 1-8) che combatte e vince i Santi di Dio è
l’A. politico, mentre la Bestia della terra (13, 11-17), che le è subordinata come profeta,
è lo pseudoagnello. Dal II secolo ad oggi gli esegeti hanno riconosciuto nell’A.
una persona individuale; ma abbiamo visto che questa tesi non trova riscontro negli
scritti biblici, perché anzi dai testi di Paolo e Giovanni l’A. appare come il segno
di un’opposizione collettiva. Le identificazioni individuali dell’A. sono state
innumerevoli nella storia: da Caligola a Nerone, fino a Federico II e Napoleone e, in
tempi più recenti, Hitler e Stalin. Nel Medioevo si accentua la paurosa attesa
dell’A., nel clima del millenaresimo (v.); ma spesso il termine ha senso
esecrativo, come in Caterina da Siena, che chiama l’antipapa Clemente "A. e
membro del demonio" (lettera 306). Poiché il concetto di A. è sempre stato
accoppiato all’idea di apostasia (v.), l’attuale apostasia progressiva del mondo
moderno ha fatto identificare l’A. con questo mondo materialista ed ateo
(Merezkovskij). Leone XIII denuncia "l’odio implacabile che arde nel cuore di
Satana" (Humanum genus, 1884), e Pio X ravvisa l’A. nella società atea e
pagana (E supremi apostolatus cathedra, 1903). È quindi ormai prevalente, in tutti gli esegeti moderni, l’identificazione dell’A. in una forma collettiva, in cui il male si oppone a Cristo e vi si sostituisce.
Antidoro:
Termine impiegato nel culto greco ortodosso per definire il
pane benedetto, ma non consacrato, distribuito ai fedeli che, per varie ragioni,
non possono accostarsi all'Eucarestia (v.). Viene anche così chiamato il pane
dal quale è staccata la parte da consacrare. Derivato dal greco, significa «invece
del dono», ed infatti sostituisce il «dono»,
ovvero l'Eucarestia, un sacramento che la liturgia greca definisce «dono
santo».
Antilegomena:
Termine derivato dal greco, che significa «contestati».
Rappresenta dato da Clemente Alessandrino e da Eusebio ad alcuni libri del Nuovo
Testamento (v.), non tutti accettati dal Canone (v.). Tra questi l'Apocalisse
di San Giovanni, di San Giuda e di San Giacomo, nonché la seconda lettera di
San Pietro. La medesima denominazione è stata estesa dalla Chiesa ad alcune
opere considerate non ispirate, come i Vangeli apocrifi (v.). Gli A. vengono
indicati anche con il nome di Deuterocanonici.
Antimonio: Nella tradizione alchemica è una sostanza che può annulla tutti i veleni, ed ha qualità simili a quelle della Pietra Filosofale (v.). Per tale ragione viene anche denominato Grande Arcano (v.) o
Pietra del Fuoco, Acqua celeste, Anima intellettuale, in grado di liberare l’essere
umano dalle scorie materiali, innalzandolo spiritualmente. Nel Seicento il simbolo
dell’A. era il Quadrato sormontato dal Triangolo, che ricorda la pietra Piramidale,
presente tra i simboli di molte Logge massoniche. Nell’A. è anche compreso il
conectto del Rebis (v.), termine composto da res (cosa) e bis (doppia).
Basilio Valentino (v.) definisce l’A. il Lupo grigio dei filosofi. Nella
Grande Opera degli Alchimista, il De Yge sostiene che "Nell’isola di Chio
(Mar Egeo) sorgeva una statua della dea Diana, la quale vista da lontano appariva
mostruosa, mentre da vicino era invece bella e gradevole. Per lui questa era una
rappresentazione, seppure alquanto ingenua, dell’A. e delle sue caratteristiche.
Antinomiani:
Nome di alcune sette eretiche, dette anche Anomiani, sorte al
tempo della Riforma. Tra queste la più importante come capo I. S. Agricola,
detto anche Schmitar, teologo tedesco, dapprima amico e poi avversario di Martin
Lutero. Gli A. sostenevano tra l'altro la piena libertà del cristiano da ogni
vincolo morale, rinnegando il principio luterano secondo cui la sola fede
sarebbe sufficiente a garantire la salvezza dell'anima.
Antipapa: Colui che, eletto al papato in modo non canonico, ne assume le dignità e l’autorità, provocando tra i fedeli una scissione, e spesso un vero scisma. La storia degli A. è lunga e complessa, ed anche il numero di essi è incerto: da Ippolito (217-235), prete romano, che fu poi martire e santo, fino a Felice V (Amedeo di Savoia, 1440-49), I computi variano dai 25 ai 40. Questa differenza dipende dai diversi criteri seguiti per definire il concetti di A.: per es., mentre gli storici protestanti attribuiscono valore alla deposizione di un papa legittimo per motivi politici, i cattolici lo negano assolutamente. In occasione del grande scisma di Occidente, vi furono contemporaneamente anche due diversi A., di obbedienza avignonese o pisana. In contrasto con l’obbedienza romana. Vari concili hanno comminato pene severissime agli A. ed ai loro fautori, pene acquisite negli articoli (can. 2314) del codice di diritto canonico (v. Papi).
Antonio
abate:
Santo (Coma, Aeman, medio Egitto 250-deserto presso il Mar Rosso, 355). Sant'Atanasio lo definì fondatore dell?ascetismo. Rimasto orfano a 18 anni, distribuì ai poveri tutti i suoi beni e si ritirò al di là del Nilo in un castello abbandonato, dove visse per vent?anni, e dove affrontò numerose tentazioni diventate leggendarie. Il suo esempio gli attrasse molti discepoli, che presto costituirono una vasta schiera di eremiti, di cui A. era padre e maestro (305). Durante la persecuzione di Massimino Daia (310) venne ad Alessandria per confortare e soccorrere i cristiani. Ritornata la pace, A. si ritirò in più stretto isolamento nel deserto presso il Mar Rosso, da dove Sant?Atanasio lo richiamò in Alessandria (335) per combattere gli ariani, molti dei quali furono da lui stesso ricondotti alla fede. Ritornato nel suo ritiro, visse ancora vent?anni. Prima di morire si fece promettere dai due discepoli più vicini a lui che non avrebbero mai rivelato il luogo della sua sepoltura. Secondo la leggenda, la tomba sarebbe stata scoperta nel 565, ed i suoi resti portati ad Alessandria, poi a Constantinopoli (635) e quindi in Francia (IX-X secolo), a St. Didier-de la Motte, e finalmente a St. Julien di Arles (1491), dove sono tuttora conservati. La figura di A., già grande per la sua ascesi personale, assume un?enorme importanza per l?influsso che ebbe sulla vita eremitica, costituendo comunità che vivevano una vita simile, con pratiche comuni, ma senza una regola determinata. La devozione attribuitagli divenne presto molto popolare: si faceva ricorso a lui contro le epidemie e le pestilenze, e specialmente contro il «fuoco di Sant'Antonio» (herpes zoster). Nell'iconografia A.
viene rappresentato come un vecchio dalla lunga barba bianca e con ampio saio.
Porta il bastone degli eremiti a forma di T (detta croce egizia di
Sant'Antonio) ed un campanello che, come pure il porco sempre raffigurato nei
suoi pressi, ricorda taluni privilegi medievali concessi all'ordine degli
Antoniani, ora scomparso. A. è protettore degli animali domestici, ed il giorno
della sua festa (17 gennaio) ha luogo la benedizione degli animali, che in varie
città assume aspetti tradizionali particolari. La vigilia di tale festa in
molte località vengono accesi i falò di Sant'Antonio, enorme cataste di
legna formate con la partecipazione collettiva, che bruciano per vari giorni, e
di cui ognuno conserva poi qualche tizzone propiziatorio.
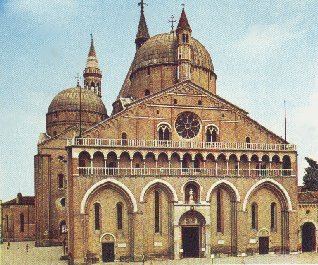 Antonio
da Padova: Santo e dottore della Chiesa (Lisbona 1195-Arcella, Padova, 1231). Entrato fra i canonici regolari di Sant’Agostino, studiò dialettica e teologia nel famoso monastero di Santa Croce in Coimbra. Nel 1220 entrò nell’ordine francescano, e partì per il Marocco sennonché, ammalatosi, riparò in Sicilia. Partecipò poi al Capitolo generale della Porziuncola (1221), dove incontrò San Francesco, e dove venne assegnato alla provincia di Romagna, nell’eremo di Montepaolo, presso Forlì. Rivelatosi valente oratore, fu destinato alla vita attiva, nell’insegnamento e nella predicazione. Primo tra i frati minori, insegnò teologia a Bologna ai suoi confratelli, avendone avuta licenza da San Francesco stesso. In Francia (1225) predicò in varie città, ed insegnò a Montpellier ed a Tolosa. Ritornato in Italia, fu ministro provinciale per l’Italia superiore dal 1227 al 1230. Ripresa la via dell’apostolato attivo, ottenne strepitosi successi con la sua predicazione avvalorata da numerosi miracoli. Canonizzato da Gregorio IX (1232) soltanto undici mesi dopo la morte, venne nominato dottore della Chiesa da Pio XII (1946). La formazione di A. era essenzialmente biblica; papa Gregorio IX lo definì «Arca del
Testamento e Scrigno delle sacre Scritture». A. segue la teologia
agostiniana, specialmente nel problema della Grazia. Ma più che uno
speculativo, egli fu essenzialmente pratico, dando alla sua
predicazione un tono popolare estremamente efficace. Gli scritti di cui
è stata accertata l'autenticità sono «Sermones
per annum dominicales», (prediche per le domeniche di un intero anno), e «Sermones
im festivitatibus Sanctorum», (prediche per le feste dei Santi), in cui A.
si rivela, oltre che un maestro di oratoria sacra, anche un asceta ed un mistico
profondo. In figura la famosa Basilica di Sant'Antonio a Padova (1231-1300).
Antonio
da Padova: Santo e dottore della Chiesa (Lisbona 1195-Arcella, Padova, 1231). Entrato fra i canonici regolari di Sant’Agostino, studiò dialettica e teologia nel famoso monastero di Santa Croce in Coimbra. Nel 1220 entrò nell’ordine francescano, e partì per il Marocco sennonché, ammalatosi, riparò in Sicilia. Partecipò poi al Capitolo generale della Porziuncola (1221), dove incontrò San Francesco, e dove venne assegnato alla provincia di Romagna, nell’eremo di Montepaolo, presso Forlì. Rivelatosi valente oratore, fu destinato alla vita attiva, nell’insegnamento e nella predicazione. Primo tra i frati minori, insegnò teologia a Bologna ai suoi confratelli, avendone avuta licenza da San Francesco stesso. In Francia (1225) predicò in varie città, ed insegnò a Montpellier ed a Tolosa. Ritornato in Italia, fu ministro provinciale per l’Italia superiore dal 1227 al 1230. Ripresa la via dell’apostolato attivo, ottenne strepitosi successi con la sua predicazione avvalorata da numerosi miracoli. Canonizzato da Gregorio IX (1232) soltanto undici mesi dopo la morte, venne nominato dottore della Chiesa da Pio XII (1946). La formazione di A. era essenzialmente biblica; papa Gregorio IX lo definì «Arca del
Testamento e Scrigno delle sacre Scritture». A. segue la teologia
agostiniana, specialmente nel problema della Grazia. Ma più che uno
speculativo, egli fu essenzialmente pratico, dando alla sua
predicazione un tono popolare estremamente efficace. Gli scritti di cui
è stata accertata l'autenticità sono «Sermones
per annum dominicales», (prediche per le domeniche di un intero anno), e «Sermones
im festivitatibus Sanctorum», (prediche per le feste dei Santi), in cui A.
si rivela, oltre che un maestro di oratoria sacra, anche un asceta ed un mistico
profondo. In figura la famosa Basilica di Sant'Antonio a Padova (1231-1300).
Antonismo:
Moderno movimento religioso che prende il nome da Luis Antoine
(1846-1912), un guaritore belga che promulgò una dottrina in cui convergono
idee attinte alle scienze occulte, alla teosofia (v.) ed alla religione
cristiana.
Antropofagia:
Termine derivato dal greco
andrwpofagia,
composto di andropoz,
uomo, e fagein,
mangiare. Definisce l'usanza di cibarsi di carni umane a scopi liturgici o
magici, o più semplicemente alimentari. Tale costume, diffuso in età neolitica
nel nord Europa e nell'Africa settentrionale, si era conservato in altre aree
fino a tempi relativamente recenti, e presso comunità di tipo etnologico, me di
livelli poco sviluppato. I principali focolai dell'A. si trovavano
nell'Africa equatoriale, nella Melanesia (Nuova Guinea, dove pare permanga
tuttora, Nuova Caledonia ed in Amazzonia). L'A. è conosciuta anche sotto il
nome di cannibalismo, termine derivato da Cannibi, nome con cui erano noti i
Caribi, popolo stanziato a Nord del Rio delle Amazzoni che abitualmente si
nutriva di carne umana. Le forme di A. sono due: l'endocannibalismo
e l'esocannibalismo. Il primo era
praticato all'interno di ciascun gruppo umano, e poteva avere una coppia di
opposte giustificazioni. Innanzitutto si volgeva ai soli familiari defunti e
deceduti per cause naturali, poiché si riteneva che così venisse loro offerta
la sepoltura più degna; talvolta tale patrofagia non veniva compiuta
direttamente sulle carni, in quanto comportava l'ingestione delle ceneri dei
corpi degli estinti, preventivamente cremati. La seconda forma aveva invece
carattere giudiziario, servendo a punire violazioni tribali particolarmente
gravi. Un suo ulteriore aspetto rappresentava il coronamento di una morte
violenta, inferta ad un membro di un'altra comunità nel corso di una
battaglia o di un'imboscata. In tali casi non era raro che si trascurassero le
carni, dato che il vincitore si limitava a nutrirsi del cervello, del cuore e
del fegato dell'avversario caduto, per assimilarne le virtù ed accrescere la
propria forza vitale. , secondo le ricorrenti ed universali credenze magiche
interessanti questi organi. Una fisionomia fluttuante assumeva il cannibalismo
rituale, ovvero inteso come offerta sacrificale alle forze soprannaturali.
Infatti per tali fini le vittime potevano essere prescelte, a seconda delle
circostanze, all'interno od all'esterno della comunità. Solitamente questa
forma di A. aveva luogo in occasione di feste agrarie e stagionali, oppure per
consacrare determinate investiture iniziatiche o sociali. Molto più rara era
l'A. profana, compiuta per pure ragioni alimentari, e considerata una sorta di
degenerazione degli stessi popoli antropofagi. Tuttavia essa sussistette qua e là,
e di norma comportava una specie di «allevamento» della futura vittima,
costretta a nutrirsi di cibi ingrassanti. Forme analogamente deviate di sciamanesimo
(v.), poterono talvolta comportare pratiche cannibalistiche, perché attraverso
queste il sacerdote stregone riteneva di potere aumentare i propri poteri
magici. Ciò si registrò soprattutto laddove s'inserì il costume della
caccia alle teste.
Antropolatria:
Termine derivato dal greco, che definisce: 1) il culto di un
essere umano al quale sono attribuite qualità divine poiché concepito come
divinità; 2 il culto di un dio concepito come un essere umano. Una forma di A.
può essere considerato il culto per la persona dell'imperatore romano.
Secondo W. Ensslyn (Storia del Mondo
antico, Il Saggiatore, Ediz. Garzanti, Vol IX), «Allorché l'Imperatore è stato assimilato agli dei, il culto
imperiale originariamente limitato alle province è diventato universale, al
punto che una colonia africana poteva dedicare un'iscrizione al “dio
Aureliano”. L'alta tendenza, che
riconosceva come sovrumano il rango imperiale, vedeva in lui lo strumento
dell'intervento divino, riconoscendolo quindi come un favorito degli dei,
arrivando ad ammettere ed a ricercare un rango speciale per l'unico padrone di
tutto. Sia che si credesse nella divinità rivelata dell'imperatore oppure nel
favore divino che lo sosteneva, vi era sempre qualcosa di divino nella sua
persona e nella sua carica. Grazie a tale concessione del favore divino, fu più
tardi possibile per gli imperatori cristiani esprimere la caratteristica santità
del loro rango nel cerimoniale tradizionale, ricevere la debita espressione di
reverenza e conservare le insegne e le vesti imperiali».
Antropologia: Scienza che studia l’uomo come fenomeno biologico (A. fisica) e, in senso più ampio, ne considera anche gli aspetti evolutivi, comportamentali, culturali e di rapporto con l’ambiente naturale (A. culturale). Sebbene lo studio dell’uomo rientrasse già nelle speculazioni dei filosofi greci, fu solo con il positivismo e l’evoluzionismo (v.) che incominciò ad assumere un aspetto scientifico attraverso la raccolta e la comparazione di dati, e la diffusione di varie teorie sullo sviluppo dell’umanità. Dalla fine del XIX secolo, con la critica all’evoluzionismo, l’A. incominciò a differenziarsi in diverse branche, sempre più specializzate: paletnologia, paleoantropologia, A. biologica, A. sociale, A. linguistica, e così via.
Antropomanzia: Specie di divinazione in uso nell'antica Grecia, realizzata attraverso l'esame delle viscere delle vittime umane. Nell'Odissea il poeta Omero racconta che, durante il ritorno dalla guerra di Troia, Menelao ed Elena vennero sbattuti da una tempesta sulle coste dell'Egitto; per conoscere le volontà del Fato vennero allora uccisi due bambini egiziani, le cui viscere ancora palpitanti furono interrogate.
Antropomorfismo: Nella tipologia religiosa significa l'attribuzione di forme fisiche e di sentimenti umani alle figure divine. Indica come gli antichi identificassero gli dei, concepiti quali partecipi delle qualità e dei vizi dei mortali, seguendo così il processo inverso per cui le religioni moderne ritengono l'essere umano creato ad immagine e somiglianza di Dio. L'A. ingigantì negli dei le qualità ed i vizi umani, e li fece signori dello spazio e del tempo. Unica limitazione al loro potere era costituito dal Fato, al quale lo stesso Giove doveva piegarsi.
Antroposofia: (v. anche Encyclopaedia Esoterica) Denominazione assegnata ad una via della conoscenza che vorrebbe condurre lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'Universo. Sorge nell'uomo come un bisogno del cuore e del sentimento. L'A. è mediatrice di conoscenze ottenute per via spirituale. Ma lo è solo perché la vita quotidiana e la scienza fondata sulla percezione dei sensi e sull'attività dell'intelletto conducono ad un limite del sentiero della vita, raggiunto il quale l'esistenza animica umana dovrebbe perire, se non fosse in grado di varcare il limite. La vita quotidiana e la scienza non conducono al limite in modo che sia necessario arrestarvisi, ma, a quel limite della percezione dei sensi, attraverso l'anima umana stessa, si apre la vista sul mondo spirituale. L'esperienza comune della vita mostra la massima dipendenza della vita spirituale dell'uomo dall'esistenza corporea. Qui si sveglia nell'uomo la coscienza che, nell'esperienza comune della vita, l'autoconoscenza potrebbe essere andata perduta. Sorge allora l'ansiosa domanda se possa esservi un'autoconoscenza che trascenda l'esperienza comune della vita ed arrivi alla certezza intorno ad un vero Sè. L'A. vuole dare una risposta a questa domanda, sulla base di una sicura esperienza dello Spirito. Dovrebbe da ciò risultare chiaro che l'A. non differisce dalla Teosofia, ovvero la saggezza che va al di là del mondo sensibile, nel mondo divino, se
non per il fatto che con l'investigazione del mondo dello spirito l'A. estrae soprattutto
i risultati che si riferiscono all'essenza spirituale dell'uomo (Internet).
 Anubi: v. Anubis.
Anubi: v. Anubis.
Anubis: Antica divinità appartenente al pantheon egizio, il cui nome geroglifico è Inpu, quello che ha la forma del cane.
Veniva normalmente rappresentato da un corpo umano con la testa di sciacallo. Sua madre è
Nefti, suo padre tanto Seth che Osiride; da alcuni era anche
considerato figlio di Thot-Hermes e di Iside. In stretto rapporto con la saga osiriaca, A.
aiuta Iside a recuperare, ricomporre ed imbalsamare il corpo di Osiride, tagliato a pezzi
dal fratello Seth. In tale compito A. era assistito dai quattro figli di Horus, preposti
alla protezione delle viscere dei defunti conservate nei vasi canopici. poi inventa per
lui i riti di mummificazione. Diventa così Capo del Padiglione divino, cioè del tempio
della mummificazione. Quindi è il dio degli imbalsamatori. "Signore del paese
dell'Aurora". A. fa sorgere la luce anubiana dell'iniziazione, che corrisponde a
questo momento ambiguo, "tra cane e lupo", in cui giorno e notte si
compenetrano. Psicopompo, egli è quello che apre le vie (Upuaut), che conduce le
anime verso il regno di Osiride. Una funzione questa che lo farà poi assimilare a San
Cristoforo. Una sua statua era collocata nei sepolcri, nei pressi della mummia del
defunto, come protezione degli arredi funerari dai violatori di tombe. A. resta immobile
sulla cassa dei segreti, il misterioso sarcofago in cui si compie il prodigio della
risurrezione. Durante il nuovo Regno un sacerdote con la maschera di A. sul viso
raddrizzava la mummia su un monticello, per i riti dell'apertura della bocca. A.
infatti ha tra i suoi titoli quello di "colui che è sulla montagna". I
suoi colori sono il nero, simbolo del lavoro di rigenerazione nell'oscurità, e l'oro
della rinascita iniziatica. Interprete dei sette libri di Thoth, la tradizione ermetica lo
chiama Hermanubi (Thoth-Hermes+Anubi). "O Anubis, che è nei suoi segreti.
Signore dei segreti ad occidente, Signore di ciò che è nascosto" (dal Libro dei
Morti). Il suo ideogramma o geroglifico è l.
Apis: Una delle principali divinità egizie, raffigurato con la testa di sparviero e con tutti gli attributi delle deità solari. A. era sposo della dea Iside, e si identificava con il dio Osiride, come veniva chiamato ancor prima della sua venuta a Menfi. La tradizione si sbizzarrisce a lungo nell'enumerare le particolarità del corpo del sacro bue A., nel quale il dio prese corpo. Era di colore nero, con una macchia bianca e quadrata sulla fronte, ed un'altra dello stesso colore ma a forma di luna piena. Dal dorso una terza macchia, a forma d'aquila, si estendeva sui fianchi. Sotto la lingua un nodo ricordava la figura del sacro scarafaggio. In tale complessa figura bovina, secondo lo storico Diodoro Siculo, dimorava il dio Osiride. Quando il primo bue A. morì, Osiride trasmigrò nel corpo del bue prescelto per la successione. Il nuovo bue sacro doveva essere accudito solo da donne; in una città posta sulle riva del Nilo veniva lavato e nutrito per quaranta giorni, per essere poi caricato su una nave dorata e così condotto lungo il grande fiume fino a Menfi. Qui il sacro bue era ricevuto dai sacerdoti del dio, attorniati da innumerevoli fedeli esultanti, che si avvicinavano il più possibile spingendo avanti i figli, perché dal soffio di A. acquistassero il dono della profezia. Nel tempio di Osiride venivano approntate due diverse stalle e, a seconda di quale veniva prescelta dall'animale, si traevano pronostici di felicità o di pubblica sventura. Come oracolo A. veniva consultato in modo perlomeno curioso. Intanto la sua risposta non era ritenuta favorevole se rifiutava il cibo offertogli. Poi il sacerdote consultante accostava un orecchio alla bocca del bue, per uscire subito di corsa dal tempio, otturandosi le orecchie con le mani. Uscito all'aperto liberava le orecchie, e considerava le prime parole udite come la risposta diretta del dio. Quando A. era giunto alla fine dei suoi giorni, il sacro bue veniva solennemente condotto sulle sponde del Nilo, dov'era fatto annegare tra i pianti ed i lamenti della popolazione, proprio come se lo stesso dio Osiride avesse concluso la propria esistenza terrena. Il suo ideogramma o geroglifico è !.
 Antico Rito Noachita: L’Antico
Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e
gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della
Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della
Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate
forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi
e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore
dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;
nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i
viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque
post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e
sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre
gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:
1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real
Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza
di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato
l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre
articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica
essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una
Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo
biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,
dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,
secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale
più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione
dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado
il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel
luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai
Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,
quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano
tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di
lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama
l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua
potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi
tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua
insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato
sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione
umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si
uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base
del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni
del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta
tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla
sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della
verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica
e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore
crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza
condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate
dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo
che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la
vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa
ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La
vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui
fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte
dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che
nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata
proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse
internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del
noachismo massonico italiano.
Antico Rito Noachita: L’Antico
Rito Noachita della Massoneria Universale è un polo iniziatico che tramanda i gradi e
gli insegnamenti connessi alla ierostoria di Noach (Noè) ed al tema dell’Arca della
Pace. Esso data alla metà circa del XVIII secolo, quando nei gradi addizionali della
Libera Muratoria prese stanza il mito Noachita, giungendo poi fino a noi sooto svariate
forme, nomi e filiazioni. L’A.R.N. si fonda sul culto del Supremo Patriarca dei Mondi
e sull’osservanza della Legge Morale che Egli ha scolpito nel cuore
dell’Universo. Pratica la venerazione dei padri Antichi e della Natura Primordiale;
nei suoi mistici riti ricorda l’Alleanza che l’Eterno ha stabilito con tutti i
viventi. Il sigillo dell’A.R.N. è costituito dall’Arca che naviga sulle acque
post-diluviane, vigilata dall’Occhio Divino inscritto nel Triangolo Luminoso, e
sovrastata da un Arcobaleno che percorre lo sfondo. L’A.R.N. è suddiviso in tre
gradi, simmetrici e complementari rispetto a quelli della Massoneria Azzurra. Essi sono:
1) Massone Illuminato o Fratello Verde, 2) Massone Sublime o Fratello Blu, 3) Real
Noachita o Fratello Rosso. L’A.R.N. ammette solo Maestri Massoni all’Obbedienza
di Grandi Logge Regolari (per il territorio italiano il G.O.I.), dei quali sia attestato
l’esemplare comportamento etico e muratorio. Citata la Premessa ed i primi tre
articoli dello Statuto Generale dell’A.R.N., risulta già evidente la caratteristica
essenziale della spiritualità e della procedura noachite. Questa rappresenta una
Massoneria del legno, e la base tradizionale di questa modalità costruttiva è il testo
biblico, nel quale la prima architettura di cui resta traccia è quella dell’Arca,
dettata a Noè dall’Eterno, in tutte le sue proporzioni e, significativamente,
secondo un modello tripartito. Rispetto alla pietra, il legno rappresenta un materiale
più sottile, più plastico, corrispondente ad un minor grado di solidificazione
dello Spirito; pertanto esso ha priorità ontologica rispetto alla pietra. Nel primo grado
il Noachita incontra la Natura Primordiale. In essa "ogni creatura è posta nel
luogo che le conviene, ed ogni azione è compiuta nel migliore dei modi. Tutto coopera ai
Piani dell’Eterno". Il neofita viaggia dall’Occidente all’Oriente,
quindi verso l’Alba (sul piano uranico) e l’entrata dell’Eden (sul piano
tellurico). Il Creato viene descritto come immerso in uno stato di estasi permanente, di
lode e di tremore: "I cieli narrano la Sua Gloria, il firmamento proclama
l’opera delle Sue Mani; gli alti monti che Egli ha plasmato dichiarano la Sua
potenza; gli uccelli del cielo cantano ad alta voce le Sue lodi, gli animali dei campi
tremano alla voce del Suo tuono, e tutte le Sue opere meravigliose rivelano la Sua
insuperabile saggezza". Nel rito dei quattro guadi, il Massone Illuminato
sperimenta a ritroso le tappe della discesa della Verità infinita nella dimensione
umana. "Come il Sacro Fiume si divide in quattro corsi che poi nuovamente si
uniscono, così la Verità, penetrata nella coscienza (simbolicamente situata alla base
del capo), scende nei centri sensoriali (simboleggiati dalle anche), nelle articolazioni
del movimento (simboleggiate dalle ginocchia) e nella stessa base della stazione eretta
tipica dell’uomo (le caviglie), per ricongiungere infine l’individuo alla
sorgente della Verità". Il rito commemora e prefigura la pienezza della
verità-coscienza, il tempo sacro in cui essa determinava e determinerà la vita biologica
e gli stessi meccanismi del mondo fisico: "trasformare il nostro chiarore
crepuscolare nella piena luce supermentale; instaurare la pace e la felicità senza
condizioni dove esiste solamente la tensione verso le soddisfazioni effimere, minacciate
dal dolore fisico e dalla sofferenza morale; fondare l’infinita libertà in un mondo
che ci appare come una costruzione di necessità meccaniche ; scoprire e realizzare la
vita immortale in un corpo sottoposto alla morte ed ai cambiamenti senza posa; ecco cosa
ci viene offerto quale scopo della Natura nella sua evoluzione terrestre" (da La
vita divina di Aurobindo). L’A.R.N., a prescindere dal linguaggio biblico di cui
fa abbondante uso, ha comunque carattere universale, poiché Noè sta molto a monte
dell’ebraismo mosaico. Inoltre egli, come Profeta di Dio, viene venerato, oltre che
nel Cristianesimo, anche nell’Islam, il cui testo sacro contiene una sura dedicata
proprio a Nuh. L’universalità del Rito trova riscontro nel vasto interesse
internazionale (Svizzera, Brasile e Stati Uniti) sollecitato dalla rivivificazione del
noachismo massonico italiano.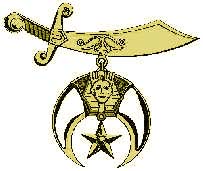 Antico Ordine
Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of
the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le
due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una
semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di
ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.
Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,
disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora
usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si
risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i
membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la
Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.
Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,
che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,
nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati
Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto
che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato
il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming
venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna
pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più
frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di
55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente
William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I
membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente
tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906
venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre
360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini
invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i
bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento
ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto
anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno
validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al
Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.
I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a
titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti
per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte
di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai
contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello
Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli
Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European
Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio
Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti
Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi
è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.
Antico Ordine
Arabo dei Nobili del Santuario Mistico del Nord America: È una corporazione paramassonica statunitense, ideata e creata a New York dai massoni Walter M. Fleming (un eminente medico) e William J. Florence (attore). Essi avevano in comune l’idea di una nuova Fratellanza riservata ai Liberi Muratori, in cui divertimento e buona compagnia venissero accentuati a scapito della ritualità. Il Fleming, che intorno al 1870 era una stella del palcoscenico, mentre i trovava a Marsiglia per uno spettacolo, veniva invitato ad una festa data da un diplomatico arabo. Il ricevimento consisteva in un’elaborata commedia musicale al cui termine gli ospiti diventavano membri di una società segreta. Era solo una specie di gioco, ma era condotto in modo tanto interessante da indurre Fleming a prendere molti appunti, che arricchì nel corso di altre due occasioni simili, cui partecipò ad Algeri ed al Cairo. Quando ebbe l’occasione di mostrare i suoi appunti al Dr. Fleming, questi ne fu tanto entusiasta da trasformare quelle idee embrionali in quello che sarebbe diventato l’Ancient Arabic Order of the Nobles of
the Mystic Shrine, l’A.A.O.N.M.S., una sigla che, anagrammata, dà stranamente le
due parole "A MASON", ovvero un Massone. Questa era forse ben più di una
semplice coincidenza. Con l’aiuto di Charles T. McCleanachan, avvocato ed esperto di
ritali massonici, di William S. Paterson, tipografo linguista e ritualista, di Albert L.
Rawson, un Massone studioso di tradizioni arabe, massonico, il Fleming redase il rituale,
disegnò gli emblemi ed i costumi rituali, formulò il saluto tra gli adepti (tuttora
usata, consistente in "Es Salamu Aleikum", la pace sia con te, cui si
risponde "Aleikum Es Selamu", con te sia la pace) e dichiarò che tutti i
membri avrebbero portato un fez rosso. Come gioiello dell’Ordine venne adottata la
Mezzaluna, con il motto arabo "Kuwat wa Ghadab", ovvero Forza e Furia.
Oggi l’emblema dello Shrine include una scimitarra dalla quale pende una Mezzaluna,
che sostiene la testa di una sfinge ed una stella a cinque punte. Il 26 settembre 1872,
nella Casa Massonica di New York City, venne inaugurato il primo Tempio Shrine degli Stati
Uniti, denominato Mecca. L’organizzazione non riscosse un successo immediato, visto
che quattro anni dopo contava un totale di soli quarantatre membri. Nel 1876 venne creato
il Corpo governante, denominato Gran Concilio Imperiale dell’A.A.O.N.M.S., Fleming
venne eletto primo Grand Imperial Potentate e venne avviata una campagna
pubblicitaria e di reclutamento. Le sue opere filantropiche divennero sempre più
frequenti. Nella Sessione Imperiale del 1900, rappresentanti di ottantadue Templi e di
55.000 Shriners sfilarono in parata a Washington, passati in rivista dal Presidente
William McKinley. Da allora il fenomeno Shrine fu inarrestabile nella sua espansione. I
membri ed i Templi si moltiplicarono, nuovi ornamenti vennero aggiunti ad una crescente
tradizione già ricca di fasto, e vennero formate nuove bande musicali. A partire dal 1906
venivano creati i primi circhi dello Shrine. Nel 1919 i membri ammontavano già ad oltre
360.000, e nel giugno 1922 venne fondato il primo ospedale dello shrine per bambini
invalidi, con un regolamento esteso agli ospedali fondati in seguito secondo il quale "i
bambini dovevano provenire da famiglie incapaci di sostenere le spese del trattamento
ortpedico, dovevano essre inferiori ai quattordici anni (limite poi portato a diciotto
anni), ed essere in condizione, a giudizio dei medici, di poìter essere curato od almeno
validamente aiutati". La gestione della grande rete ospedaliera è affidata al
Consiglio dei Curatori degli Ospedali dello Shrine per Bambini Storpi, eletto annualmente.
I bambini vengono accettati senza alcuna distinzione di razza, religione e nazionalità, a
titolo gratuito per loro e per chi li accompagna. Gli ospedali ortopedici e gli Istituti
per grandi ustionati sono finanziati da un’autotassazione annua pro capite da parte
di ogni membro, dalle attività per la raccolta di fondi dei numerosi Templi, dai
contributi e dai lasciti dei membri o di simpatizzanti. Si calcola che oggi i membri dello
Shrine ammontino ad oltre un milione, distribuiti in circa duecento Templi operanti negli
Stati Uniti, in Canada, nel Messico ed in Europa, Qui è operativo dal 1950 un European
Shrine Club (E.S.C.), costituito dapprima a Wiesbaden con la sponsorizzazione del Tempio
Aahmes, poi ad Heidelberg con il Tempio Moslah. L’E.S.C. comprende oggi circa venti
Oasi, tra cui il N.I.S.O., ovvero il North Italy Shrine Oasis con sede a Milano. Ogni Oasi
è retta da un Presidente, ed ogni Tempio da un Imperial Potentate.